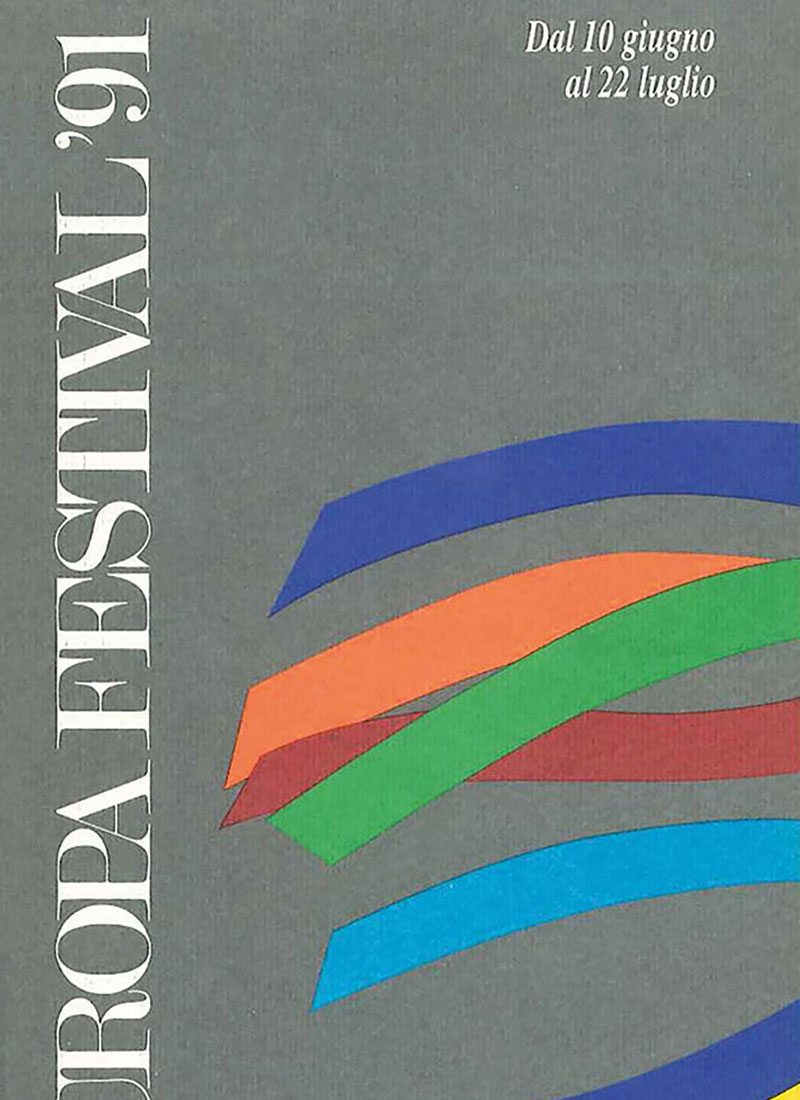“Un viaggio onirico nello spazio e nel sogno, una successione di immagini e di simboli che si compongono in un certo ordine, giustapponendo diverse culture: orientale, europea, mediterranea. Artemide scende sulla terra con il desiderio di essere qualcosa di diverso da quello che è”, precisa Lydia Azzopardi. Linea guida della coreografia di Cesc Gelabert e Lydia Azzopardi, alla loro quinta creazione in questo 1991, è proprio la figura di Artemide, la dea figlia di Leto e Zeus, sorella gemella di Apollo, venerata da cacciatori e arcieri, seppure protettrice degli animali selvaggi. Nel lavoro della compagnia, la dea diventa l’elemento attraverso cui investigare l’interrogativo sull’identitĂ , e la coreografia, imperniata sul tema della predestinazione propria di ogni essere, elabora l’idea di un destino ineluttabile che si muove attraverso tempi, luoghi e radici molteplici.
I due coreografi hanno tradotto questa grande ed immensa domanda in un’immagine ricca e densa di echi musicali ed iconografici provenienti dalle loro molte culture di appartenenza.
“Il tempo ed il luogo sono le linee orizzontali, la cultura e i contrasti sono le verticali”, sentenzia Azzopardi.
Coreografia e Direzione Cesc Gelabert e Lydia Azzopardi
Musica Javier Navarrete, Maurici Villavecchia
Scenografia Thomas Pupkiewicz
Progetto Luci Cesc Gelabert
Costumi Lesile Languish
Corpo di Ballo Amparo Pla, Lydia Azzopardi, Luis Cancillo, Cesc Gelabert, Toni Gomez, Toni Jodar, Carme MartĂ, Alicia PĂŠrez-Cabrero, Carme Renalias, Miguel VĂĄzquez, Catalina Villana
Assistente alla Coreografia Toni Jodar
Grafica Pere Canals
Fotografia Ros Ribas
Realizzazione dei Costumi Teatro Lliure, Toni Langa
Realizzazione della Scenografia Thomas Pupkiewicz, Pere Adell (Durpo SA)
Tecnico Luci Mingo Albir
Macchinista Guille GĂłngora
Amministrazione Lourdes EspaĂąol
Assistente alla Produzione Cecilia Francesch
Segreteria Elisabeth EspaĂąol
Produzione Beatriu Daniel
Distribuzione Gelabert-Azzopardi, Fagot, Gerencia Cultural
Co-produzione Centro Culturale de Bayonne et du Sud-Aquitain, terzo Festival de Tardor-Olimpiada Cultural (Barcelona), Teatre Lliure, Gelabert-Azzopardi Companya de Dansa, con la collaborazione della “Consejeria del Gobierno Vasco (Eiuskadi a Escena).
Con la collaborazione del Festival di Danza del Comune di Castelldefels.
Con l’accordo del Ministero della cultura (I.N.A.E.M.).
Con la sovvenzione del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
IL BAILE INNANZITUTTO
di Elsa Airoldi
Questa volta la storia ce l’ha messa proprio tutta. Solo s’è permessa di distrarsi, di prendere sotto gamba quel “particulare” che è la trovata del pensiero di Guicciardini. Insomma non ha fatto i conti con l’hispanidad: orgoglio che non cede, non arretra, non demorde. CosĂŹ, se da un lato, pur davanti all’evidenza di apporti arabi e indiani piuttosto che ebraici o persiani, molti preferiscono credere alla totale autonomia culturale spagnola, e se addirittura il musicologo Felipe Pedrell, analizzando l’enigmatico cante hondo, suggerisce l’idea dei mori che attingono dalla Spagna e non giĂ di quest’ultima che ne subisce l’influenza, noi, che oggi parliamo di danza, ci troviamo a osservare come il baile della piazza abbia sempre prevaricato ogni diversa espressione del genere.
La storia, che non voleva escludere la penisola iberica dal gioco di scambi che ha connotato l’Europa, ha provveduto a dare madri e mogli spagnole a Luigi XIV di Francia; a consegnare due spose italiane a Filippo V di Spagna; a insediare nell’Escurial un Carlo III che arrivava dall’Italia. Il che avrebbe dovuto significare una linea comune di danza colta (quella accademica) parallela alle relative etnie rimaste appannaggio del popolo.
A fasti e amori dei coronati, in buona parte riferita a essi, è dovuta poi la presenza nel paese di personaggi specificamente legati alla storia evolutiva del balletto. Salvatore Viganò, grande innovatore napoletano di origine reggiana, arrivato a Madrid per l’incoronazione di Carlo IV, vi trova moglie (la mitica Maria Medina) ed il maestro, il “riformatore” Jean Dauberval. PiĂš tardi, a formalizzazione accademica ampiamente avvenuta e anzi in procinto di sgretolarsi, vediamo vagare per le pianure mancheghe Marius Petipa. Insomma per la Spagna ci passarono tutti, ma nessuno riuscĂŹ a intaccare un folclore che ancora oggi pare avere la meglio su ogni altra realtĂ .
Le ali di elfi e silfidi divennero mantiglie, il morbido ballon dei principi violenza di zapateado, il candore dei tutĂš trionfo di balze e frange. Nacque l’affascinante ibrido chiamato “scuola bolera”. Quando in fine, ansanti, approdarono alla ribalta alcuni balletti “spagnoli”, tutto era perfettamente ispanico: dalla musica di Manuel de Falla, al libretto di GarcĂa Lorca, al tipo di satira sociale, al rito del fuoco e degli incantamenti. Ă ben vero che anche l’opera, o il repertorio cameristico e sinfonico, una volta allontanatisi dalla culla d’origine si tinsero delle peculiaritĂ dei nuovi paesi di migrazione. Ma crediamo che in nessun caso gli apporti estranei abbiano subito un simile processo di personalizzazione.
Nella Spagna di oggi esistono fior di scuole accademiche. Ma non riescono a convincere; nemmeno quando si chiamano Ballet del Teatro LirĂco Nacional diretto da Maja Plissetskaja, il fiore all’occhiello della ufficialitĂ classica facente capo al Teatro Lirico della Zarzuela; l’altra faccia del Ballet Nacional de EspaĂąa di JosĂŠ Antonio dedito al baile.
Nemmeno quando, preceduta da impressionante battage, arriva a Spoleto una Maria Esturdo che fa vaneggiare la stella sovietica Maja sotto la bacchetta delle coreografie di JosĂŠ Granero. I ballerini spagnoli dediti al classico insomma non sono convinti di quello che fanno. Non lo sentono. Qualcuno in effetti è riuscito ad accettare la stilizzazione edonistica dell’accademia. Ma appena ha potuto non ha esitato a cercare respiro in quelle strutture che utilizzano il classico per dire cose concrete, per trasformarlo in violenza espressiva. Victor Ullate è stato a lungo con BĂŠjart. Ana Laguna e MarĂa Bianco hanno sposato il grido di Birgit Cullberg; Nazareth Panadero la lacerazione esistenziale di Pina Bausch. Quasi una questione di pelle.
La Spagna non vuole accettare gli intellettualismi costretti e indubbiamente restrittivi di casa ovunque, nel vecchio come nel nuovo mondo, vittoriosi persino dell’italico individualismo. Parliamo di un paese passionale che si identifica nelle sue liturgie. Nella tauromachia, per esempio, la festa dei tori. Una sorta di messa dove si adora e si sacrifica al dio e dove l’officiante, l’uomo in lotta con la bestia, obbedisce a un calligrafismo gestuale assai vicino a quello che regola il baile.
In arena come nella cueva gitana si celebrano le categorie dell’assoluto: bellezza, gioventĂš, grazia, eroismo, onore, amore. E Lorca, che ha cantato il toro e Ignacio, come avrebbe potuto, in un’altra terra, dire i simboli scarnificati di un’infanzia trascorsa nella campagna granadina? Come il sole, la luna, il cristallo, il Guadalquivir delle stelle? Dove se non qui avrebbe potuto nascere la violenza luministica di ZurbarĂĄn, la visionarietĂ di El Greco, l’allucinazione di Goya, la radicalitĂ goticheggiante del GaudĂ?
In questa terra assoluta e assolata pare esserci spazio solo per il sentire. Un sentire forte, che si esprime a tutto tondo. Finora era stato lo straziante e fatale vocalizzo hondo. Adesso si affaccia un sentimento piĂš universalizzato, che racconta ancora la sua terra ma con parole raccolte affannosamente in tutti i centri disponibili sparsi nel mondo.
Ă una Spagna nuova che si cerca per trovarsi: senza la rassegnazione fatale di sempre. L’epicentro del terremoto ancora timido e in molti casi ancora malato di hispanidad è la Catalogna, in particolare Barcellona. Ă lĂŹ che sul finire degli anni Settanta Anna Maleras apre il primo centro di danza jazz e moderna, invita coreografi stranieri e forgia i primi allievi: Francesco Bravo, Cesc Gelabert, Avelina ArgĂźelles. LĂŹ nascono i primi gruppi, come l’Espantall (1977) e la Heura (1979), giĂ ora cancellati da una mappa appena tracciata dove le strade sono solo abbozzate e non conoscono futuro e destinazione.
I nuovi cercatori di Dio vanno in Europa, in America e poi tornano. Si uniscono e disgregano. Qualcuno ha piĂš fortuna, o parla piĂš forte. Come Cesc Gelabert che, di ritorno dagli Stati Uniti, costituisce una compagnia con Lydia Azzopardi, artista di nazionalitĂ inglese che insegna all’Istituto del Teatro di Barcellona (uno degli spazi piĂš importanti accanto a La Fabrica e a BĂźgĂŠ). La Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi Companya de Dansa debutta nell’86 con Desfigurat per realizzare poco dopo una versione del Requiem di Verdi.
Ă grido, trasgressione, denuncia. La violenza allucinata non è troppo lontana da quella provocata da un altro gruppo catalano, La Fura dels Baus, il “topo del baus”, il torrente che passa per il quartiere barcellonese di MoĂa. Il 1983 assiste, sempre a Barcellona, alla nascita di lavori fondamentali: Casc InsĂłlit di Nuria Olive, Duna di Angels Margarit, Avui dimars i demĂĄ dimecres di Avelina ArgĂźelles. I nomi si moltiplicano e le compagnie proliferano. Arrivano anche i primi riconoscimenti internazionali spesso sanciti da festival francesi.
Fino a oggi l’unica rassegna dedicata alla Spagna nella sua totalitĂ coreografica, dalla Plissetskaja a JosĂŠ Antonio attraverso vari saggi di sperimentazione, è stata promossa da Reggio Emilia nell’88. Ă in quell’ambito, Bailar EspaĂąa, che il nostro pubblico può avvicinare Mudances della Margarit, Bocanada Danza di Blanca Calvo e MarĂa JosĂŠ Ribot, la CompaĂąia de Dansa di Carmen Senra o la Herencia Dux di Maria MuĂąoz e MarĂa Antonia Oliver Ribas. Si parlano tutte le lingue, con arte piĂš o meno matura. E in fondo si sente sempre, ancora, la Spagna.
Rassegna stampa
“I brevi quadri che si susseguono partono dai ritmi melensi e rarefatti degli assoli, fino ad arrivare a frenetiche danze di improbabili figli degli anni ’70, con tanto di parrucconi riccioluti e gonne svolazzanti, il tutto all’insegna del piĂš puro Kitsch. Nella seconda parte, sicuramente piĂš armonica, i danzatori preparano lentamente i pezzi delle sculture sparsi per il palcoscenico, per rimetterli insieme e per formare un gigantesco piede, sul quale gli interpreti con una certa dose di autoironia si rotolano sopra, o fanno capolino da una apertura del gigantesco arto che non è stata ancora coperta”.
(Sandra Cesarale, Artemide sogna, il pubblico no, Qui giovani, 1991)
“Non basta dunque richiamarsi al presunto caos di un sogno (e comunque dall’arte si pretendono strutture solide a sostegno dell’astrazione) per giustificare il puzzle sconnesso di immagini e di brevi quadri che (s)compongono questo Sogno di Artemide. Assoli rarefatti nella penombra si alternano a spezzoni d’insieme colorati all’Almodovar, in cui personaggi dalla parrucca riccioluta e camicia a volants modello “Trastevere bieco” o vestiti in un chiassoso revival anni ’70 si dimenano qua e lĂ con qualche palpito flamenco. Un continuo fuori tema che recupera terreno nella seconda parte, piĂš organica”.
(R.B., Il sogno-sonno di Artemide a Villa Medici, l’UnitĂ , 26 luglio 1991)
“Su una chitarra e una scena inondata di luce Cesc esegue un superbo assolo. I ritmi serrati diventano melodia e gioco di bambini blu. Il jazz e la disco music fanno esplodere un party plurietnico. Alla divisa degli euzones fa riscontro il velo rosso della sposa turca che scivola su coturni da tragedia greca e lancia un grido roco scoprendosi il seno. La prima parte è sviluppata su un piano verticale ed è colorata. La seconda è orizzontale e nera “.
(Elsa Airoldi, Il lungo”Sogno” di Artemide, Il Giornale nuovo, 26 luglio 1991)