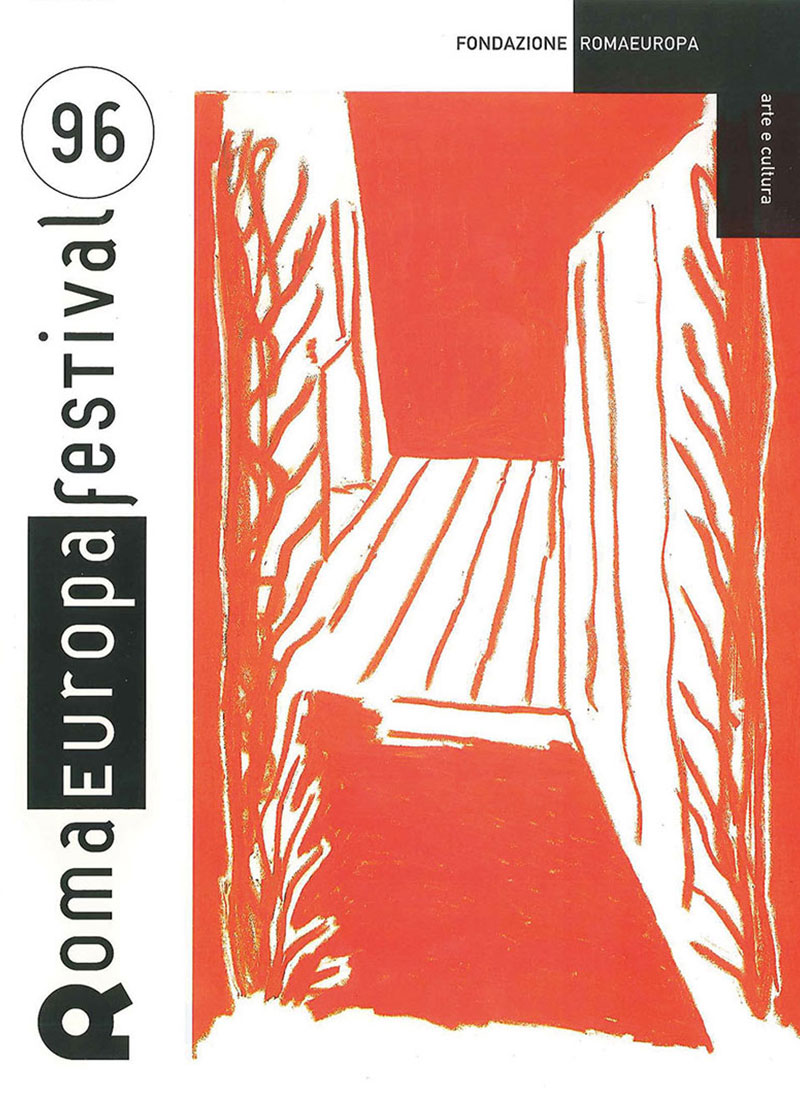La vetta del Parnaso
“Martha”: un ricordo SATYRIC FESTIVAL SONG (1932)
Musica Fernando Palacios
Ricostruzione Diane Gray, Janet Eilber
DEEP SONG (1937)
Musica Henry Cowell
MAPLE LEAF RAG (1990)
Musica Scott Joplin
Arrangiamenti Chris Landriau
Pianoforte Donald Berman
CAVE OF THE HEART (1946)
Musica Samuel Barber
CHRONICLE (1936, estratti: Spectre-1914, Steps in the Street, Prelude to Action)
Musica Wallingford Riegger
Arrangiamenti (Spectre-1914, Prelude to Action) Stanley Sussman
Ensemble Martha Graham Dance Company
Costumi Martha Graham, Donna Karan, Calvin Klein
Luci David Finley, Jean Rosenthal, Steven W. Shelley
Direzione artistica Ronald Protas
Direzione generale Douglas H. Mau
Scenografia Isamu Noguchi
Danzatori Takako Asakawa, Elizabeth Auclair, Kevin Boseman, Terese Capucilli (solista), Katherine Crockett, Christine Dakin (solista), Donlin Foreman, Gary Galbraith, Sandra Kaufmann, Martin Lofsnes, Peter London, Krisha Marcano, Virginie Mécène, Rika Okamoto (solista), Miki Orihara, Alexandre Proia, Alessandra Prosperi, Peter Roël, Matthew Rose, Fang-Yi Sheu, Amanda Thomas, Stepahanie Tooman
Un omaggio ad una delle personalitĂ piĂą eminenti della danza del Novecento da parte della compagnia newyorkese che ella stessa ha fondato e che porta il suo nome, la Martha Graham Dance Company: cinque coreografie, da Satyric Festival Song, del 1932 a Maple Leaf Rag, del 1990, per rivivere alcuni dei momenti maggiormente significativi dell’opera di un’artista che ha rappresentato un imprescindibile punto di riferimento per le generazioni a venire e il cui magistero rimane tuttora intatto. La storia, il mito classico, ma anche l’impegno sociale e politico percorrono questi lavori conferendo loro uno spessore che va al di lĂ della pura ricerca formale: basterebbe pensare a Deep Song, scritto dalla Graham durante la guerra civile spagnola, o alla denuncia degli orrori di ogni conflitto in Chronicle, di cui vengono presentati tre brani grazie al paziente lavoro di documentazione storica e ricostruzione delle coreografie originarie compiuto da Carol Fried, Terese Capucilli, Diane Gray e dallo stesso Ronald Protas. Cave of the Heart rilegge d’altra parte il mito di Medea, in un allestimento in cui un ruolo determinante è giocato dalle sculture di Isamu Noguchi, mentre Maple Leaf Rag, costruito su un ragtime di Scott Joplin, è l’opera, leggera e briosa con cui la Graham, all’incredibile etĂ di 97 anni, ha scelto di congedarsi dal suo pubblico.
“MARTHA”: UN RICORDO
di Vittoria Ottolenghi
“Martha” : così voleva essere chiamata dagli amici, piuttosto che col gelido “Miss Graham” o, peggio, con l’odiatissimo “Miss Martha”.
A cinque anni dalla morte, proviamo a ripensarla, ad analizzarne il fascino e a valutarne l’importanza, uscendo da una generica devozione. Anche perchĂ©, se non la “fissiamo” in qualche modo, la sua ombra si farĂ sempre piĂą imponente nella dimensione della memoria, ma sempre piĂą indistinta – come è accaduto per le ombre di tanti “Grandi”, anche quelli che, come lei, morirono in piedi e meravigliosamente sulla breccia.
Era diventata piĂą bella – nonchĂ© divinamente elegante – andando avanti negli anni. Da giovane, a giudicare dalle foto, era, senza dubbio, molto “racĂ©e”, figlia di “gente bene”, della buona borghesia provinciale americana, a cavallo tra i due secoli. E aveva gli occhi luminosi, il volto intelligente e un corpo espressivo, quando esordì con Ruth St. Denis e suo marito Ted Shawn. Ma, certo, non era bella, o sexy, o fascinosa, almeno secondo i canoni prevalenti all’epoca del cinema muto, quando cominciò a lavorare in proprio. Aveva il volto troppo lungo e sottile e l’espressione sempre un po’ troppo tesa e aggressiva. Poi, però, negli anni Sessanta, una volta entrata trionfalmente nella terza etĂ – e ormai carica di onori e di allori, dopo anni di lotte e di amarezze – il suo volto aveva cominciato ad assumere una luce dorata, quasi superumana. E gli occhi erano diventati quelli – sereni e arguti – di una qualche antica ed esotica divinitĂ . Per di piĂą, la dimestichezza con i lunghi pepli greci di tante coreografie mitologiche – adesso mitiche – e soprattutto con il grande stilista americano Halston (fu lei la prima coreografa, in senso assoluto, a stimolare la metamorfosi di uno stilista in costumista per la danza), sta alle origini della sua trasformazione nella Gran Signora della Danza e dell’Immagine Femminile: il famoso “Mito Vivente”.
Scelse di indossare, piĂą o meno sempre, abiti dello stesso modello – semplicissimo, quasi monacale: una tunica accollata e lunga fino ai piedi e grandi maniche, fino a coprire anche le mani (ben presto tormentate dall’artrite). Ma il risvolto teatrale del suo modo di apparire era il taglio, fantastico, degli abiti, e la scelta del tessuto, sempre ricchissimo, tutto d’oro e d’argento, in paillette o materiali intessuti di fili lucenti. Come dire, un saio, ma tagliato da Dior e con rifiniture di Bulgari.
Io la conobbi, per la prima volta, quando aveva circa ottant’anni e mi sembrò un’antica imperatrice della Cina – signora d’un mondo perduto, meraviglioso e terribile. Parlava piano, con voce soffice e calma, a un gruppo di critici di danza, sul palcoscenico del Teatro Ateneo. Eravamo tutti molto emozionati, ma anche spiazzati. PerchĂ© con quella voce sapiente e aristocratica, “Martha” parlava “come si mangia”: diceva cose semplici, familiari, confidenziali. Parlava di come, per anni, aveva fatto di tutto, anche le pulizie per terra, per continuare ad esistere e a danzare. Raccontava le piccole e grandi avventure della sua vita d’artista, liberamente mescolate alla cronaca familiare, alle faccende quotidiane.
Nei suoi ultimi anni, quando ancora l’ingegno era vivissimo, ma le sue forze e le sue capacitĂ fisiche di movimento erano minime, i suoi assistenti e collaboratori – capeggiati dal grande amico e formidabile collaboratore, Ron Protas – la sostenevano in ogni sua attivitĂ , intellettuale o fisica, insieme la proteggevano da ogni fastidio o intrusione da parte degli estranei. Tuttavia, ebbi la fortuna di essere convocata direttamente, un paio di volte, per una conversazione a due, rilassata e informale. E fu così che mi resi conto da vicino della sua assoluta eccezionalitĂ , rispetto anche ai maggiori coreografi americani, uomini o donne, che avevo conosciuto. Il fatto è che “Martha” non era affatto spaccata in due o in qualche modo dilaniata da due anime diverse – quella della danza e quella di “tutto il resto”. Era fatta di un unico impasto, in cui la danza – il lavoro in generale, creativo o no – era parte integrante della vita quotidiana, delle idee e degli affetti. Il suo racconto dell’albero che le cresceva in casa – a dispetto di tutti e di tutto – tra le gambe del pianoforte, nell’unica sala della sua scuola, era insieme un delizioso racconto di vita urbana e una poetica metafora della sua missione di artista e di insegnante.
Insomma, era, in molti sensi, tutto quello che molte di noi avremmo desiderato di essere e non riusciremo mai nemmeno a intravedere da lontano.
(in Catalogo Romaeuropa Festival 1996)
Rassegna stampa
“Nonostante l’attuale compagnia presenti vistose debolezze tecniche, specie nelle file maschili – con l’eccezione, naturalmente, delle due ultime formidabili interpreti rimaste, Terese Capucilli e Christine Dakin – il programma testimonia magnificamente l’assoluta originalitĂ del linguaggio grahamiano e l’affascinante complessitĂ del suo mondo poetico.
Nei primi assoli il vocabolario è elementare e anzi si intravede quasi uno sforzo a mantenerlo tale per non cedere alle potenti influenze del passato. Passando per l’ironia evocativa di Maple Leaf Rag e la maturitĂ formale di Cave of the Heart si giunge alla stupefacente catena di invenzioni di Chronicle: dalle folgoranti schegge di Spectre-1914 nelle quali riaffiora l’immagine di Ruth St. Denis, arcano scrigno a partire dal quale la personalitĂ della geniale allieva si rivela come il filo di seta dal bozzolo, fino alle travolgenti ondate dinamiche di Prologue to Action, passando per il denso nucleo drammatico di Steps in the Street“.
(Donatella Bertozzi, “Radical Graham” il ritorno alle origini, Il Messaggero, 17 luglio 1996)
“Balanchine disse di lei che ha ricreato la tecnica classica. Ed è vero. Sono assai rare le compagnie di danza dotate di eguale maestria. L’assolo titolato Satyric Festival del 1932 era improntato a una freschezza piĂą che moderna. L’interprete era Rika Okamoto, anche il costume era della Graham. Seguiva Deep Song del ’37, un brano coinvolgente a livello intellettuale. Un racconto impressionante di torture, eseguito da Christine Dakin con la passione dell’autentica guerrigliera spagnola. Non tutti conoscono la Graham “partigiana” dei perseguitati e dei sofferenti – lei così elegante, apparentemente distaccata, era invece intensamente “impegnata” – come si è visto poco dopo, nella esaltante serie nata negli anni di guerra. Scena tratte da Chronicle: Spectre-1914, popolato da suoni di tamburi e da lamenti. Steps in the Street e Prelude to Action, episodi di danza collettiva, animati da una forza altrettanto emotiva quanto (incredibilmente) attuale. Il genio della Graham insegna come non esista tramonto per chi ha la pancia piena di idee. Favolosa Graham”.
(Mya Tannenbaum, Anche Martha Graham sorride, Corriere della Sera, 17 luglio 1996)
“Le coreografie di Graham diventano archetipi stilistici ma anche manifesti di un’aderenza alla realtĂ umana e, per questo, universali. Il segreto di un classico, in fondo, consiste proprio nel diventare immortale trattando di cose mortali…
La Martha Graham Dance Company ce lo ricorda in una serata non impeccabile (il corpo maschile dei danzatori non è sempre all’altezza del compito di perpetrare memorie storiche), ma ricca di storia. Con uno spruzzo di effervescenza: quel Maple Leaf Rag, che Martha creò nel 1990 come una fluttuante e autoironica miscellanea delle sue creazioni. Uno sguardo retrospettivo, che proprio per essere alla fine di una lunghissima strada di impegno tenace e di meditati passi, si permette di essere, per una volta, sbarazzino”.
(Rossella Battisti, “Radical Martha” e gli archetipi della perfezione, l’UnitĂ , 19 luglio 1996)
LA VETTA DEL PARNASO
di Vittoria Ottolenghi
Le vecchie e le giovani Dame e i rari Cavalieri della “modern dance” americana – ma anche della danza contemporanea europea – sono tutti nipotini di Martha Graham. PerchĂ© tutti l’hanno, magari devotamente, imitata. I migliori sono riusciti a portare avanti una delle tante vie, che lei ha aperto alla danza del nostro tempo.
Che donna.
Ripensiamo all’Europa ballettistica del primo Novecento, improvvisamente sconvolta e spiazzata dalla “rivoluzione” della bella visionaria Isadora Duncan. E ripensiamo agli Stati Uniti, piĂą o meno nello stesso periodo, eppoi fino a tutti gli anni Venti e Trenta, dove anche l’esotica, ieratica Ruth St. Denis giĂ danzava senza alcun riferimento al balletto classico. Ebbene, ambedue queste straordinarie danzatrici non erano però realmente capaci di elaborare un “codice” e quindi di trasmettere la loro nuova danza ai discepoli. La rivoluzione sarebbe forse finita con loro, se Martha Graham non avesse preso su di sĂ© l’incarico di raccogliere il loro “verbo”, di arricchirlo con la sua personale, immensa capacitĂ creativa, e soprattutto di codificarlo in maniera chiara e leggibile. “Martha”, insomma, elaborò un metodo: il metodo Graham, appunto.
La base del metodo era, come per Isadora, la “libertĂ ” dalle cinque posizioni e dai passi prefissati del balletto classico. Niente scarpette “da punta”, ma piedi nudi o guantati. Niente tutĂą, niente coroncina in testa, ma tuniche sciolte o ampi abiti senza tempo. Su questo innalzò la salda, originale costruzione della sua tecnica “moderna”, basata su principi chiari e geniali: “contraction and release”, “fall and recovery” e ogni altra sequenza dinamica che permettesse alla danza di respirare con gli interpreti e tra gli interpreti, e di porsi come equilibrio tra forze libere, anche se uguali e contrarie. In teatro, via le musiche ottocentesche: bisognava usare soltanto musiche e scenografie della nostra epoca, che riflettessero la moderna condizione umana – in particolare la persistente condizione di servaggio della donna. “Martha” fece, della sua nuova danza, anche un poderoso manifesto femminista e, piĂą in generale, un manifesto per la liberazione, di donne e uomini, dalla paura, dalla violenza, dalla prevaricazione.
Di fronte al fenomeno Graham, una certa critica “giovane”, per così dire, e alcuni ballettomani vecchio stile, pensarono, una ventina d’anni fa, di costruire una sorta di “aut aut”, tra danza moderna e balletto classico. Volevano costringere la gente, con sprezzante alterigia giovanile o senile, al sinistro gioco della torre: “O Giselle, o Clitennestra”, insomma. O anche: “E chi non è con noi, peste lo colga”.
Per fortuna, i piĂą si sono sempre tenuti stretti l’uno e l’altro “linguaggio” – ambedue “contemporanei”, naturalmente, dal momento che sono tuttora usati, o “parlati”, o manipolati, o trasformati, o estesi, in maniera sempre nuova. Oggi, finalmente, siamo addirittura al di lĂ della coesistenza pacifica. C’è, tra i due stili, un intenso rapporto dialettico. Alla School of American Ballet, la scuola del New York City Ballet fondata da Gorge Balanchine, il re del balletto classico di ogni tempo, si insegna anche il metodo Graham. E nel tempio della danza moderna – la scuola di Martha Graham a New York – è ormai consuetudine fare anche “la sbarra”, che è la base della tecnica classica. E così il ballerino di oggi è sempre piĂą spesso preparato a danzare in ambedue gli stili principali. E in tutti quegli altri stili con cui – ormai con vera libertĂ – i coreografi e i ballerini scelgono di confrontarsi, di guardarsi negli occhi e, in piena letizia, di scambiarsi idee ed emozioni.
Il programma romano di questa compagnia, che è vitalissima, eppure “storica”, comprende cinque lavori. Due sono in prima italiana: Satyric Festival Song, una recentissima ricostruzione di Diane Gray e Janet Eiber, dall’originale del 1932 (e di cui non sappiamo ancora nulla); e Chronicle, analogo recupero di un originale del 1936. Insieme con Chronicle, anche Deep Song (del 1937, in apertura di serata) è un esempio della passione civile e ideologica che ha sempre animato la danza di Martha Graham. “Martha” ha sempre sentito profondamente l’impegno, non soltanto di testimone del proprio tempo, ma anche e soprattutto di combattente – sul suo terreno – per quello che riteneva l’idea giusta. Ed è sempre stata un’idea di libertĂ , di dignitĂ , di apertura mentale. Nell’interpretazione, in alternanza, di due tra le massime interpreti, e giĂ strette collaboratrici, della Graham – Christine Dakin e Terese Capucilli – questo Deep Song o “Canto profondo” (un’evocazione analogica del flamenco, o Cante hondo) si propone di esprimere il grido di dolore e di rivolta delle donne di Spagna. E non solo il loro: Deep Song ha, infatti, una sua vocazione supernazionale e intende farsi espressione della sofferenza umana in generale – quella di tutti i popoli che tuttora affrontano situazioni simili a quelle della Spagna di quegli anni. Chronicle, animato da poderose passioni sociali, chiude la serata ed è la ricostruzione di tre diversi “frammenti” coreografici: Spectre, originariamente del 1914, creato da Carol Fried e Terese Capucilli sulla base di spezzoni di film e delle foto di Barbara Morgan; Steps in the street che era stato giĂ ricostruito dalla stessa Graham e da Yuriko, sulla traccia del film di Julien Bryan; Prelude to action, ricostruito da Sophie Maslow, con la collaborazione di Terese Capucilli, Carol Fried, Diane Gray e Ron Protas, sempre sulla base di spezzoni di film e delle foto di Barbara Morgan.
RenĂ© Sirvin, l’autorevole critico francese del “Figaro”, dopo la prima europea di questo “frammento”, a Creteil, nel dicembre scorso, ha parlato di un “capolavoro espressionista di straordinaria forza drammatica, impressionante per le immense gonne dagli effetti spettacolari in rosso e nero, e le sue dodici donne, cupe e determinate, attorno alla protagonista”. E RaphaĂ«l de Gubernatis, su “Le Nouvel Observateur”, conclude: “Chronicle disegna, in maniera allucinata, i tormenti della guerra, la rovina spirituale che devasta la nazione. Con la sua gestualitĂ lirica, deliberata, potente, virile, in questo lavoro di amazzone, dove tutto è eroico, c’è una gran forza “rabbiosa”: è la forza di chi è convinto di essere nel giusto”.
Ben noti ci sono i due capolavori che completano la serata e che sono di vocazione opposta: il tragico, viscerale Cave of the Heart (del 1946), sul mito di Medea, e l’allegro, lieve, animatissimo Maple Leaf Rag, sul celebre, omonimo rag di Scott Joplin. Sulla musica di Samuel Barber, Cave of the Heart (“La caverna del cuore”, o magari, “L’antro in fondo al cuore”) ci seduce innanzitutto per il genio della sintesi, che Martha Graham possiede: un gesto, un passo, ed è giĂ mito, giĂ momento eterno, giĂ evocazione di uno, dieci, cento possibili significati in cui identificarsi, o con cui confrontarsi. Eppoi, c’è quasi una magia teatrale, l’dea – maturata con il grande scultore giapponese Isamu Noguchi – di creare per ciascun personaggio un elemento scenografico “da indossare” – come una sorta di casa essenziale, a volte come prigione. Una struttura solida e salda, quasi un costume, insomma, che trattiene, contiene, frena, protegge. Oppure stringe, tortura, impedisce la vita, il respiro stesso. Medea, chiusa in questa sua casa-prigione-guaina d’argento, vive il suo destino di dolore e di morte, da cui non può comunque fuggire, con la nobiltĂ di una regina. Così come, molti anni dopo, nel 1958, farĂ anche la sua Clitennestra.
Con l’allegro Maple Leaf Rag, il suo ultimo lavoro, la Graham – che era stata definita “Martha senza sorriso”, per la serietĂ appassionata delle sue motivazioni e della sua ispirazione – ha voluto congedarsi da noi proprio con un sorriso, nell’ottobre del 1990, sette mesi prima di morire, a 97 anni. Racconta, in un’atmosfera radiosa, e con un pizzico di sorridente malinconia, i giorni della primavera, dei sentimenti incorrotti, dei casti giochi d’amore tra adolescenti, sullo sfondo di un’aia campagnola. E quanta amabile, arguta presa in giro di se stessa, ella ci mostra, quando le danze felici, “volate” e “saltate”, dei ragazzi in calza maglia, sono interrotte dal passaggio ricorrente di una giovane alta, magra, solenne, tutta avvolta in lunghe e immense gonne avvolgenti. Una giovane fiera e concentrata, che somiglia come una goccia d’acqua alla giovane Martha, quando, nel 1929, cominciò la sua meravigliosa e solitaria ascesa verso la vetta del Parnaso.
(in Catalogo Romaeuropa Festival 1996)