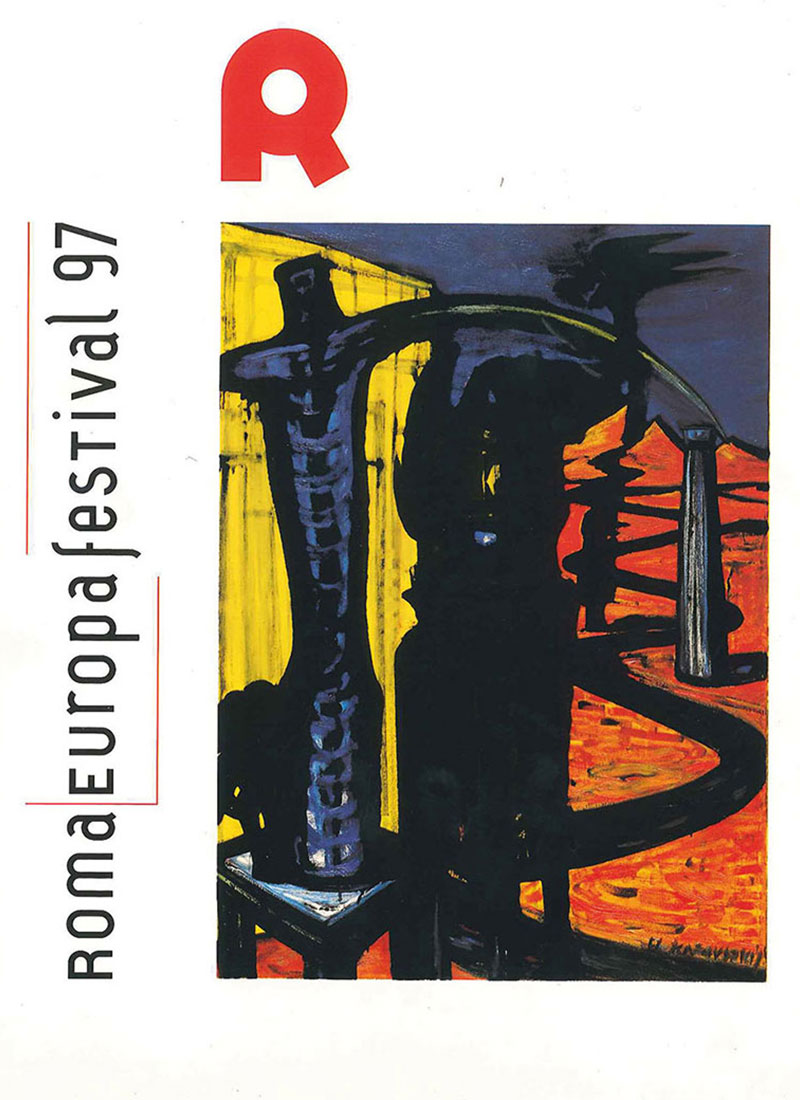La sofferenza del ritorno
Intervista a Lepage
Testo e regia Robert Lepage (con brani di Jean Cocteau)
Musica Robert Caux (con brani di Miles Davis, Eric Satie)
Traduzione italiana Franco Quadri
Direttore tecnico Ottorino Neri
Luci Sergio Ciattaglia
Supervisione artistica Jacques D’Amboise
Multi-Image Jacques Collin
Assistente alla regia Paolo Orlandelli
Consulenza tecnica Cristina Menozzi
Interpreti (attori) Nestor Saied
Interpreti (musicisti) Pierluigi Calzolari (tastiere)
Produzione Renato Fontana per Segnali – Culture Engineering (Roma), Michel Bernatchez e Jean-Pierre St-Michel per Ex Machina (Quûˋbec), Romaeuropa Festival (Roma)
Durata 70 minuti
Ideato da Lepage nel 1991, L’Aguilles et l’Opium û´ stato interpretato dall’autore stesso e, a partire dal 1994, anche dall’attore canadese Marc Labrû´che, in versione francese e inglese. Quella che viene presentata al Romaeuropa Festival, in prima assoluta, û´ la versione italiana dello spettacolo, affidata da Lepage, insieme a quella spagnola, all’attore italo-argentino Nestor Saied: solo sul palcoscenico, appeso ad una fune per l’intera durata della piû´ce, Saied rivive il dramma personale di Lepage attraverso quello di due artisti di culto del Novecento come Miles Davis e Jean Cocteau, entrambi apolidi, entrambi alla ricerca di una via d’uscita da sofferenze sentimentali, entrambi dipendenti dalle droghe (l’eroina per il trombettista nero, l’oppio per lo scrittore francese).
Il risultato û´ una sorta di teatro musicale da camera, in cui la voce narrante si intreccia con le immagini proiettate su un grande schermo mobile ed estensibile che funge non solo da fondale, ma quasi da interprete dialogante con il protagonista, mentre si alternano sulla scena diversi brani musicali di Davis e le parole di Cocteau (con riferimento particolare alla Lettera agli americani e a quell’insuperato dramma della solitudine che rimane La voce umana).
LEPAGE: “TEATRO? L’ENERGIA DEL MONDO”
a cura di Andrea Porcheddu
Come û´ nato questo progetto e soprattutto la sua versione italiana?
û uno spettacolo scritto sei anni fa in inglese e francese: abbiamo pensato che potesse avere una vita ulteriore in italiano e spagnolo. Mi û´ stato detto, poi, che l’italo-argentino Nestor Saied e la compagnia Segnali stavano facendo un lavoro vicino al nostro: un giorno ci siamo incontrati, dopo un lungo inseguimento in tutto il pianeta. Abbiamo iniziato a lavorare ad una prima traduzione in italiano, firmata da Franco Quadri, e ad una seconda in spagnolo, curata dallo stesso Saied.
Quadri ha fatto un lavoro superbo, dando continuitû poetica all’insieme di due differenti testi: estratti di un’opera critica letteraria di Jean Cocteau, Lettera agli americani e la mia scrittura.
Come lavora sull’attore e cosa û´ per lei l’attore?
Il ruolo dell’attore di teatro oggi û´ profondamente mutato. Deve essere differente da quello di cinema, identificarsi con il “narratore” approcciando in modo “ludico” la scena. L’aspetto giocoso del recitare si û´ perso nel XX secolo proprio a causa del cinema: quello che ritengo importante, quindi, û´ che gli attori riescano a comunicare al pubblico il senso del gioco. Comunicare che quello che sta avvenendo non û´ la realtû , ma û´ “teatro”, disciplinato da regole precise, alle quali anche il pubblico û´ soggetto. û un ritorno alle origini, alla Commedia dell’Arte, a Moliû´re, ma anche a Shakespeare: l’attore puûý far evolvere la storia. Una delle chiavi del successo de I sette rami del fiume Ota sta proprio nel fatto che gli attori – in quattro anni di errori e di successi – siano arrivati a creare qualcosa che appartiene loro. Il mio lavoro quindi û´ di scrittura scenica.
Che ruolo ha la tecnologia in questa scrittura scenica?
La tecnologia ha cambiato il modo di narrare: noi raccontiamo sempre le stesse storie, gli stessi conflitti, mentre la societû , e soprattutto la tecnologia, si sono evolute. E questo ci concede punti di vista differenti.
Esiste una generazione dopo-Lepage?
Credo di sû˜, anche se penso che questa generazione subisca maggiormente influenze letterarie: in Quûˋbec, ad esempio, si produce un teatro “letterarizzato”, con una comunicazione fortemente verbale, volta piû¿ a cercare una lingua teatrale che un vocabolario teatrale. Ci sono delle tendenze interessanti nel mondo, a Dublino, per esempio, esiste una nuova scena molto stimolante. Credo che il teatro possa svilupparsi piû¿ liberamente lû dove non esiste una grande produzione cinematografica. Il teatro û´ la sola forma d’arte collettiva che esista ancora. Il cinema e la tv si rivolgono ad individui isolati, mentre a teatro l’energia di una collettivitû incontra quella di un’altra collettivitû .
Progetti futuri?
Oltre alle riprese teatrali, un nuovo film, ispirato alla terza parte dei Sette rami, e un nuovo spettacolo sulle vite di Frank Lloyd Wright e di Gurdjeff che si intitolerû La geometrie de miracle (lo spettacolo û´ andato in scena nel 1998, n.d.r.).
(“l’Unitû ”, 25 settembre 1997)
ROBERT LEPAGE: E DENIS MARLEAU: LA SOFFERENZA DEL RITORNO
di Gianni Manzella
Un grande telaio in rotazione fa da supporto a uno schermo elastico che û´ allo stesso tempo sipario e fondale da proiezioni. Passano vecchie immagini documentarie, film in bianco e nero che ricreano il clima della Parigi anni 50; disegni e fotografie e onirici giochi d’ombre. Lû˜ davanti, fra due eliche in rotazione, il protagonista volteggia senza peso, sospeso per aria, con la penna e il taccuino in
mano come un angelo della scrittura, o si abbandona a una cinematografica caduta nel vuoto. Cosû˜, qualche anno fa, incontrammo sulla scena Robert Lepage, artefice di questo Les Aiguilles et l’Opium che torna ora in una nuova edizione, tradotto in italiano e con un nuovo interprete.
Artista eclettico e visionario, il creatore canadese del Quûˋbec û´ capace di passare dall’assolo, come il piû¿ recente Elsinore, a una messinscena shakespeariana o al cinema d’autore, fino a complesse costruzioni drammaturgiche come il grande affresco in progress dei Sette rami del fiume Ota visto anche a Spoleto; al pubblico italiano si era del resto giû presentato insieme alla sua compagnia in una elaborata Trilogia dei dragoni ambientata all’interno di una struttura industriale, con cui ripercorreva la storia di immigrazioni del proprio paese.
Ma Les Aiguilles et l’Opium (ovvero, gli aghi e l’oppio) resta a suo modo uno spettacolo-manifesto dell’emergente scena quûˋbecoise (anche musica, danza, cinema…) in quel giocare fra le due sponde dell’atlantico, fra nuovo mondo e vecchio continente, che forse ne segna in profondo l’anima. Terra dalle frequenti tentazioni indipendentiste. E con quell’attaccamento alla lingua francese che poteva apparire romanticamente illusorio fino a poco fa e risulta invece preveggente ora che il multilinguismo ha fatto breccia nella corazza dell’America wasp.
Les Aiguilles et l’Opium parla di un viaggio di ritorno, il nostos dei greci, e della nostalgia che û´ appunto la sofferenza del ritorno. û la malattia di cui soffre il protagonista, un uomo innamorato, un artista, in preda a un’angoscia, a un male di vivere, che invano cerca di lenire affidandosi all’agopuntura o all’ipnosi. Ha preso alloggio all’hotel Louisiane caro a piû¿ generazioni di artisti, a Parigi. Ha chiesto la camera numero 9 che fu di Sartre e di Juliette Greco. Al telefono cerca di ottenere una difficoltosa comunicazione oltreoceano, in una ironica variazione della Voce umana di Cocteau. Il nome del poeta francese non ricorre per caso giacchûˋ insieme alla musica di Miles Davis funge da nume tutelare di un triplice viaggio nello spazio e nel tempo, che mescola alla vicenda attuale due episodi datati 1949, due viaggi da un continente all’altro, o da balsamo possibile di quel malessere esistenziale. Ecco cosû˜ apparire la sagoma della tromba del jazzista americano, mentre nel testo dello spettacolo si innestano alcuni brani tratti dalla lunga lettera agli americani che Cocteau scrive in aereo, ritornando da New York.
Le simmetrie si moltiplicano. Gli aghi del titolo diventano anche quelli di una siringa che incombe enorme sul profilo di un uomo che si buca, e questa rimanda ancora all’oppio di cui Cocteau fa l’elogio. Ma questo viaggio agli inferi, questo bisogno di disintossicazione non sono lontani da quelli dell’uomo innamorato che accetta di vivere il proprio dolore dopo aver inseguito il percorso di Orfeo. Lo spazio sospeso fra i due continenti diventa cosû˜ il non-luogo dove esperienza artistica ed erotica si congiungono.
Si viaggia nel tempo e nello spazio anche in Les trois derniers jours de Fernando Pessoa messo in scena dal ThûˋûÂtre Ubu di Denis Marleau, l’altra stella del teatro del Quûˋbec (ha collaborato fra l’altro con Lepage per il giû citato Elsinore), a partire dal breve racconto del nostro Tabucchi. Anche qui un uomo solo in scena, e ancora si tratta di un artista, lo scrittore portoghese sul letto di ferro all’ospedale di Saint-Louis des FranûÏais a Lisbona, dove si compie un’agonia imbottita di laudano. û il novembre 1935. Pessoa û´ rimasto solo con i fantasmi della sua fantasia, i suoi eteronimi venuti a fargli visita, come per un addio. A turno, sotto lo sguardo immobile di un’infermiera. Ciascuno col proprio carattere, col proprio stile: il dandy, il saggio contemplativo, il filosofo folle, il medico e poeta, il contabile sognatore. Ma tutti questi uomini non sono che una sola persona. Tutti con un unico volto, quello di Pessoa, ovvero l’attore Paul Savoie.
I volti doppi dello scrittore passano su un altro volto, registrati in video, come una maschera tragica: sono proiezioni, questi altri da sûˋ, nel senso piû¿ pieno. Con loro l’attore intesse un dialogo che û´ solo virtuale, mentre le musiche di John Rea danno voce lirica al sentimento d’amore. Presenze tutte che nascono dal delirio del poeta, in questa contemplazione della morte che û´ anche un atto di riconciliazione con la vita, prima della morte. Prima di prendere in pace la strada del ritorno.
Rassegna stampa
“S’avverte un nodo alla gola che dura per tutto lo spettacolo, nel folgorante Les Aguilles et l’Opium di Robert Lepage, solo fino ad oggi al Vascello nel quadro del Romaeuropa Festival. A cogliere di sorpresa û´ l’irrimediabile strazio reso da un monologo visionario che ritrae la coincidenza di due analoghe angosce esplose quasi 50 anni fa nella vita intima di Jean Cocteau e Miles Davis, al cui calvario si ricollega piû¿ tardi, nell’89 a Parigi, lo stato d’animo altrettanto infelice dello stesso Lepage. Di eccezionale c’û´ che questo ideatore franco-canadese di macchine celibi stavolta opera su se stesso una chirurgia che mette a nudo un’umanissima dipendenza dai turbamenti amorosi. Ed û´ toccante l’anatomia comparata delle depressioni in cui sprofonda l’unico attore, il coinvolto italo-argentino Nestor Saied, che in sequenza evoca il lutto sentimentale di Cocteau dopo la morte di un compagno, la dissipazione di Miles Davis reduce da un contatto con Juliette Greco, e lo stress telefonico di un giovane artista cosmopolita in cui û´ da riconoscere Lepage abbandonato da una persona cara. C’û´ da sgranare di continuo gli occhi di fronte a uno scenario mutante che si imprime in uno schermo girevole come una lavagna, sulla cui superficie non smettono mai di fluttuare disegni surreali e frammenti simulati di cinema d’autore, finchûˋ appaiono come su un vetrino impietoso le pratiche del consumo di sostanze allucinogeni.
Il cantore-martire a piû¿ riprese si libra in aria come se viaggiasse sull’Atlantico (che Cocteau e Davis sorvolarono all’inverso nel ’49), o si distende plasticamente alla maniera di Cocteau nelle foto di Halsman ispirata a Le Sang d’un poû´te, o girovaga in cerca di siringhe come il disperato trombettista. E mentre didascalie sostengono i capitoli, mentre scorre il tessuto calmo delle parole (fra cui quelle della Lettera agli americani di Cocteau) tradotte da Franco Quadri, mentre questa diagnosi dell’ineluttabile fa patire anche chi assiste, ci si avvede dopo un’ora e un quarto che anche il teatro tecnologico ha i suoi palpiti”.
(Rodolfo Di Giammarco, Anche gli artisti soffrono il mal d’amore, la Repubblica, 18 ottobre 1997)
“La stanza dell’hotel si trasforma in un apparecchio per registrare emozioni e suggestioni, organizzate in un componimento poetico dove le parole rimano con la musica e le immagini all’interno di una struttura metrica multimediale: la parete di fondo ruota su se stessa e accoglie ombre e frammenti di film e di fotografie, si dilata ad inghiottire il protagonista. Il quale si stacca, alla lettera, dal palcoscenico e dalle convenzioni sceniche per “volare” in una diversa dimensione narrativa, in assenza di leggi di gravitû e di coordinate naturalistiche.
Antichi e preziosi trucchi da teatro barocco (come la “macchina per il volo dell’angelo” che solleva da terra l’attore) si fondono con una garbata sperimentazione multimediale e, al di lû della fascinazione spettacolare, Les aiguilles et l’opium disegna una convincente prospettiva di ricerca linguistica in campo teatrale; senza fare ricorso a soggezioni alle avanguardie piû¿ o meno storiche e indenne da eccessivi innamoramenti nei confronti delle nuove tecnologie: una lavagna luminosa e un proiettore sono sufficienti.
Solitario protagonista, l’attore italo-argentino Nestor Saied interpreta la versione in lingua italiana dello spettacolo (interpretato dallo stesso Lepage nell’edizione originale) con lieve eleganza, con suadente malinconia”.
(Pietro Favari, Un amore lontano fra Cocteau e le note di Davis, Corriere della Sera, 17 ottobre 1997)
“Ebbene, ecco che quanto di letterario e di compiaciuto (sotto il profilo dell’autobiografia) comporta un simile mûˋnage viene stemperato da Lepage, come dicevo, nell’equazione e nell’interscambio, oltremodo eclatanti, stabiliti con sistematica inventiva fra le parole (ma anche i suoni, ma anche la musica) e gli oggetti di scena, compreso il corpo dell’ attore protagonista. Tanto grazie, soprattutto, a uno schermo mobile ed estensibile, elastico e traslucido, che, ruotando su se stesso, funge di volta in volta da fondale, trampolino e sipario.
In proposito, mi limito a due esempi. La descrizione del volo di Cocteau verso New York risulta “doppiata” da due eliche che ruotano in alto, a sinistra e a destra dello spazio scenico; mentre l’attore – sospeso fra di esse, esattamente al centro, per mezzo di due cavi – “si trasforma” nella fusoliera dell’aereo e lo schermo citato, capovolgendosi sotto di lui, diventa un cielo trapunto di stelle. E allo stesso modo, quando si sentono gl’inconfondibili riff di Davis, l’attore, mantenendosi dritto e rigido, assume letteralmente l’aspetto del perno attorno al quale ruota il disco della non meno mitica Capitol su cui sono incise le frasi musicali in questione e che, s’intende, contemporaneamente appare proiettato in diapositiva sullo schermo.
Per di piû¿, l’esibizione della tecnologia multimediale e dei raffinati effetti da optical art (vedi, sempre a titolo d’esempio, l’assemblaggio contro luce, dietro il solito schermo, dei pezzi della tromba) risulta vivificata – complice l’agile traduzione di Franco Quadri – da un’ironia tanto scoperta quanto allusiva. Penso, mettiamo, a quella Grûˋco che lascia aperta la porta della predetta camera 9 dell’Hotel “La Louisiane”, l’unica dotata di acqua corrente, come segnale e invito, per i suoi amici esistenzialisti, a lavarsi almeno di tanto in tanto. Eccellente, infine, la performance attoriale di Nestor Saied. E giustificatissimi, quindi, i molti applausi al termine”
(Enrico Fiore, La droga, il poeta e la tromba, Il Mattino, 21 ottobre 1997)
“Insomma, questa sorta di raffinatissima piû´ce introspettiva, o di scintillante confessione scenica, o di pungente thriller sentimentale – tradotto con affettuosa freschezza da Franco Quadri – û´ di fatto un’elegante variazione musical-letteraria, una partitura a piû¿ voci piena di tenerezza, di stratificazioni culturali, di disincantato romanticismo, di lucida nostalgia raziocinante per una certa epoca e i suoi miti intellettuali: cosû˜, mentre le musiche originali di Robert Caux si alternano a vecchi echi struggenti di Miles Davis, all’azione teatrale si aggiunge l’intensa suggestione dei vecchi filmati, la Greco che canta “Je suis comme je suis”, la Greco e Davis al tavolo con Picasso che offre vino e Sartre che fa da interprete, il torbido fascino della giovane Jeanne Moreau in Ascensore per il patibolo.
Proprio nella perfetta realizzazione di una compiuta ipotesi di espressione multimediale sta d’altronde la principale attrattiva di un allestimento che non si limita a sovrapporre immagini dal vivo e spezzoni del passato. Attraverso uno schermo mobile e un ingegnoso sistema di carrucole che sollevano e rivoltano in ogni direzione l’attore italo-argentino Nestor Saied, la piccola ribalta da monologo – un pavimento a quadri bianchi e neri e due colonne ai lati a evocare la fatale camera d’albergo – si apre infatti di continuo a orizzonti infinitamente variabili: cosû˜ Lepage immerge la figura umana in sorprendenti paesaggi virtuali, svela magici controluce, inventa prospettive spiazzanti, richiama il volo di un vecchio aereo mostrandoci il protagonista sospeso per aria tra due grandi eliche ruotanti, con impeccabile senso della composizione visiva e un istinto poetico niente affatto limitato dalla ridotta dimensione dello spettacolo”.
(Renato Palazzi, Mal d’amore multimediale, Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 1997)