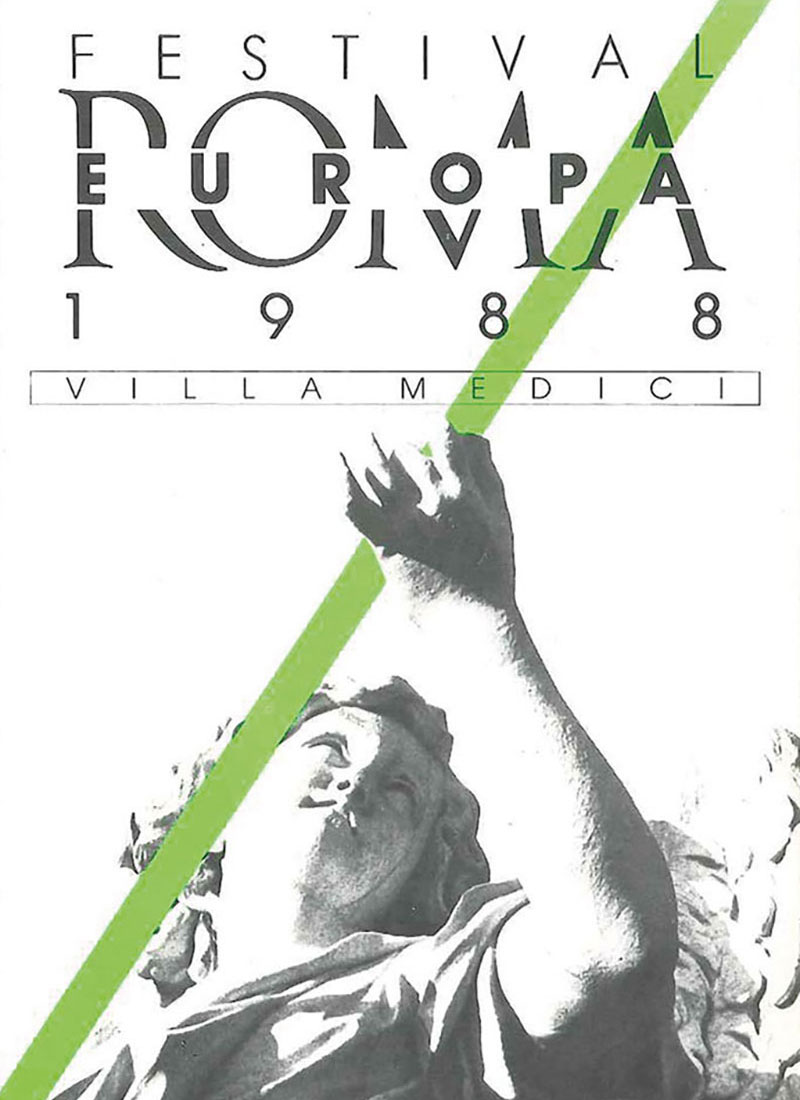“Cinefilo”, secondo il Coccia-Cacciatore della Terminologia Filmica, è “colui che si dedica con passione assoluta ed esclusiva al cinema, spesso a discapito del rapporto col mondo”. Questa è anche l’epigrafe che accoglie il visitatore di Celluloid flesh, l’allestimento di Pierre Pelle, già borsista dell’Accademia di Francia, che presenta a Villa Medici in prima assoluta la sua nuova creazione. Pelle, che per il suo lavoro ha raccolto vasti consensi da nomi come Achille Bonito Oliva, Jean Clair, Harald Szeeman, Giancarlo Politi, realizza le copie esatte di una variegata fauna di frequentatori di cinema d’essai, conosciuti e fotografati durante le sue frequentazioni della sala Filmstudio di Roma. Riprodotti con cura maniacale attraverso l’uso di materiali come resina, cera, lacca e fibra di vetro, i dieci cinefili in copia perfetta sono calati nel contesto straniante creato dalle musiche di Franco Battiato e Faust’O, e dalla livida atmosfera delle luci di Gianni Marras. Lo stesso Pelle si intrufola fra le sue statue, immobile, come a confondersi con i suoi soggetti, ricalcandone il destino di succubi dell’ossessione cinematografica che li costringe all’immobilità sociale ed affettiva.
LA CARNE È UN’INVENZIONE SENZA FUTURO
di Achille Bonito Oliva
Se il cinema era già nei primi anni del secolo “il mondo fatuo degli artisti muti e degli autori delle films” (almeno per Pirandello), era anche già saturo del profumo della rosa purpurea del Cairo, la fragranza della magnifica ossessione. Un’ossessione che porta esemplarmente la Cecilia di Mia Farrow e Woody Allen alla perdizione. Non una perdizione di stampo morale, ma proprio uno smarrimento letterale, un perdersi nel Cinema. Nello schermo Cecilia cercava e trovava il rapimento, l’inganno di una vita altra che improvisamente diventa questa. Ma solo per spegnersi spietatamente e definitivamente quando il proiettore tace.
A differenza della cinefila di carne di Allen, i cinefili di fibra di vetro di Pierre Pelle (non nuovo a questo gioco fra materiali organici e inerti: ricordate Le Table Marbrée della Biennale del 1987?) non hanno sentito il proiettore spegnersi. Continuano a vedere le immagini scorrere sullo schermo, in movimento ed avvolgenti. Più veloci del mondo reale. Tanto più veloci che, impossibili da fermare, costringono il filmgoer pelleano a fermarsi lui stesso, per letale contrappasso. Immobile, vitreo, copia morta di carne che può dirsi viva solo perché il cuore ancora batte, ma la testa è persa dietro al mondo altro delle ombre cinesi. Le sculture di Pelle sono esse stesse ombre cinesi, o meglio ombre cinefile, create da un cineasta che non hai mai girato un metro di pellicola. Ma che ha reinventato paradossalmente l’ossessione, calandosi poi in essa, carne vera accanto a carne finta.
Nella mostra, Pelle rimane in agguato, in posa accanto alle sue statute per fuggire qualsiasi sospetto di uno sterile e spettacolare gioco avanguardistico. Per puntualizzare quanta empatia chieda a se stesso e allo spettatore nel raccontare il melodramma comico di vite ferme davanti allo schermo. Per urlarci con dolcezza e partecipazione quanto noi stessi, difronte ad un’epoca di gigantismi sovranazionali nella politica, nell’arte, nella cultura e nei rapporti sociali, siamo diventati spettatori di cera. E per scioglierci non è necessario un inverno nucleare. Basta un’illusione estiva di glamour che poi può essere smantellata con un gesto semplice, lasciandoci nel panico perché convinti di aver subìto una perdita irreparabile. Mentre era solo la fine del primo tempo. La cera di cui siamo fatti non è che carne reinventata dopo la contaminazione col cinema, una carne che è divenuta quindi eccitante, realistica e finta come uno spettacolo cinematografico. Carne che dunque, come il cinema stesso secondo la fallimentare e geniale intuizione dei fratelli Lumière, è diventata un’invenzione senza futuro.
PUTTING FLESH INTO CELLULOID
di Pierre Pelle
Ho sempre creduto che andare al cinema fosse un piacere puro e univoco.
In una sala cinematografica non ci sono attori o autori da applaudire, a cui trasmettere la proria empatia. Raramente si può manifestare direttamente il proprio apprezzamento ai cineasti.
Nel 1987 ero di passaggio a Roma, dopo la presentazione alla Biennale di Venezia di una mia opera, e mi sono ritrovato a seguire un ciclo di proiezioni in uno storico cinema d’essai della capitale, il Filmstudio. Con me, una schiera di appassionati che seguiva l’integrale del cineasta franco-austriaco Marcel Ophuls. Parlando con alcuni di loro mi sono reso conto che mai mi era capitato di registrare una tale e assoluta ossessione per il cinema e i film. A differenza di quanto accade in altri paesi, il cinefilo romano pareva essere completamente assorbito, la vita risucchiata nei film, tanto da escludere qualsiasi altra forma di relazione sociale. Era come se la loro dedizione totale si trasfigurasse in fervore religioso: così pensavano di arrivare a toccare l’oggetto del loro amore, pur rimanendo assolutamente lontani da esso nel tempo e nello spazio. In quel momento ero parte di un rito estetico-religioso brechtiano e insieme un incubo popolato da oscure ossessioni. Una specie di cattolicesimo dell’Arte. Non solo l’anima, ma anche il corpo dgli spettatori che erano con me sembrava intrappolato nella pellicola cinematografica.
Da qui nasce l’idea della carne (flesh) intrappolata in qualcosa di eterno e insieme friabile come il cinema. Che ho scelto di evocare attraverso la suggestione passatista della celluloide (celluloid), un materiale ormai smesso dall’industria cinematografica ma sempre vivo nell’immaginario collettivo. Qualcosa di estinto ma vitale. Passato ma presente. Come il cinema è avvenuto realmente su un set, ma ciò che ce ne rimane è solo una traccia iperrealistica – e la realtà che l’ha originata è ormai persa, intangibile – la carne è veramente esistita, viva. Fino a quando il cinema stesso l’ha fagocitata avidamente, restituendola iperreale ma inadatta alla vita. Al contatto con l’aria sarebbe esplosa per autocombustione come il nitrato d’argento che fissava i film di una volta. L’ho dovuta così marmorizzare prima che decadesse, rendendola una carne inedita. Una carne di celluloide.
Rassegna stampa
“Facile accusare il parigino Pelle di elitarismo iperrealista, come qualche voce risentita dell’Accademia di Francia ha fatto. Più difficile è ammettere che lo shock dei corpi perfettamente riprodotti, cristallizzati in posture semplici, banali, ne ridà vividamente la disperazione. Pelle mette la decadenza culturale in formalina, esponendo la degenerazione della passione cinefila in un’ossessione cupa e profonda. […] Gli interventi musicali stranianti (lo psycho-ambient del primo Franco Battiato, lo sperimentalismo synth-pop di Faust’O) posizionano le sculture in uno spazio alieno, inquietante, tanto quanto alieno e inquietante deve apparire il mondo reale agli occhi del cinefago terminale”.
(Teresa Campi, Pelle di Celluloide, Paese Sera, 6 giugno 1988)
“Una cascata di capelli neri perfettamente organizzati in trecce rasta, lo sguardo vitreo fisso nel vuoto, Pierre Pelle si è confuso fra le sue sculture con l’amore di un padre che, ansioso per la sorte delle sue creature, ne vuole seguire passo passo il destino. Anche a rischio di immedesimarsi con loro e perdere la propria identità . O di farla perdere a loro. Ed è proprio questo il senso delle sculture che abbiamo visto a Villa Medici. La fusione dell’arte, che è rilettura della vita, con la vita stessa, che esiste solo per essere reinterpretata dall’arte. Che poi è il dramma dei corpi di celluloide dei film buff, immortalati per sempre nell’atto di confondersi disperatamente con l’oggetto del loro amore”.
(Francesca Giuliani, Cinecriogenia a Villa Medici, la Repubblica, 6 giugno 1988)
Sculture Pierre Pelle
Musica Franco Battiato (Areknames, Aria di rivoluzione), Faust’O (The sound of one hand, Amedeos’)
Luci Gianni Marras