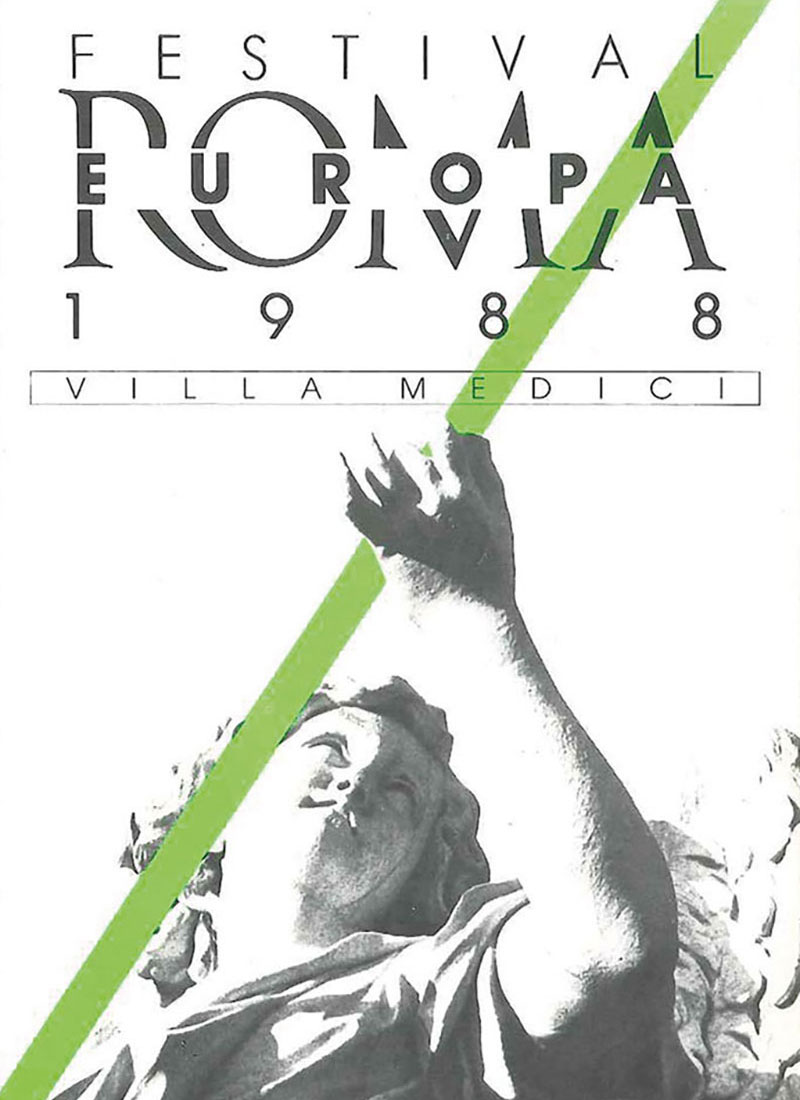Lo spettacolo di Lucia Latour esplorando il concetto di “caduta” si propone come satira dell’idea tradizionale di movimento del corpo: attraverso tre quadri coreografici, Truppa, Film giallo e Ballabile, si snoda una riflessione intorno all’idea e all’azione del “cadere” e “non cadere”, come indica il titolo stesso del lavoro; un gioco sapiente che rivede la nozione di gravità capovolgendone il senso comune e approdando ad un nuovo equilibrio, anche spirituale.
Continuando il discorso iniziato a partire da Frilli Troupe, Lucia Latour e Altroteatro sottopongono il corpo dei danzatori ad una ricerca estenuante attraverso i propri limiti e le proprie possibilità , per arrivare quasi a forzare le leggi della fisica. La scenografia, essenziale, si arricchisce delle immagini proiettate su uno schermo (fotografie, figure geometriche, paesaggi e forme astratte), che fanno da contrappunto all’azione coreografica e rilanciano in una nuova direzione quella ricerca spaziale che rimane uno dei cardini degli spettacoli della Latour.
INTERVISTA A LUCIA LATOUR
a cura di Francesca Bernabini
(“Era una donna che ballava a testa in giù“, Corriere della Sera, 22 luglio 1988)
Non scherzo se affermo che tra una decina di anni prenderò l’aperitivo in un’altra gravità . Non intendo dire che bisogna andare in altro mondo. Ma il nostro sarà comunque un mondo diverso. Lo sviluppo tecnologico è molto accelerato, veloce. Un secolo fa prendevano per pazzi coloro che volevano volare. Oggi gli aerei non sono altro che autobus di massa. Fra qualche anno forse ci sarà proprio un’altra gravità . […]
Il nuovo spettacolo è una prosecuzione del precedente lavoro?
Non è esatto. Non è una ricerca ma una avventura nel mondo della gravità che mi diverte molto. Con Frilli Troupe avevamo giocato con un modo diverso di essere. Era come entrare in un mondo “altro” e divertente. Con questo spettacolo abbiamo affrontato, sempre divertendoci, tutti i problemi che nascono stando a testa in giù.
Come si configura questa nuova gravità ?
Nasce dall’idea di cadere. La si supera. Si arriva in un’altra gravità dove non si cade più ma si ha sempre la memoria del cadere. Nella vita si ha paura di cadere, di farsi male. È un fastidio ma al tempo stesso un piacere, una sicurezza su uno stato preciso e conosciuto. Questo spettacolo è un po’ un viaggio verso l’ignoto.
Come è venuta questa idea?
Mi ha ispirato la danza eccentrica di Foregger. Era un russo di origine austriaca che ha lavorato intorno agli anni venti al fianco di Mejerchol’d e Ejzens¹tejn. Compose un tango in cui la donna ballava a testa in giù. Era stravagante e provocatorio, come del resto lo era tutto il teatro non tradizionale di quel periodo. E con questo intendo il varietà , il circo, il tip tap, che erano le più grosse officine di creatività . La multivisione totale che uso nello spettacolo si ispira ai fondali del varietà : alludo a spazi reali senza nascondere una finzione evidente.
On y tombe… si ispira anche ai mezzi di comunicazione di massa. Dagli spot, dai video musicali, nasce un rapido succedersi di situazioni…
Nello spettacolo facciamo proprio questo. Le azioni mutano come se si spingessero i tasti di un telecomando. Durante i cambi appaiono scritte pubblicitarie che reclamizzano lo spettacolo. Poi appare un film giallo, e ancora una clownerie e una rivista effimera con tutù. Il tutto è condito con una buona dose di stravaganza e eccentricità , che considero i miei segni distintivi.
LA NUOVA DANZA ITALIANA
di Leonetta Bentivoglio
C’è una giovane coreografia che parla, in Italia. Dai balbettamenti dei primi anni 80, si è approdati allo spessore di un discorso dotato di concretezza autentica. Fresca per stimoli entusiastici, calda per appassionata convinzione, la nuova danza in Italia si muove forte, corre in espansione, gioca coi riflessi del teatro, del cinema, delle arti visive. E la considerazione ormai anche internazionale del fenomeno (il Festival di Chateauvallon dedica quest’anno alla giovane coreografia italiana un’ampia, importante sezione) non è che una testimonianza in più di un particolare momento di felicità creativa.
S’è identificato un percorso, s’è raggiunto uno “stile”: emerge un marchio, una riconoscibilità di tendenza. Oggi, al di là di qualsiasi compiacimento nazionalistico, la sperimentazione italiana in danza semplicemente “è”: esiste, procede. Si dimostra in crescendo quantitativo e qualitativo. Si dichiara come movimento che ha una sua storia ed una sua labile e sfaccettata, ma reale, fisionomia. Guardiamole entrambe: il carattere della danza sperimentale italiana è infatti intimamente legato alla sua rapida genesi.
Non c’è stato, nella storia contemporanea della danza in Italia, alcun compatto movimento di avanguardie storiche. L’unico codice vigente, fino agli anni 60 almeno, è stato quello del balletto classico-accademico: una tradizione aurea e un riferimento radicatissimo ed esclusivista nella cultura di danza italiana. Quegli isolati pionieri della danza libera che per l’Italia hanno viaggiato e insegnato (per esempio i coniugi Sakharov) non hanno mai determinato una reale scuola di pensiero e di diffusione di codici alternativi: solo fenomeni epigonali. E se il Futurismo, tra la fine degli anni 10 e gli anni 20, dalla danza fu sedotto fortemente, e in questa direzione giocò più di una carta interessante, la provocazione futurista non fu messa a frutto in senso specificamente coreografico. Quegli stimoli, in realtà , furono raccolti e sviluppati in Germania (pensiamo alla diffusione che il “Manifesto della danza futurista” ebbe nella scuola del Bauhaus, la stessa da cui nacque il Balletto triadico di Oskar Schlemmer) e persino in Russia (consideriamo i legami tra futurismo e costruttivismo nell’estetica russa del balletto): paradossalmente più che in Italia. Dove gli ideali di una nuova coreografia definiti da Marinetti a livello teorico restarono delimitati a quest’ambito.
Fu in realtà soltanto una forte suggestione pittorica la concreta influenza che ebbe il futurismo nella danza teatrale italiana. Una fascinazione tutta esterna che non produsse tracce sul dinamismo interno del danzare: in onore e a vantaggio del balletto, i futuristi italiani furono grandi scenografi (Prampolini), autori di visionarie, favolistiche metafisiche cornici di spettacolo (Depero), e ideatori di happenings preveggenti rispetto agli sviluppi successivi della “performing art” (Marinetti). Ma la storia della danza è soprattutto, innanzitutto, storia del movimento: e il futurismo non seppe incidere sulla ragion d’essere teatrale del movimento.
La trasformazione “genetica” del movimento – o forse l’idea della possibilità di questa trasformazione, la constatazione di un’avvenuta alterazione espressiva: di una differenziazione reale, insomma, rispetto alla delimitazione di codice costituita dall’accademismo – giunse in Italia da lontano: dagli Stati Uniti soprattutto, con la diffusione delle nuove tecniche di formazione alla danza (Graham, Limón, Cunningham). E poi (ma solo in seguito: dopo la rivelazione e l’assorbimento del Tanztheater tedesco) anche dalla Germania. S’apriva intanto il mercato italiano (clamorosamente, persino in eccesso) alla grande danza internazionale: un turbine di scoperte finì per investire il pubblico. Un “boom” – parola odiosa, ma efficace – che ne ha modellato il gusto e aperto lo sguardo. Che ha insegnato i mutamenti avvenuti molto più di qualsiasi nuovo verbo pedagogico parallelamente introdotto (spesso in modo caotico e approssimativo) nelle scuole di danza italiane. E ha stimolato i più giovani ad uscire: non solo oltre confine (per imparare, guardare, studiare), ma anche, più metaforicamente, dai codici delimitati della danza stessa. Che s’avvicinava al nuovo teatro, che assorbiva dalle arti visive e dalla performance, che si lanciava alla scoperta dei video.
Così, prima timidamente, poi via via con una sempre più eccitata e fervida consapevolezza, alcuni tra i molti danzatori italiani si sono fatti autori: rivelandosi lontani, drasticamente distanti dal “modernismo” stereotipo della “prima” danza contemporanea italiana (quella anni 70: prevalentemente grahamiana e tendenzialmente narrativa ed enfatica).
I referenti più importanti, i giganti dai quali farsi attraversare, sono stati Merce Cunningham e Pina Bausch, due poli estremi, emblematici, della sperimentazione occidentale: astrazione da una parte, espressionismo dall’altra. Danza pura, linguaggio che basta a se stesso, spersonalizzazione siderale, sublimazione del corpo in Cunningham. Danza-teatro, anti-atletismo, profonda individuazione psicologica ed espressiva degli interpreti, drammaturgia gestuale, e totale, in Pina Bausch.
Ma è sempre di due poli che si tratta: tra questi estremi esasperati pulsa un intreccio intenso e articolato di altri artisti dai quali molto s’è attinto. E non sono soltanto coreografi: la giovane danza italiana nasce pure dai riverberi delle mitiche apparizioni anni 70 (Kantor, Wilson, la “prima” Meredith Monk), dai riflessi del teatro di ricerca nazionale (i Magazzini e altro), dagli sguardi incrociati alla letteratura e alle arti plastiche.
Nasce, soprattutto, da una prepotente volontà di nascere. Spesso, nella sua breve storia, si fa arrogante e presuntuosa: vuol arrivare là dove non può; oppure copia male i suoi modelli; altre volte è rozza nel linguaggio, tecnicamente abbozzata ed insicura. Ma è vitale, recettiva, curiosa, vibratile; è un fatto che respira, è un’interessante voglia di futuro: anche nell’arroganza. E oggi si dilata, è epidemia di gruppi e tentativi.
È cronaca di compagnie disseminate ovunque: un panorama che si moltiplica ogni anno. È teatro che ama il “racconto” (perché non è mai puramente astratta la danza italiana) ma sempre evitando la didascalia e il descrittivismo; è coreografia non atletica né tecnicistica (come molta nuova danza americana) ma piuttosto espressiva, teatrale, punteggiata di gestualità , di danza “comportamentale”; è partitura di movimenti che tende a utilizzare la musica più come atmosfera (o colonna) sonora e elemento di contrappunto che come partitura speculare della danza; è, infine, teatro che ama gli elementi scenici invadenti, i materiali concreti, i referenti visibili. Senza che mai la danza resti sola ed esclusiva, protagonista astratta di una scena astratta: piuttosto, sempre, è danza che vuol contaminarsi con le “cose”, le presenze di materia, gli oggetti. Ed è anche qui, proprio da questo punto di vista, che si definisce la sua sostanza “calda”: lontana dall’efficientismo tecnico, dal corpo “tecnologico”, caro a tanta sperimentazione altrove. Ecco detti alcuni punti di contatto tra i gruppi italiani: ma le differenze, all’interno di questo medesimo tronco, sono infinite. Quanto distano, tra loro, le fisionomie: quanto poco somigliano, per esempio, i siciliani di Efèsto al romano Enzo Cosimi. Quanta scarsa affinità tra gli ombrosi e primitivisti Sosta Palmizi, di diretta ascendenza carlsoniana, e il romano Fabrizio Monteverde, letterario e neo-romantico. Oppure, ancora, quanta poca familiarità tra il lavoro fosco e drammatico del complesso Vera Stasi, nato e cresciuto a Roma anch’esso, e il morbido immaginario al femminile della milanese Luisa Casiraghi, un’altra “figlia” della Carlson. E i fiorentini di Parco Butterfly, con la loro intensità visionaria, non proclamano forse esplicitamente un’affinità più diretta con la compagnia teatrale dei Magazzini che con altri gruppi di danza? E quanto davvero conta affiancare, solo perché entrambe le coreografe sono italiane, l’energia furiosa di Adriana Borriello, formata all’esperienza del gruppo fiammingo Rosas, alla delicatezza, le sfumature, l’ambiguità , il gusto “alla francese” della veronese Laura Corradi?
Insomma: c’è un mare che cresce, tutti vogliono dire e creare, e tutti in modo diverso. Seppure un timbro, una luce, un calore mediterraneo, e soprattutto quella certa serie di abitudini metodologiche di cui s’è detto, rendono ormai riconoscibile un “italian style”.
Oggi, di questo stile, l’Accademia di Francia a Roma prende atto. E in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, produce quattro creazioni italiane. Una decisione significativa per lo sviluppo della nuova danza; e una cornice di prestigio, quella del festival Roma-Europa, pronta ad accogliere il progetto. I quattro coreografi prescelti (con una selezione ardua, vista la quantità del materiale a disposizione) sono due uomini (Roberto Cocconi e Enzo Cosimi) e due donne (Lucia Latour e Laura Corradi); due sono romani (Latour e Cosimi) e due settentrionali (Cocconi di Udine e Corradi di Verona). Rappresentano, insieme, una fetta di qualità riconosciuta della coreografia di ricerca italiana. Ma non è questo il punto: la qualità senza dubbio è anche altrove.
Due, in realtà , sono stati i criteri della selezione. Ancor prima che quattro gruppi sono stati scelti quattro progetti di spettacoli. Sollecitati, comunque, all’interno di un medesimo filone: quello della ricerca, appunto. Una precisa scelta di campo che riflette la fisionomia culturale di un festival, Romaeuropa, prevalentemente votato all’esplorazione della danza nuova. E questo è stato il primo criterio. Il secondo: puntare sulle differenze, più che sulle somiglianze. Per dare anche all’estero (il progetto sarà esportato) un quadro il più possibile emblematico di una situazione in fermento: differenziata, appunto.
Ecco dunque il “visivo” per eccellenza di una coreografa come Lucia Latour, autrice di luci, colori, movimenti, in una concezione fortemente architettonica delle relazioni tra i fattori. E in un’avventura di linee e spessori, immagini e volumi, esplorazioni del rapporto tra figura umana e spazio scenico, corpo e artificio teatrale, che definisce un racconto “cinematografico”. Racconto senza storia, certamente: costruito per rimandi e citazioni, spunti tematici e salti nel fantastico. Ma pur sempre di un racconto costruito si tratta: edificato su netti presupposti d’intercodice, in un viaggio di andata e ritorno circolare tra danza e immagine, segno dinamico e segno grafico.
Ecco invece Morgana, di Cocconi, trio per una danzatrice e due danzatori, tutto cresciuto su un procedimento di composizione “work in progress”: materiali di danza sviluppati per accumulazione e per progressiva selezione e distillazione, come sempre accade nella dimensione creativa instaurata da Carolyn Carlson. Un mondo da cui Cocconi, che è membro dei Sosta Palmizi, deriva in pieno.
Ecco l’eros nero di Cosimi, la sua brusca sensualità , la sua ispida rabbia, che oggi si fa pronta ad affrontare, ancora una volta con un trio (ma scendono in campo due donne e un uomo, stavolta) la video-arte e la scultura tecnologica (come già in Sciame). Ma approfondendo ed esplorando nel dettaglio psicologico – grazie alla formula ridotta – il suo percorso espressivo. Ecco Laura Corradi che sviluppa le suggestioni di un romanzo, Il profumo di Patrick Süskind, in un’intrigante ode all’olfatto. Preannuncia, questa coreografa femminilissima nel segno, un’eleganza e leggerezza di “colore” drammaturgico che pare appena odorosa di essenze surrealiste.
Rassegna stampa
“Spregiudicata, estrosa, ammiccante, divertente è apparsa Lucia Latour con la sua compagnia AltroTeatro. La Latour costruisce qualcosa di nuovo anche se, trovata la chiave, vi insiste un poco troppo (e qualche iterattività di disegno andrebbe eliminata). La Latour combina una serie di immagini, di “scoop” e li fa esprimere da sette danzatrici che da tempo lavorano con lei e che sono di una grande bravura.
Ciascun collage è ispirato a qualcosa che appartiene (attraverso una scenografia bidimensionale, realizzata con la multivisione) ora con orrore, ora con sarcastico umorismo alla nostra vita: la guerra, il film giallo, la meccanizzazione, la grande città . Sono visioni fuggitive, immagini policrome a sfilare sullo schermo mentre sul davanti le ragazze si abbandonano continuamente alla dinamica del cadere e del non cadere (On y tombe… On n’y tombe, che è il titolo dello spettacolo).
Il problema che si è posto la Latour è quello di restare in equilibrio (l’ossessivo “aplomb” della danza classica) o di perdersi sotto il peso della forza di gravità . Ecco una tematica, con il paradosso della satira acuta, che si presta alla danza, che solo la danza può evidenziare. Quasi in polemica con il balletto, la Latour non riesce a far stare in piedi le sue creature le quali cadono nelle maniere più diverse, assumendo anche per terra le pose più diverse e più impensate, disarticolate e contorte”.
(Alberto Testa, Cadere, non cadere: com’è difficile restare in equilibrio, la Repubblica, 26 luglio 1988)
“Contrappuntato sullo sfondo da immagini di “multivisione” con la quale, a ritmi serrati, le ballerine interagiscono creando dimensioni visive curiosamente frammentate, con effetti stranianti di trompe l’œil, il continuum danzante è solo uno degli elementi di uno spettacolo rigoroso, pulito, in cui tutto funziona ai limiti della perfezione, dalle quasi sempre bellissime immagini della multivisione (di Elena Green e Bruno Magno) alla musica (di Luigi Ceccarelli e Luca Spagnoletti) alla costruzione coreografica. Solo che la perfezione talvolta si fa calligrafica, patinata, e sembra rimandare all’esclusivo piacere dell’occhio. In questi momenti lo spettacolo, pur conservando un innegabile ipnotico fascino, sembra perdere di spessore, appiattirsi in una dimensione da video-clip dalla quale non sempre riesce a prendere le debite distanze, magari, com’è nelle corde di Latour, attraverso il colpo d’ala dell’ironia e del gioco”.
(Elena Grillo, “On y tombe” elegante caduta di Lucia Latour, Avanti!, 24 luglio 1988)
“Proprio come nella scena “Girl Hunt” in The Band Wagon (Spettacolo di varietà ) celebre film di Vincent Minnelli con Fred Astaire e Cyd Charisse, sullo sfondo di anonimi grattacieli tipacci con aria da gangster vanno e vengono volteggiando nella figura della “ruota” e sparando a destra e a manca con le loro “colt”. Niente di male nella citazione, ma a che pro? Questo roteare di gambe, sospendersi in verticale per poi cadere a gambe all’aria continua per oltre un’ora senza che se ne intraveda la ragione, e solo trasformandosi in un roteare da can-can di cui si ode persino qualche nota, con le ragazze in lunghi tutù di colori shock. E la cosa finisce qui. Viene il dubbio che il titolo alluda, per negarlo, al celebre “on y danse… on n’y danse” riferito al Ponte di Avignone e inteso nel senso che qui non si danza per niente. Ma se non si nutre neppure un briciolo di amore per la danza perché definirsi coreografi per forza?”.
(Donatella Bertozzi, Ma Cyd Charisse era meglio, Il Messaggero, 26 luglio 1988)
Coreografia Lucia Latour, Altroteatro
Compagnia Altroteatro
Musica Luigi Ceccarelli, Luca Spagnoletti
Progetto multivisione e luci Elena Green, Bruno Magno
Realizzazione multivisione Renato Piselli
Fotografia Enrica Scalfari
Costumi e trucco Marina Lund
Interpreti Carla Bertusi, Gloria Mujica, Arianna Ottico, Ketty Russo, Olimpia Scardi, Alessandra Sini, Monica Taroni
Produzione Festival Romaeuropa, Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, Altroteatro, Teatro Petrella di Longiano