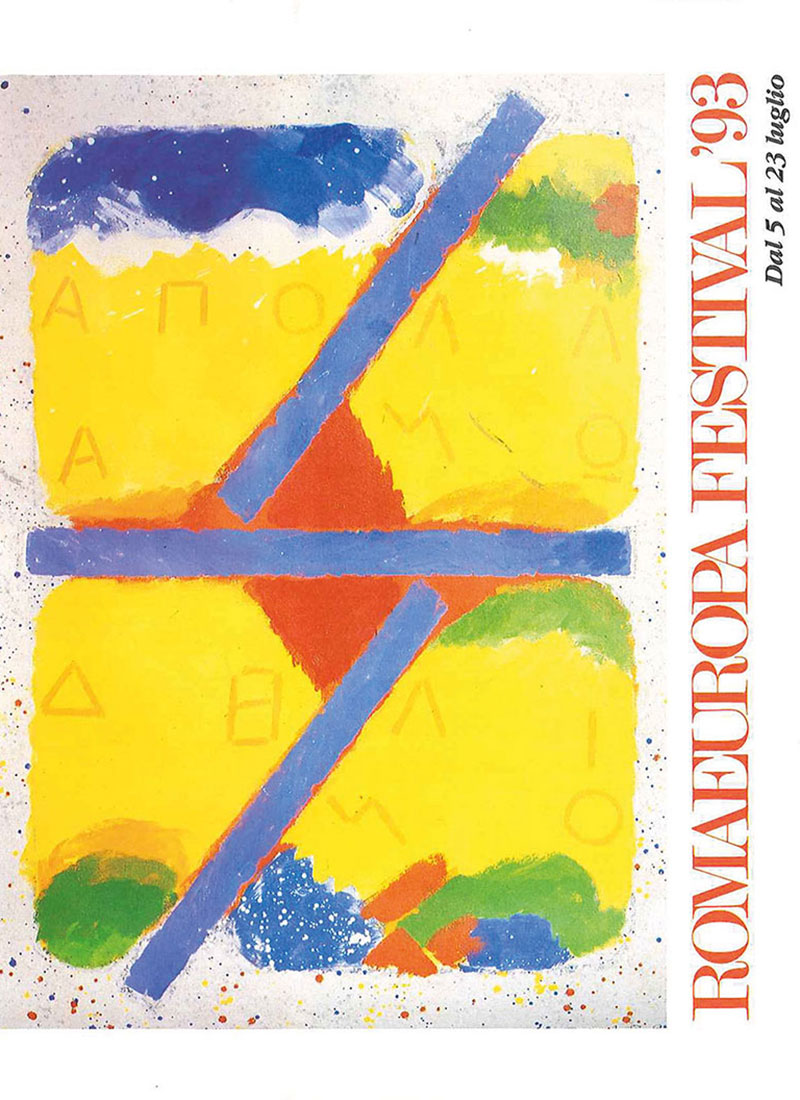Very, quarta produzione del gruppo fondato dal danzatore solista del Royal Ballet, Jonathan Burrows, si qualifica come il secondo capitolo di una analisi dei rapporti di coppia nella società contemporanea.
Se nel primo Stoics del 1991 uomini indifferenti umiliavano con gelido piacere le compagne, ora i ruoli sono capovolti, e la danza si fa sempre più spigolosa e dura. Rifuggendo da una visione rassicurante, con un linguaggio in cui la fluidità del gesto di matrice “classica” è trattata quasi con violenza ed i movimenti sono volutamente rigidi mentre i passi diventano pesanti, Burrows svela le contraddizioni di una società conservatrice: le donne lottano con l’uomo e gelide, lo ridicolizzano annientandone la virilità . Alla fine, emergono trionfanti, ma la solitudine impera, diventando incolmabile. Le note romantiche composte appositamente ed eseguite dal vivo da Matteo Fargion, stretto collaboratore del coreografo, sono continuamente messe in scacco dalla violenza delle relazioni, e si pongono quindi come un orizzonte di utopia o di sogno, comunque inaccessibile. Allo stesso modo in cui, di fronte al cortometraggio di Adam Roberts, che spia i ballerini da dietro una porta, si rimane passivi spettatori di un disagio generazionale.
Coreografia Jonathan Burrows
Danzatori Jonathan Burrows Group: Jonathan Burrows, Lynne Bristow, Deborah Jones
Musiche composte ed eseguite da Matteo Fargion
Cortometraggio Adam Roberts
Costumi Joe Casely – Hayford
Luci Peter Mumford
Rassegna stampa
“In un’originale intersezione tra danza post-moderna americana e il Teatro -danza europeo Burrows sembra quasi voler sottolineare la bellezza del brutto, ma anche voler mettere a nudo le ipocrisie e le contraddizioni della società contemporanea (specie britannica) conservatrice e antiliberale”.
(L.T., L’inquieto Burrows Group, Il Tempo, 20 luglio 1993)
“Una scena semplice delimitata solamente da una fila di lampadine. Sul fondo, ad un piano elettrico, Matteo Fargion esegue dal vivo le musiche da lui stesso composte, le interpreta anche col canto usando la tonalità alta dei castrati di settecentesca memoria: finalmente una musica che non commenta e non accompagna, ma dialoga con sapienza e misura insieme alla danza. […] I ballerini di Very un po’ monellacci, un po’ bambini passano dal riso alla rabbia, dalla carezza all’aggressività , senza soluzione di continuità , com’è proprio dell’età infantile. Come se il linguaggio e la ricerca coreografica di Jonathan Burrows andasse a rintracciare le origini dei gesti e dei comportamenti, in quella zona inesplorata dove l’istinto la fa da padrone”.
(Giulia D’Intino, I monelli danzano senza sesso, Paese Sera, 21 luglio 1993)
“In Very (1993), sulla falsariga di una ricerca che va mutando di forma ma non di contenuti, Burrows mette in scena la “brutta verità ” della vita, la impossibilità , se non momentanea ed episodica, della comunicazione interpersonale. I tre danzatori […] si rimbalzano a lungo le loro isterie, si malmenano, si strapazzano crudelmente, si lasciano narcotizzare da reiterati saltelli, cadute improvvise, gesti spigolosi, pur restando ognuno prigioniero della propria corporeità ”.
(Lorenzo Tozzi, Burrows o la brutta verità , Il Tempo, 21 luglio 1993)
LA DANZA CONTEMPORANEA INGLESE
di Elisa Vaccarino
La danza contemporanea inglese è un caso a parte nel panorama europeo. Forte e agguerrita sul piano tecnico, è stata pressoché immune dagli influssi e dalle tentazioni del teatro-danza che hanno, invece, contato molto in Francia, in Germania, in Spagna, per ricreare o creare nuovi linguaggi per nuove drammaturgie.
Il contemporary britannico è, caso mai, debitore del modern e postmodern USA; e, per come l’abbiamo conosciuto finora, tende a prediligere la forma, l’astrazione formale, il gioco sui flussi di energia, la composizione per campi plastico-pittorici in movimento.
Basta pensare a Siobhan Davies e ai suoi lavori eleganti, costruiti su ritmi interni raffinati e complessi, oppure al repertorio attuale della “Rambert Dance Company”, che va da Trisha Brown a Merce Cunningham a David Gordon a Richard Alston, che l’ha diretta. Di Robert Cohan, grahamiano doc, e del suo “London Contemporary Dance Theatre” tutti riconoscono la centralità non solo nell’elaborazione delle basi per una via inglese alla nuova danza, ma anche e soprattutto per la formazione, presso la scuola annessa, di generazioni di ottimi danzatori e, anche, coreografi.
Ma un ruolo primario lo ha svolto anche il Laban Center, che ha fatto da incubatrice a tanti nuovi talenti.
Di qui provengono “The Cholmondeleys” di Lea Anderson, ovvero due gruppi speculari, uno maschile
e uno femminile, portatori di uno humour inconfondibile, per aguzza leggerezza; e sempre dal Laban provengono i componenti di “Adventures in Motion Pictures”, con un repertorio firmato da più coreografi. Non che fossero finora assenti, in Gran Bretagna, i coreografi-autori, così come li intendiamo sul Continente, vale a dire inventori di un proprio codice espressivo per un proprio teatro, ben individualizzato, personale, nei contenuti e nelle strutture: ad esempio il ribelle Michael Clark (il sinuoso Calibano nudo e dipinto nella Tempesta di Peter Greenaway), rockettaro sbeffeggiatore del balletto classico, Laurie Booth, performer sapiente e ironico nel solco della contact improvisation (al Dartington College non è passata invano la presenza di Steve Paxton), Yolande Snaith, la più surreale e femminista, Ian Spink, oggi capogruppo di Second Stride, che lavora sull’assemblaggio di idee e immagini improvvisate dai suoi danzatori.
E ancora, il gruppo che più ha fatto sensazione, i clamorosi DV8, con la loro fisicità rude e violenta e le tematiche hard, apertamente gay.
È recente, poi, la nascita del team più giovane e più “arrabbiato” sul piano stilistico, V-Tol (“Vertical Take off and Landing”) di Mark Murphy, “parente” delle rudezze ginniche fiamminghe.
Mancava, in questo ampio ventaglio di profili e di tendenze, qualcuno che potesse e sapesse “mediare” tra la danza contemporanea e il balletto, quel balletto inglese universalmente tanto ammirato ed amato come un fiore prezioso e unico, tra narrazione e puro dialogo con la musica, tra divertimento sottile e rigore di mezzi espressivi.
A soddisfare questa esigenza profonda di “rinnovamento nella continuità ”, senza ammiccamenti modaioli, con spirito acuto ma senza sberleffi trasgressivi, con sicurezza strumentale e con spiccata capacità di raccontare, ma al modo d’oggi, ellittico e trasversale, più allusivo che dispiegato, è apparso sulle scene londinesi Jonathan Burrows , poco più che trentenne, già solista del Royal Ballet e danzatore nel gruppo di ricerca di Rosemary Butcher, figlio di un Pastore, cosciente delle sue doti di coreografo-sintesi, stuzzicante, ma non scandaloso, anticonvenzionale, ma non quotidiano né naïf né minimal nello studio e nella scoperta di movimenti originali, up to date ma non iconoclasta. Come ben dimostra il video della BBC, Far End of the Garden (si tratta della Covent Garden Opera House, ovviamente), che ne documenta la personalità e i metodi di lavoro, da lui stesso definiti, sorridendo ma non troppo, “autocratici”. Alla prima creazione, commissionatagli dal Royal Ballet nel 1980, meno di un anno dopo il diploma, che subito lo segnala agli osservatori più attenti, seguono Hymns, esercizio di osservazione irrispettosa dei comportamenti umani, in particolare maschili, elaborato con un piccolo gruppo di danzatori complici, e poi Dull Morning, sorta di viaggio privato denso di umori, e Stoics, un successo pieno che gli regala il consenso e l’interesse generale. Scegliendo come argomento la menzogna, su un sonoro accattivante, evocativo, selezionato per scherzarci sopra con maestria musicalissima, Mendelssohn, Bach, il valzer del Danubio blu di Strauss, The green green Grass of Home di Puttnam, con i ballerini, maschi e femmine, in costumi caki, simili a imprecisate divise militari (ingannevoli come ogni involucro), il neo-coreografo ha sorpreso tutti per la verve, la carica di intenso vigore, il tono polemico pieno di un garbo contropelo tutto suo, la decisa personalità di artista.
Jonathan Burrows porta a Romaeuropa ’93 il suo nuovo pezzo, Very, brano per tre interpreti, Lynne Bristow e Deborah Jones del Royal Ballett, sue compagne “di lungo corso”, più lo stesso coreografo, con musica originale dal vivo di Matteo Fargion, allievo di Kevin Volans e di Howard Skempton, e già suo abituale collaboratore, con i costumi molto fashion di Joe Casely-Hayford, le luci di Peter Mumford, uno dei maghi del lighting d’oltre Manica, e con le immagini di Adam Roberts, vincitore del Best Short Film al Festival del Cinema di Angers del 1992. E, di nuovo, Burrows tocca le corde del disagio in società , ma con dita che sanno sfiorare la tristezza nel verso della serietà canzonatoria, inquieta, intima, che sanno mostrare anche la crudeltà attraverso una corporeità secca e decisa, schietta e, se del caso, mordace. Proprio per questo suo carattere, non crede alla “mistica per cui i coreografi sarebbero creature speciali, che nascono tali, e non si possono fabbricare” e, quanto al movimento, non esita a dire chiaro e tondo che “bisogna, talvolta, essere capaci di trattarlo rudemente e che, quindi, deve essere abbastanza robusto, per questo”. Circa l’appartenenza a un’area della danza piuttosto che un’altra, Jonathan rivendica la sua libertà : “Si può dire che abbiamo avuto il balletto, la danza contemporanea, la new dance, il post-modern, il minimalismo, la performance art, il teatro della fisicità . Non manca nulla. Ma solo da questo punto in avanti le reali potenzialità della forma arriveranno a trovare una realizzazione”.
Ragazzo sagace, ribelle e contestatore, come è giusto che sia ogni giovane cresciuto in un contesto ordinato e prescrittivo, Jonathan è coreografo autentico, agile conversatore, nell’intrecciare e districare fraseggi e contrappunti per gesti, nel tratteggiare disegni nitidi e bizzarri per corpi. Discorsi trasparenti, i suoi, forse più sinceri delle parole.