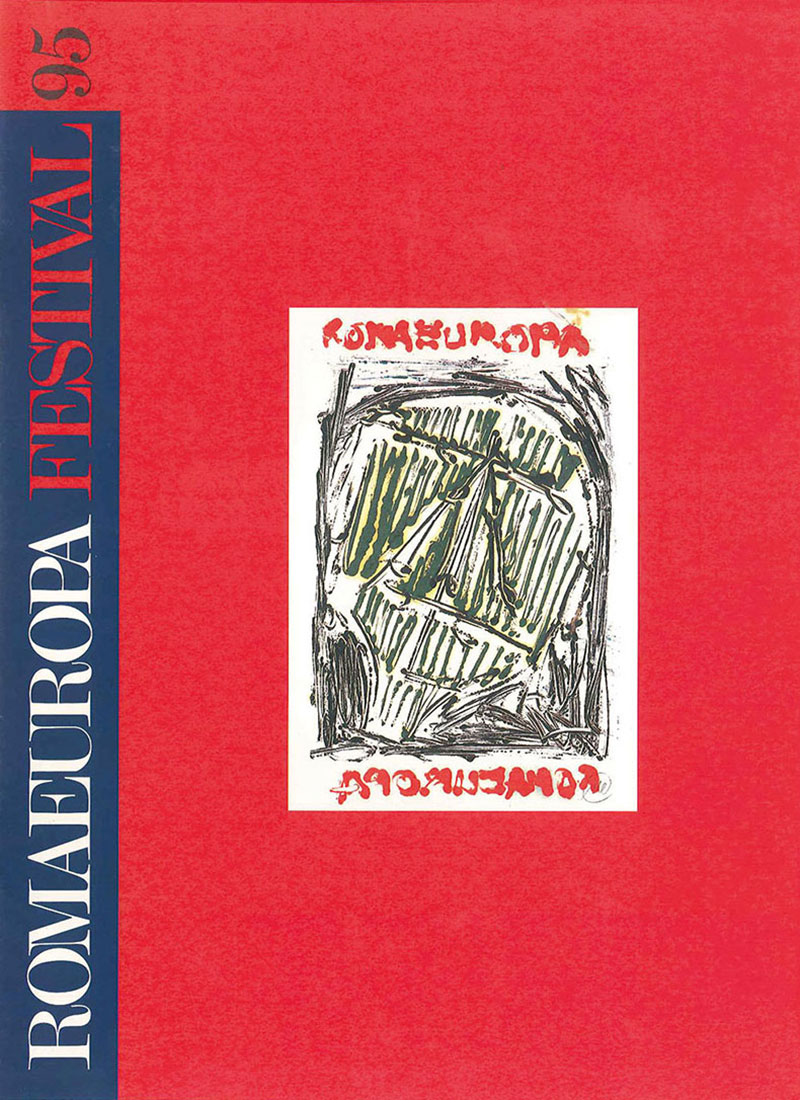Philip Glass, al suo pianoforte, ripercorre alcuni dei brani più significativi della sua ricerca musicale, dall’articolazione minima del suono, asciugata e deprivata, al recupero di un più ampio respiro “narrativo”: da brani originali per pianoforte a riarrangiamenti di composizioni strumentali e per organo, Philip Glass presenta il suo percorso attraverso il suono e la composizione, ormai ventennale. E se Opening è stata scritta per la prima registrazione dei CBS Masterwork, e la contemporanea Satyagraha (seconda opera della trilogia che comprende anche Akhnaten e Einstein on the beach) è incentrata sul tema della non violenza con chiaro riferimento alla vicenda politica ed umana del Mahatma Gandhi, Wichita Vortex Sutra (1988) ha la sua origine nelle letture di Allen Ginsberg – a cui faceva da accompagnamento – per poi diventare, solo in un secondo tempo, parte dell’opera Hydrogen Jukebox.
E poi, a chiara esemplificazione di una strada musicale che, nel corso degli anni ottanta, recupera la frase e la costruzione musicale, Glass interpreta Five Metamorphoses, cinque brani dalla più varia origine – alcuni composti per A thin blue line, un film di Errol Morris, altri per la messa in scena delle Metamorfosi di Kaflka con la regia di Gerald Thomas (San Paolo del Brasile) -, accanto ai SixEtudes, omaggio al cinquantesimo compleanno del direttore d’orchestra Dennis Russell Davies e ad Anima Mundi, dal film di Godfrey Reggio, e prodotto dal WWF.
Musica Philip Glass (Opening, 1981; Wichita Vortex Sutra, 1988; Five Metamorphoses,1989; SixEtudes, 1994; Anima Mundi, 1991; Satyagraha, 1981)
In collaborazione con Stet
Durata 105 minuti
Intervallo 15 minuti
PHILIP GLASS, FRA AUTOMATISMO E MORBIDEZZA NARRATIVA
di Mario Gamba
Certo non dev’essere un caso che un pezzo per solo piano di Philip Glass, – Metamorphosis two – si ascolti nel corso della rappresentazione di Porcile di Pasolini, uno dei più recenti (e riusciti, e conturbanti) spettacoli dei Magazzini, vale a dire del gruppo teatrale italiano di gran lunga più importante da almeno quindici anni a questa parte.
Non è un caso e significa varie cose.
La prima è che c’è ancora sintonia, come ai tempi di Crollo nervoso (1980), tra i Magazzini, Bob Wilson, il clima culturale nel quale il compositore Philip Glass è cresciuto. Bob Wilson, già . Non va dimenticato che lui e Glass costituiscono un sodalizio straordinario e che forniscono uno all’altro una credenziale sicura: se quell’inventare di azioni, immagini, forme sceniche in meraviglioso equilibrio tra astrazione visiva e allusioni a storielle, tra automatismo e morbidezza narrativa, ha potuto scegliere un musicista così per le sue principali imprese – Einstein on the beach (1975 – 1976) sopra tutte – è perché gli garantiva il più alto rendimento; e se quello scrittore di musica febbrile e struggente, metropolitana, arcaica, di strada, religiosa, monocorde, polimorfa ha potuto realizzare i suoi migliori progetti – Einstein on the beach sopra tutti – con quel coreografo, anzi con quell’architetto totale del teatro, è perché solo lui poteva fargli venir fuori una vocazione drammaturgica tanto forte quanto censurata negli anni dall’apprendistato.
Un’altra ragione della scelta di quel pezzo da parte di Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, le teste pensanti dei Magazzini, è che Porcile rappresenta bene il percorso dell’ensemble teatrale fiorentino verso la riappropriazione della parola così come Metamorphosis two rappresenta bene, magari come “opera minore” e, in genere, insieme ai lavori e alle performance pianistiche, il percorso di Glass verso la riappropriazione della vera e propria melodia, della frase compiuta, oltre il nucleo minimo di suoni da accumulare e reiterare.
Non si sa il motivo per il quale Philip Glass si arrabbia regolarmente quando viene definito minimalista. A rigore, il suo dispetto è giustificato per quanto riguarda la produzione ultima, ma solo in parte: in fondo si tratta pur sempre di una grande indagine sulle possibilità di far musica a partire da piccole particelle sonore, costituite su una struttura armonica elementare (in origine, provocatoriamente elementare), anche se vi è ammesso il principio dello “sviluppo”, quindi di una sorta di narratività , del tutto assente nelle opere del primo periodo, quello della scoperta di Glass negli Stati Uniti e in Europa. Parliamo dei primi anni ’70, durante i quali esplode l’entusiasmo di un pubblico eterogeneo per la sua musica: cultori dell’avanguardia, hippie, amanti del rock underground e dell’India. Eppure Glass nel libro La mia musica (1987, traduzione italiana 1993, Edizioni Socrates) è costretto a usare l’espressione “stile riduttivo e ripetitivo” quando descrive il carattere delle sue partiture nel periodo in questione, dalla musica di scena per Play di Samuel Beckett (1965) a Twopages (1968), da Music with changing parts (1970) a Music in twelve parts (1971 – 1974) e Einstein on the beach.
È vero che nei lavori successivi, a cominciare da Glassworks (1981) e dalle due opere liriche che con Einstein completano la trilogia sui grandi personaggi-mito della storia, Satyagraha (1980, ispirata a Gandhi) e Akhnaten (1983, ispirata a un faraone egizio del XV secolo A.C.), poi sempre più nei lavori recentissimi (un titolo per tutti: La bella e la Bestia, 1994), Glass attenua il suo radicalismo minimalista. I suoi concerti di solo piano aggiungono al quadro un che di colloquiale, proprio della nobile musica “da intrattenimento”. Ma il modo di intendere la composizione di questo cinquantottenne di Baltimora (è nato il 31 gennaio 1937) non è cambiato da quando, nel libro citato, sosteneva di aver capito all’inizio degli anni ’60 che la musica dodecafonica era “musica del passato”, che John Cage, Earle Brown e Morton Feldman erano “una boccata d’ossigeno dopo tanto didatticismo europeo”, che bisognava guardare al cinema di Godard e Truffaut, al teatro di Brecht e di Beckett, alla pittura di Jasper Johns e Sol LeWitt se si voleva fare qualcosa di innovativo in campo musicale.