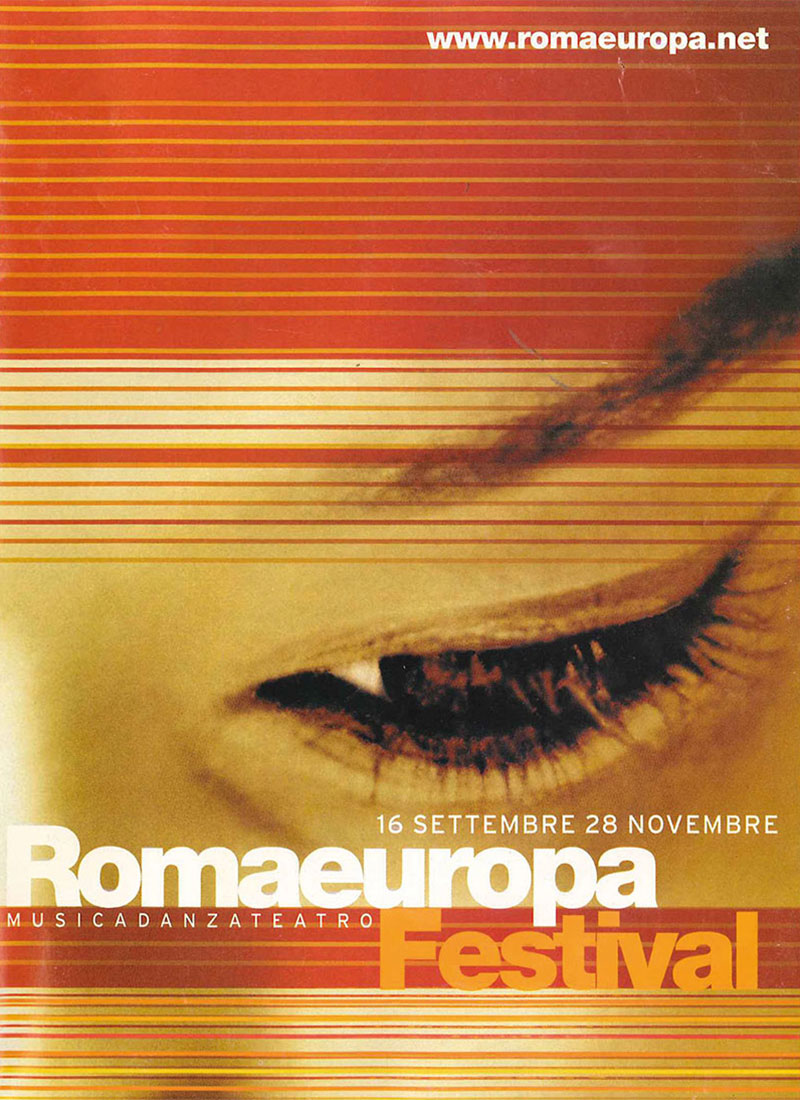Dopo ‘mPalermu e Carnezzeria, Emma Dante chiude, con Vita mia, la trilogia legata all’universo familiare della sua Sicilia. Testo dialettale, strettamente legato alla gestualità ed all’espressività del corpo, Vita Mia si presenta come una surreale e carnale elaborazione del lutto, una ricerca viscerale sulla morte perché non sia vissuta più come tabù, evento innaturale, tragedia tra santini prefiche ed ex voto. E allora questo dramma, che prima o poi rigurda ciascuno di noi, viene raccontato con tono beffardo e grottesco, fino alla negazione della sua stessa potenza. Vita Mia (l’appellativo con cui le madri siciliane apostrofano i figli) diventa così una veglia funebre senza il morto, un rito a cui sono invitati gli spettatori, in un numero limitato, ogni sera.
Sulla scena campeggiano un letto (“è un catafalco, un monolite che trascende tutto, ci si dorme, ci si fa l’amore, ci si partorisce, a volte ci si mangia e immancabilmente ci si muore”, dice Emma Dante), una bicicletta e poi gli attori e la vita, soprattutto, che diventa una corsa estenuante attorno a questo letto vuoto, un atto di ribellione di una madre che non accetta la morte di uno dei suoi figli – il preferito dei tre, il più bello. Corre la madre, corrono i figli, ed il letto rimane vuoto: finché è vuoto la vita scorre, ma prima o poi quel letto deve essere occupato ed il morto deve essere “consato” e tutti i simboli funebri devono offrirsi al necessario compimento del rito.
La madre si arrende infine, come è giusto che sia, all’inevitabile destino e veste quel corpo di bianco, per poi coricarvisi accanto con il suo vestito più bello.
PARLANDO CON EMMA DANTE
Estratti da interviste a cura di Livia Grossi, Cristina Piccinino, Tiberia De Matteis
“Emma Dante si avvicina al teatro durante una gita scolastica a Siracusa: “Restai folgorata da Antigone. Lei era ciò che volevo essere: eroica, forte e meravigliosa. E il teatro era il mezzo per arrivarci. Mia madre allora mi ha detto: se vuoi fare teatro, te ne devi andare da qui. E così a 19 anni ho preso un treno per Roma, per studiare alla Silvio d’Amico. Da timida e chiusa che ero, sono riuscita perfino a fare l’attrice. Ma il palcoscenico mi metteva troppa ansia: non era quella la mia strada. Così dopo una grande delusione amorosa con un “angelo satanico” sono tornata a Palermo. Dopo la morte di mia madre ho avuto la seconda illuminazione della mia vita e ho fondato Sud Costa Occidentale, la mia compagnia. Non avevamo un soldo e facevamo teatro “a cappello” nelle case private e nei pub. Poi nel 2001, abbiamo deciso di partecipare al Premio Scenario con mPalermu: abbiamo vinto. La nostra avventura è cominciata così. […]
Mi interessano le storie che parlano di disagi, di contraddizioni radicali. Storie che filtrano da dietro le imposte semichiuse di famiglie rispettabili, vittime del ricatto dell’apparenza. Come in mPalermu, dove un povero nucleo familiare irrigidito dalle convenzioni sociali vive in una specie di bunker, e dove il rituale pranzo domenicale diventa una cerimonia antropofoga, con i parenti cannibali che si sbranano fra loro. In Carnezzeria, invece prendo di mira l’ipocrisia della famosa regola ” i panni sporchi si lavano in famiglia”. La Scimia mette al centro una sorta di Cristo-animale: “Vivo in una terra in cui il cattolicesimo ha generato nevrosi: fede, salvezza, redenzione, peccato. L’uomo-scimmia rappresenta il contatto più vero e profondo con la terra: è il più vicino alla vera spiritualità ””.
(Livia Grossi, Provoca e colpisce al cuore con un teatro di rottura. Che sa essere universale. In lingua siciliana, Flair, 15 novembre 2004)
“I miei spettacoli nascono tutti da una matrice. Lavoro su un piccolo nucleo, la famiglia, che spesso è matriarcale. In Sicilia le donne decidono molto, mio padre firmava gli assegni, ma era mia madre che stabiliva a chi. Poi lavoro sempre sulle icone religiose, i santini, simboli che sono il mio incubo. E gli attori anche loro sempre gli stessi, con cui facciamo un lavoro di demolizione dei testi. ..
Mi sono chiesta: cosa vuol dire per una madre perdere un figlio giovane? Ho pensato più alla madre che al padre perché lo ha avuto nella carne. Ho scelto la dimensione della veglia funebre perché mi sembrava giusto che nelle storie delle mie famiglie ci scappasse il morto. In questo senso parlo di trilogia: le famiglie palermitane sono le stesse, un proletariato che continua a distruggersi”.
(Cristina Piccinino, Vita mia, il rito claustrofobico della famiglia, il manifesto, 26 ottobre 2004)
“Vita mia è il modo con cui le donne siciliane appellano i propri figli. Mi sembrava adatto a indicare il dolore di una madre che ha perso la sua creatura in tenera età e deve affrontare un dolore contro natura. Voglio proporre sulla scena la follia di chi ha perso per sempre un essere formato e cresciuto all’interno della sua carne. Come si fa ad accettare questa separazione definitiva? Ho immaginato quindi che la donna non riesca a concepire la visione del figlio morto. L’esito non può essere che il suo desiderio di coricarsi insieme a lui nel catafalco pur di non lasciarlo da solo. […] Ho cercato di prenderla [la morte, ndr] in giro per tentare di renderla più accettabile. Il meridione, da cui provengo, punta sull’esibizione del dolore e della tragedia del lutto in quanto la morte non è considerata un fatto naturale, ma vissuta come un tabù terribile. Basti pensare che quando se ne parla tutti fanno gli scongiuri. Volevo liberarmi dalla superstizione in cui sono cresciuta: i santini, gli ex voto, le prefiche pagate per piangere ai funerali costituiscono un universo tradizionale che reputo il mio incubo quotidiano. […] La morte, per esempio, è un evento straordinario con cui tutti dobbiamo fare i conti. Si prepara il cadavere in una stanza e nell’altra i parenti si riuniscono a bere il caffè. Vita mia esprime la struggente consapevolezza di questa situazione. Per metà dello spettacolo la scena è occupata da un letto vuoto, una grande struttura in ferro battuto, contenuta dentro una valigia. Il letto è l’elemento fondamentale dell’allestimento, ma anche della nostra vita. Lì si nasce, si fa l’amore, si creano i bambini, si sta malati e infine si muore. Nella seconda parte il letto viene occupato a simboleggiare la tumulazione del bambino, la cui madre cerca in ogni modo di ritardarne la scomparsa. […]
La mia idea iniziale era proprio quella di un palcoscenico alternativo, di un luogo non deputato al teatro. Ho progettato infatti una scenografia portatile: il letto di ferro su cui il ragazzino, interpretato da Giacomo Guarnieri, balla e la bicicletta Graziella con la quale ha un incidente fatale sono chiusi in due valigie. Vita mia sta tutto lì dentro e questo mi elettrizza. Nel salone di Villa Medici non si può attaccare neanche un chiodo, quindi la dotazione scenica consiste solamente nelle due valigie che ho inventato. La sintonia fra luogo e spettacolo è totale. Il mio teatro mira all’instabilità in un’epoca in cui si cerca di stare comodi. Mi piace stimolare il pubblico al valore della scomodità ”.
(Tiberia De Matteis, In teatro abbatto i pregiudizi, Il Tempo, 26 ottobre 2004)
VITA MIA
di Andrea Porcheddu
Aggiunge un tassello importante, forse il definitivo, alla ricerca sulla dimensione tragica della famiglia, la regista Emma Dante con la sua compagnia Sud Costa Occidentale. Dopo la rivelazione di mPalermu, dopo aver spiccato il volo con Carnezzeria, arriva ora all’epilogo, più tragico e straziante, con Vita Mia.
Di nuovo la famiglia, di nuovo il confronto inesorabile con la morte: questa volta, però, affrontata nell’apice della sua assurdità . Una madre e tre figli: uno di loro è morto, e deve essere preparato per la veglia. Il pubblico – un numero ridotto di spettatori – entra per partecipare alle cerimonia. E spia (ancora una volta: come in mPalermu) il dolore straziante della madre. È qui la storia, tutta qui: come accade con i lavori di Emma Dante, quel che importa è il sentimento che è sotteso, non l’intreccio. Le dinamiche relazionali più delle funzioni, gli sguardi più delle parole, le risate più dei costumi, i silenzi più della scenografia. Viene da pensare al Cassavetes di Faces, alle frenesie espressive e umanissime dei suoi attori: con Emma Dante il teatro si piega ad una comunicazione atavica, primordiale, intensissima. Allora l’elaborazione del lutto, il senso tragico della vita, viene buttato in scena senza reticenze. La madre soffre, non capisce, non accetta: e si ostina, disperatamente, a tenere in vita il figlio morto per un banale incidente.
Nulla è detto chiaramente, ma tutto si svela per passaggi delicati, per gesti, per singhiozzi continuamente repressi e spostati. La morte è là , evidente come il catafalco che costituisce l’unico elemento scenico: poi ci sono le persone, e le loro vite. Gaspare, il grande, che non trova lavoro. Uccio, un po’ ritardato, e Chicco, il più piccolo, il più vivace, con la fissazione della bicicletta che lo porterà alla morte.
Scherzano tra loro, si lanciano in una danza di maschi (come in Carnezzeria), si aggirano con i loro pigiami e ricordano banali episodi della loro vita: il carnevale, le maschere, i giochi…
Lentamente lo spettatore entra in quella famiglia, entra in quella storia, ne scopre dinamiche e tensioni: ne conosce i desideri e le sconfitte.
La vestizione in bianco del ragazzo è forse il momento più toccante: lui continua a parlare di calcio, del Palermo in serie A (come avveniva in mPalermu) mentre la madre gli abbottona la camicia bianca, gli allaccia la cravatta bianca, gli infila la giacca…
Ma tutto, in un istante, si trasforma in dolente gioco di nostalgia: fino al vorticoso sirtaki che fa sollevare e danzare il corpo del ragazzo, trasformando il catafalco in un tappeto elastico. “Si muove!”: è la negazione della morte, l’allucinata visionarietà di chi non vuole credere a quanto accade.
Ma accanto al rifiuto netto della madre di accettare la perdita, contro natura, del piccolo, vi è anche, all’opposto, come tema sotteso eppure inquietante, la totale dipendenza dei figli: l’attaccamento morboso, il cordone ombelicale perenne, il matriarcato possente e nascosto che governa la famiglia.
Questo spettacolo, che pure deve trovare un ulteriore assestamento, è un inno ostinato alla vita, un inno alla presenza, alla realtà della carne. E sono belli gli abbracci, allora, che contrastano la morte, diventata una faccenda inaccettabile, un qualcosa di inconcepibile, da sfottere con gesti volgari, o – alla fine – da condividere…
Emma Dante chiude la sua indagine sui meccanismi famigliari, sulle bigotte visioni di un cattolicesimo barocco e opprimente di un paese confessionale come il nostro, sul rituale svuotato di senso, sul perbenismo piccolo borghese: mette in scena una Palermo (un’Italia) ancora in bilico tra “nuovo” arcaicismo e disgregazione contemporanea, urla e strepita l’amarezza di chi è ai margini, denuncia le violenze e le vessazioni che si consumano, silenziosamente, nell’ombra di una casa.
Vita mia, interpretato da Ersilia Lombardo e da Enzo Di Michele, Giacomo Guarneri e Alessio Piazza, rimanda dunque ad alcuni topoi del teatro di Emma Dante: certo uso della musica (i Fratelli Mancuso, ovviamente…), certe danze, la ricerca linguistica che confermano la qualità di uno stile, pur aggiungendo poche innovazioni sostanziali rispetto ai precedenti e altrettanto struggenti capitoli di questa trilogia. Visto nell’ambito del vivace cartellone del Romaeuropa Festival 2004, lo spettacolo ha riscosso un caldo e commosso applauso.
(in, “delTeatro.it”, 29 ottobre 2004)
Rassegna stampa
“Uno studio sulla fenomenologia della morte sugli aspetti viscerali e trascendenti della morte, con una ricerca che entra nel cuore, di cerimonie profane senza tempo, traducendo l’antropologia in ballo macabro di figure meridionali, mostrando la società come un alveare stonato, ruvido, lugubre”.
(Rodolfo Di Giammarco, La veglia di Emma Dante, i non-luoghi di Pasolini, la Repubblica, 13 settembre 2004)
“Vita mia mantiene tutte le promesse che un titolo così impegnativo fa allo spettatore. Sono cinquanta minuti di rara compattezza e tensione tenuta al limite, mai oltrepassato dello spezzamento. Una madre e i suoi tre figli. Il primo perdigiorno. Il secondo mezzo scemo, il terzo è il più bello, il prediletto, su cui puntano le speranze materne anche per gli altri due. Ma proprio a lui toccherà di morire per un incidente, mentre va in bicicletta. Lo spettacolo si concentra proprio sul rito di non accettazione, di inaccettabilità della morte. Così è ogni vero pensiero sulla morte: pieno della sua inaccettabilità . Il crocefisso agitato dalla mamma un po’ bigotta contro i figli scavezzacollo, sta in capo al letto di morte, segno di un destino misterioso e muto. Toccanti al limite delle lacrime i momenti della vestizione, quando la mamma mette al figlio il vestito da morto, il suo più bello, bianco come la sua gioventù, come il sole della Sicilia, il figlio che lei vede vivo e si comporta da vivo, salta, ride, canta canzoni da stadio e non si lascia vestire facilmente”.
(Luca Doninelli, Teatro d’autore sulla tragedia di una madre, L’Avvenire, 30 ottobre 2004)
“La banale normalità del quotidiano si mescola all’evento straordinario della morte e la camicia utilizzata dal fratello maggiore per mascherarsi da Zorro a carnevale è ora il sudario dello scomparso. Ma l’immobilità del defunto è inaccettabile e i fratelli giocano con il suo corpo con l’allegoria provocatoria e spensierata dei giovani che sfidano la morte con coraggio sentendola troppo lontana per essere vera. Il desiderio materno di guardare e ascoltare il figlio come fosse vivo sembra realizzarsi in un sogno reso possibile dalla magia del teatro: il ragazzo finisce allora per ballare sul letto tra la meraviglia e l’esaltazione dei familiari che in realtà evocano con la loro “corrispondenza di amorosi sensi” quella liberatoria danza funebre”.
(Tiberia De Matteis, Più sublime più straziante la veglia al bimbo morto, Il Tempo, 31 ottobre 2004)
“È come se Emma Dante girasse vorticosamente intorno a certe costanti legate certamente al suo Sud, ma tracciando in ogni spettacolo angolature diverse, fornendo illuminazioni più profonde e articolate, riuscendo a dare a ogni singola prova scenica una particolare intensità stilistica e una cospicua densità emotiva e portando sempre i suoi bravissimi interpreti sul confine di uno stupore assorto, di un’espressività fisica perfettamente tesa tra fissità e slancio. Così è anche per Enzo Di Michele, Giacomo Guanieri, Ersilia Lombardo e Alessio Piazza, che aggiungono coloriture di costante ironia, seguendo certe verità umane ma descrivendole per astrazioni o per minutissimi dettagli di quotidianità ”.
(Antonio Audino, La vita è un sogno?No lo è la morte, Il Sole 24 ore, 31 ottobre 2004)
VITA MIA
di Emma Dante
Ma chi ci ha rigirati così
che qualsia quel che facciamo
è sempre come fossimo nell’atto di partire?
Come colui che sull’ultimo colle
che gli prospetta per una volta ancora
tutta la sua valle, si volta, si ferma, indugia-
così viviamo per dir sempre addio.
(Rainer Maria Rilke, Ottava Elegia)
Entriamo in una stanza vuota con un letto al centro. Cos’è quel letto ci chiediamo: un riparo? Una pace pigra? Un termine?
C’è un viaggio nel tempo e nello spazio attorno a quel catafalco e ciò che muove tutto è qualcosa che resterà sempre fuori dalla nostra comprensione. La stanza dove entriamo è un buco sul nulla. È il posto dove l’anima per un attimo si sospende nell’aria prima di strapparsi dal corpo.
Una madre guarda con occhi dolci e tristi i tre figli che ha di fronte e gli insegna che la vita è la cosa più preziosa, è qualcosa che fugge, passa.
La vita è una corsa attorno a quel letto.
Vita mia è il tentativo folle e disperato di ritardare fino allo stremo delle forze quest’ultimo giro prima della morte.
Chi è il prescelto? A chi tocca? Al più grande o al più piccolo? Al più buono o al più cattivo? E soprattutto perché toccherà a chi ancora non è pronto, a chi ancora non si è fermato, a chi ancora mai come ora mantiene fermi gli impulsi della vita, le idee, le scoperte, le domande, i progetti, le piccole cariche d’energia?
Tra Gaspare, Uccio e Chicco c’è un morto che deve occupare quel letto, ma la madre non vuole saperne, vacilla, si mette a sedere, piega la testa di lato e se li guarda a uno a uno i suoi maschi di casa: il grande, il mezzano, il piccolo, tutti giovani e sani, belli come il sole… Come fa a sentirlo “suo” quel figlio morto? Con quale coraggio lo porterà fra le braccia sul letto “conzato di lutto”, dopo averlo vestito e avergli bisbigliato nell’orecchio parole d’amore? Come faranno le sue gambe a non cederle inaspettatamente?
Tutto è immobile: i gesti, i ricordi, le parole di conforto, i rimorsi, quell’ultimo ritmo di pulsazione del cuore che si ripete all’infinito.
Vita mia è una veglia.
Quel letto è una nave di pietra e quella stanza è il mare che ci risucchia e sparisce.
A mio fratello Dario
Con Enzo di Michele, Giacomo Guarneri, Ersilia Lombardo, Alessio Piazza
Luci Cristian Zucaro
Produzione Compagnia Sud Costa Occidentale
Co-produttore principale Romaeuropa Festival 2004
Co-produzione Festival Internazionale Castel Dei Mondi РAndria, Sc̬nes Etrang̬res La Rose des Vents РLille m̩tropole