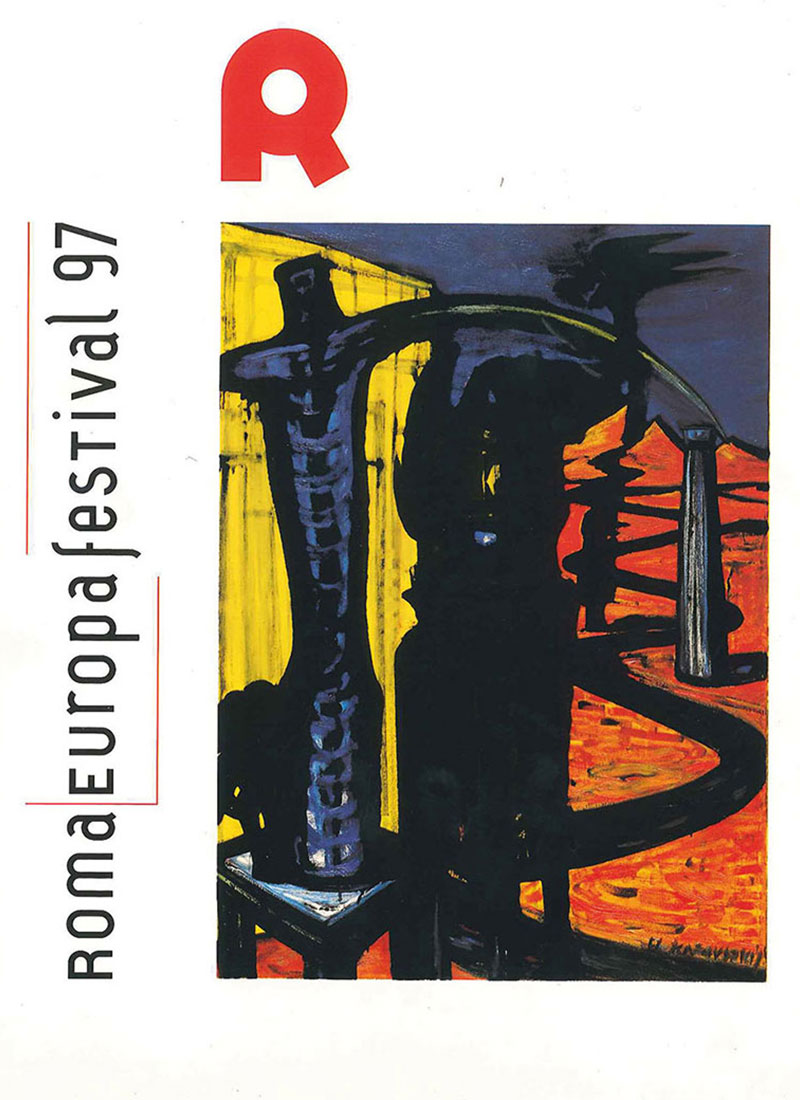Opera andalusa di cornette e tamburi
Ensemble La Cuadra de Sevilla
Ideazione, geometria coreografica, scenografia e successione drammatica della musica, direzione Salvador TûÀvora
Musica Salvador TûÀvora, Julio Vera, Rafael Soto Reyees, Josûˋ Ramû°n, Pûˋrez Soto, ûngel Manuel Cebrero Miranda, Francisco J. RodrûÙguez, Georges Bizet (estratti)
Direzione orchestra Julio Vera, Ricardo CauûÝago, Rafael Vazquez
Collaborazione documentale Javier RodrûÙguez-PiûÝero, Manuel Alcantara
Luci Pepe DomûÙnguez, Claude Corval
Costumi Creativo Fridor
Suono Juan Josûˋ del Pozo
Interpreti Lalo Tejada, El Mistela, Juan Romero
Interpreti (danzatori) Carmen Vega, Marco Vargas, Antonio Delgado, Amador Rojas
Interpreti (cavallo alta scuola) Jaime de la Puerta
Interpreti (cantanti) Ana PeûÝa, Nuria del RocûÙo
Interpreti (musicisti) Manuel Berraquero (chitarra), Joaquin Amaya (chitarra), Banda de Cornetas y Tambores Santisimo Cristo de las Tres Caidas: Julio Vera (solista), Israû¨l Jimenez (solista), Miguel ûngel TomûÀs (solista)
Produzione La Cuadra de Sevilla
Durata 105 minuti
La Carmen proposta dalla compagnia andalusa La Cuadra de Sevilla û´ lontana da quella romanzata di Mûˋrimûˋe come da quella messa in musica da Bizet, per non parlare delle tante versioni anche cinematografiche di cui la sigaraia di Triana û´ stata protagonista, prima fra tutte quella di Carlos Saura. Salvador TûÀvora, fondatore e direttore della Cuadra, mette in scena, infatti, la Carmen realmente esistita all’inizio dell’800, un’operaia libera e indipendente della Real Fabrica de Tabacos, innamorata di un poliziotto e poi di un picador (non del torero Escamillo), finita uccisa per mano del primo: rilettura dal taglio fortemente politico che fa di Carmen una sorta di orgogliosa protofemminista – “Voglio dare risalto”, dice TûÀvora, “a quella Libertû da lei ostinatamente conquistata e gelosamente difesa fino alla morte”-, l’opera di TûÀvora pesca dalla piû¿ originaria tradizione andalusa anche nella musica, affidata ai soli tamburi e cornetti della Banda de Cornetas y Tambores Santisimo Cristo de las Tres Caidas ed alle chitarre di Manuel Berraquero e Joaquin Amaya. Sul palco, oltre ad una compagnia che conta oltre cinquanta elementi, spicca il cavallo montato da Jaime de la Puerta nel ruolo del picador, in una lunga e suggestiva scena di seduzione.
CARMEN
di Laura Putti
û stato un rapimento in grande stile. Un distinto e creativo signore andaluso si û´ ripreso la sigaraia, l’ha caricata su un cavallo bianco e, via, al galoppo verso Siviglia.
Salvador TûÀvora, fondatore e regista della Cuadra de Sevilla, la piû¿ importante compagnia teatrale andalusa e una delle piû¿ importanti di Spagna, ha strappato la Carmen a Mûˋrimûˋe e a Bizet, ha restituito veritû a un personaggio troppo romanzato. Per questo la sua Carmen non scandalizza. La Carmen di TûÀvora, semplicemente, û´. Quando Lalo Tejada entra in palcoscenico û´ proprio la donna della leggenda sivigliana, û´ la sigaraia che lotta per la sua dignitû e per quella delle compagne. E, come dice TûÀvora, “vuole essere libera essendo povera, donna, operaia e gitana”. Una condizione molto difficile per l’epoca. û il 1830 quando Mûˋrimûˋe ascolta per la prima volta la storia di Carmen. Gliela racconta la contessa di Montijo, nel suo salotto. Il romanzo esce quindici anni piû¿ tardi. û una visione romantica della leggenda, filtrata attraverso una fantasia di scrittore, mescolata alle sue esperienze. La cultura gitana, lo spirito del flamenco, sono spariti. Un grande senso del peccato aleggia tra le parole. Non a caso nelle sue Lettres d’Espagne, Mûˋrimûˋe scrive: “Ah, signore mio, quella giornata e l’evocazione delle gambe di Carmen! E come Basilisa, l’eroina di Calderon, la gitana di Siviglia era piena di peccati mortali tra la vita e i reni”.
Ma Carmen non û´ una peccatrice. û una donna che si innamora, poi si disamora e si innamora di nuovo. Libera di non sottostare a un uomo, neanche se û´ il suo. Quando Carmen muore, uccisa da Don Josûˋ dopo una corrida, sulla Porta del Principe della Real Maestranza, la Plaza de Toros di Siviglia, non muore per amore. Muore per la libertû di tutte le donne. Nello stesso momento il generale Rafael de Riego difende la costituzione di Cadice, revocata nel 1814 da Fernando VII, ed entra a Triana, quartiere popolare di Siviglia, accolto come un eroe. Morirû impiccato nel 1823 a Madrid per avere votato, come deputato, per la sospensione temporanea dei poteri del monarca.
Nello spettacolo TûÀvora racconta anche la sua storia: Carmen e Riego sono per lui simboli di libertû . Nella leggenda, che a Siviglia si tramanda di generazione in generazione come fosse storia vera, la sigaraia della Real Fabrica lascia Don Josûˋ Lizarrabengoa per il picador Lucas. Nel culmine della sua opera, nell’incontro tra il picador e la sigaraia, TûÀvora restituisce all’amore una sensualitû animale. Il cavallo û´ il simbolo prescelto. û un animale grande, solenne, maestoso, ed û´ l’animale di Lucas, la continuazione del suo corpo. Carmen gli gira intorno in una danza d’amore, scandalosa per la sua epoca, ormai inconsueta per i nostri tempi affannati. û una scena conturbante. Perfino eccessiva nella sua bellezza.
Tutto il resto, nella Carmen, û´ flamenco puro, senza contaminazione. Perchûˋ Lalo Tejada û´ una grande bailaora, perchûˋ El Mistela, nonostante sia gitano (e il suo personaggio non lo era), û´ un Don Josûˋ umano e disperato; perchûˋ Ana PeûÝa û´ una cantaora che appartiene a una di quelle dinastie gitane che hanno dato al flamenco artisti importanti. La curiositû , il mai ascoltato prima, per lo meno da noi, û´ l’orchestra di cornette e tamburi. Una banda tragica, un suono non modulabile, una musica senza note. Il fiato spinto nello strumento diventa all’occorrenza melodia d’amore, urlo, marcia funebre. Non a caso la Banda de Cornetas y Tambores Santisimo Cristo de las Tres Caidas accompagna appunto le tre cadute di Gesû¿ verso il Calvario durante la Settimana Santa di Siviglia. Chissû che con la sua Carmen la Cuadra de Sevilla non riesca veramente ad avvicinarsi al flamenco, al suo duende. Non û´ musica facile per le nostre orecchie, abituate alla melodia.
TûÀvora e i suoi sono reduci da tre settimane al Teatro dell’Opera di Amburgo, con una media di milleduecento spettatori a sera.
TûÀvora su Carmen
Rassegna stampa
“Al centro dell’operazione, come d’abitudine, nei lavori di questo regista, una propulsiva voglia di libertû che riempie di energia la lettura di un “classicismo” fin troppo proposto, fin troppo interpretato. La drammatica evidenza dei personaggi, i neri e i rossi della loro psicologia, la passione che li trascina nell’affermare la loro voglia (sia essa amore, o altro sentimento dominante), giovano alla leggenda di Carmen, la ringiovaniscono, la rendono, dopo tanti abusi, di nuovo plausibile. Rimandata nel luogo in cui nacque, restituita ai ritmi e ai passi flamenchi, al cante jondo della terra d’origine, l’amante di Don Josûˋ puûý brillare in tutta la sua stranezza eversiva. […]
Salvador TûÀvora si riconferma, con questa performance fatta di pura emozione, capace di trasfigurare in carne e sangue persino l’inevitabile calligrafismo che a tratti contiene, un alchimista di gran razza, un teatrante puro, cui la schiettezza andalusa e l’enorme cultura scenica cumulata negli anni, teatro dopo teatro, consentono risultati ogni volta piû¿ originali e comunque indimenticabili”.
(Rita Sala, Carmen, energia e seduzione ritrovano il flamenco perduto, Il Messaggero, 5 ottobre 1997)
“Qualsiasi sospetto di didascalismo cade davanti alla meravigliosa sintesi di immagini, suono e gesto che la Cuadra presenta in un’ora e tre quarti di spettacolo serratissimo: un vero turbine che dal palcoscenico si rovescia sul pubblico, un avvicendarsi di grandi momenti di teatro in cui il baile flamenco comunica un legame viscerale con la terra andalusa e le sue tradizioni che sono sû˜ musica, ma anche la tradizione della carne e del sangue della corrida. Per quanto flamenco uno spettatore estraneo alla tradizione possa aver visto, û´ difficile arrivare all’intuizione del significato del cante jondo, quel canto profondo che û´ agito dal flamenco e che ne û´ il motore primario. […]
Non c’û´ niente di barbaro nello spettacolo di Salvador TûÀvora: Carmen û´ un rituale raffinatissimo, estetizzante ed estenuato pur nella violenza trattenuta dei passi dei due solisti: Lalo Tejada ed El Mistela, sostenuti da una compagnia che – tra suonatori, danzatori e cantanti – assomma 50 elementi”.
(Chiara Vatteroni, Carmen, tutta la libertû nel cuore, Il Piccolo, 5 ottobre 1997)
“La Carmen che Salvador TûÀvora ci ha sparato negli occhi e nelle orecchie in uno spazio cosû˜ tristemente neutrale come il teatro Olimpico û´ uno spettacolo violento, ancestrale, odoroso di sudore, di sesso e di incenso. û uno spettacolo che ferisce e che dovrebbe respingere, cosû˜ come respingono il dolore e l’ignoto, le forze sgarbate che rompono i nostri equilibri. Bisognava alzare i muri delle difese. Difesa fisica, prima che ideologica, una pressione delle dita sulle orecchie lacerate da un suono violento, continuo, disarmonico di cornette elevate al cielo, a gridare come impazzite un dolore atroce, e di tamburi a ritmare un’ossessiva incombente marcia funebre. […]
C’û´ qualcosa di assoluto in tutto ciûý, forse û´ questo il dionisiaco che descriveva Nietzsche, û´ questa l’essenza del mito tragico che provoca piacere nonostante il brutto e il disarmonico di cui û´ fatto. Questa prima mezz’ora brucia con la velocitû di un fiammifero, ma lû˜ û´ tutta la veritû . Il resto û´ “dûˋcor” compiaciuto, û´ la storia che riprende il sopravvento sul mito e non interessa piû¿: il velo da sposa rifiutato, il melodrammatico ingresso a cavallo (un vero bianco stallone) del picador Lucas, l’impiccagione dell’eroe della resistenza Rafael de Riego, la seguedilla di Bizet, offeso nel lacerante effetto-folklore che la sua musica meravigliosa scatena in questo contesto.
Questa irritante e fascinosa Carmen era da espungere, asciugare perchûˋ andasse diritta al cuore e allo stomaco. Non doveva piacere, doveva offendere o eccitare, far gridare o ammutolire, non applaudire”.
(Marco Spada, Il suono violento e sgarbato della “Carmen”, l’Unitû , 4 ottobre 1997)
Cartellone 1997
TûÀvora su Carmen
SU CARMEN
di Salvador TûÀvora
Me la ricordo sempre, seduta su una poltrona di vimini, con i capelli tirati indietro e raccolti in uno chignon dietro la nuca, con una grossa sigaretta tra le dita, avvolta da un fumo grigio che delineava la sua schiena ricurva, simile alle dee sfumate tra le nuvole; scrutavo il suo viso che lasciava intuire una bellezza posseduta in gioventû¿ fino all’etû matura. Viveva a Siviglia, in via Antolinez, vicino a piazza della Gavidia, e aveva piû¿ di cent’anni. Si chiamava Carmen. Era la madre di mia nonna Antonia, dunque la nonna di mia madre, Pilar Triano. Lo sguardo vispo e la destrezza delle dita ingiallite dalla nicotina rivelavano il suo orgoglio nel raccontarmi gli aneddoti sul suo mestiere. Mestiere che non avrebbe mai potuto celare, poichûˋ nei suoi gesti i segni ne erano troppo evidenti: era stata sigaraia nella fabbrica di tabacco di Siviglia. Fra tutte le storie che ascoltavo dalle sue labbra, quando ci stringevamo intorno ai tavoli apparecchiati con tovaglie pesanti che trattenevano il calore emanato dal braciere, ve ne era una che mi commuoveva sempre, e che lei stessa aveva appreso da sua madre. Si trattava della vita della sua omonima Carmen, di Triana, orgoglio delle sue compagne di lavoro per essere sempre in prima linea in tutte le rivolte contro le convenzioni sociali dell’epoca, soprattutto quelle riguardanti la libertû e la dignitû delle donne lavoratrici.
Era la storia di Carmen, la sigaraia uccisa davanti la Porta dei Principi dell’arena di Siviglia a causa del suo amore nei confronti di un picador. Era il dramma della sigaraia che visse perseguitata per aver voluto essere libera pur essendo povera, donna, operaia e gitana e che morû˜ assassinata. Rivedo ancora gli occhi della mia bisnonna pieni di tristezza mentre ripercorreva le sofferenze vissute e le ingiustizie subite. Li rivedo luminosi, verdi e radiosi quando parlava della bellezza e della seduzione di Carmen, donna simbolo della dignitû del mestiere di sigaraia; e quando parlava di una realtû cosû˜ profonda e seria come quella di Triana, dei suoi gitani, di Siviglia e dell’Andalusia prima che questa venisse trasformata in un clichûˋ deformato e deformante.
A causa di tutte queste storie che colpirono il mio animo di fanciullo, come solo i rari eventi possono segnare una giovane mente, ho sempre provato il bisogno di presentare una versione del mito di Carmen diversa da quella universalmente conosciuta grazie a Prosper Mûˋrimûˋe e a Georges Bizet, e diversa da quella tramandata dai vari racconti confusi di gitani, andalusi e spagnoli.
Lo studio paziente di documenti storici sulla vita a Siviglia dal 1800 al 1830, epoca in cui ebbero luogo gli episodi che diedero origine alla leggenda di Carmen, sedusse l’immaginazione di Prosper Mûˋrimûˋe a tal punto da portarlo a farne un romanzo: tutto ciûý rafforza in me la convinzione che sia necessario ritornare alla storia reale e ricostruirla, confrontando gli aneddoti raccontati da mia nonna con gli episodi di quell’epoca. E riscontro nel libro di Vincente Lleû° Sevilla, 1790-1868. ImûÀgenes de una sociedad dei riferimenti rivelatori: “Carmen û´ il prototipo di una nuova classe sociale, di un proletariato femminile costituito da donne indipendenti, non soggette all’autoritû maschile. E come il proletariato maschile provoca allo stesso tempo un sentimento di attrazione e repulsione per l’incredibile potere rivoluzionario e di distruzione che esso rappresenta, cosû˜ il proletariato femminile rivela in piû¿ una carica di erotismo non meno distruttrice dell’ordine stabilito e dei buoni costumi”. Si sa d’altronde che in quell’epoca, nel clima combattivo in cui vivevano e lavoravano le donne sivigliane, il comportamento vergognoso, delittuoso e frivolo di una gitana-operaia di Triana, come viene descritta dallo scrittore, non era ammissibile. Vi û´ un’enorme differenza tra la Carmen litigiosa, maga e generosa nell’offrire le sue grazie ai soldati e ai briganti nelle taverne di contrabbandieri e il personaggio di Carmen, sigaraia perdutamente innamorata di un soldato. Quest’ultimo l’aveva soccorsa durante una rissa tra gitani e poi l’aveva uccisa, poichûˋ, ferito nel suo onore di uomo e di militare, non poteva sopportare che lei, libera e indipendente economicamente, stanca ormai delle sue attenzioni, fosse divenuta l’amante di un picador.
Tutte queste riflessioni mi hanno spinto, forse per sfida, a voler fabbricare un’opera di canti e danze andaluse fuori dalle convenzioni, attingendo alle sorgenti della leggenda e del suo universo musicale d’origine. Ho voluto creare una Carmen piû¿ conforme alla personalitû della mia bisnonna, ai suoi racconti, ai suoi ricordi e ai documenti letti, rispetto alla Carmen nata dal genio letterario di Mûˋrimûˋe. Questa Carmen non ha bisogno del mio contributo: questa Carmen piû¿ volte riproposta da autori che non vengono coinvolti dalla storia dell’Andalusia, ma ne colgono unicamente gli aspetti piû¿ superficiali quali elementi tematici della loro opera. Tutt’ora la frivolezza folclorica che scaturisce dalla leggenda non fa altro che offendere Carmen e noi, uomini e donne andalusi che lavoriamo e apparteniamo alla stessa classe sociale.
La musica per tamburi e cornette (martinetes, deblas e tonas) su testi d’epoca, fa da sfondo alla cronaca oscura e indiscutibile della realtû popolare andalusa, in cui si fondono danze, rabbia, sangue, dolore, bellezza, abitudini e costumi. Questo modo di essere e di sentire degli Andalusi, dei Sivigliani, dei Gitani, che non ho dovuto apprendere poichûˋ l’ho ereditato, emergerû dalla rappresentazione di questa realtû dura e cruda, spogliata delle connotazioni folkloriche, in cui risiedono certo le origini della versione romantica ed ingannatrice, piû¿ nota al pubblico.
A partire dall’universo estetico e sonoro familiare a Carmen, che û´ anche il nostro, voglio dare risalto a quella Libertû da lei ostinatamente conquistata e gelosamente difesa fino alla morte. Attraverso questo nostro linguaggio mi avvalgo del diritto di recuperare questa leggenda, patrimonio della nostra storia, dall’operatta, divenuta un pot-pourri di briganti, furbi, pugnali, che ha cancellato l’immagine grave e austera del nostro paese.
(in Catalogo Romaeuropa Festival 1997)