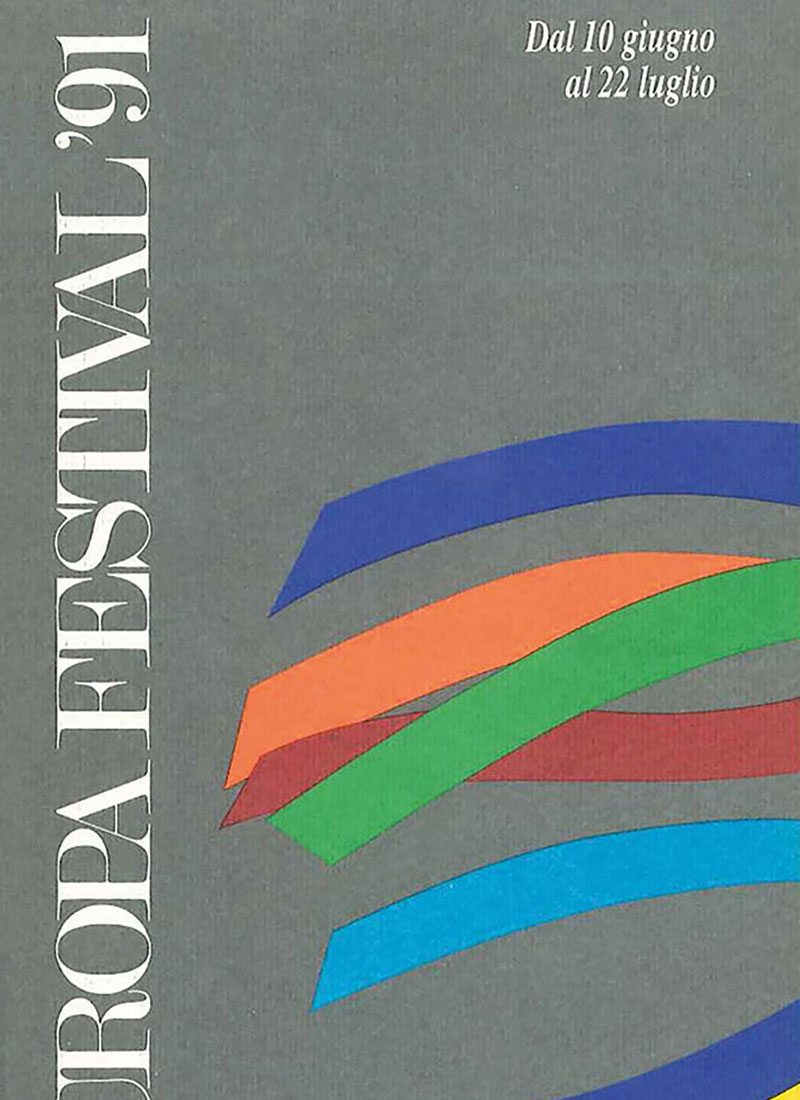Sei serate dedicate alla letteratura contemporanea in squarci di paesaggio che meglio possano far vivere i testi e ricreare quell’atmosfera di intimit├Ā che protegge la lettura privata. Il Romaeuropa Festival ha voluto cos├¼ offrire uno sguardo, personalissimo, sul variegato mondo della scrittura e per questo si ├© avvalso della collaborazione di Guy Walter, per la letteratura italiana, e Martine Bauer (Direttrice della Maison des Ecrivains) per la selezione francese.
La mise en ├®space ├© stata cura da Jean Lacornerie (segretario Generale della Com├®die Fran├¦aise) che per ogni letttura ha cercato il suo fisico luogo dell’immaginario. E cos├¼ in fondo ad un viale, in un “non luogo”, in una zona di passaggio, si ├© svolta l’immaginaria intervista con la figlia di Moli├©re, personaggio da sempre in ombra, ma tratteggiato delicatamente ne Il silenzio di Moli├©re, saggio-romanzo di Giovanni Macchia. All’incrocio di strade, a sottolineare una instancabile ricerca attraverso la scrittura, si sono alternati brani dai romanzi di Jean Echenoz (L’├®quip├®e malaise) e di Elisabetta Rasy (L’altra amante). Ai piedi della statua di Roma, i due racconti Les atl├©tes dans leur t├¬te di Paul Fournel e Dillon Bay di Daniele del Giudice, rispettivamente sullo sport e sulla guerra. Nel bosco delle Niobidi, in un intreccio tra fantasia e storia, Ma├«tres et serviteurs di Pierre Michon e La rovina di Kasch di Roberto Calasso, due romanzi che si nutrono di documenti storici, con protagonisti il pittore Watteau e il politico Talleyrand. Il tempietto di Venere ├© stato lo scenario per la storia di tre uomini innamorati di un rudere situato in un parco (La glycine di Serge Rezvani); mentre, nell’atmosfera intima della Villa, sono state ospitate le raccolte di versi Gnif Gnaf di Valerio Magrelli ed Echanges de la lumi├©re di Jacques Roubaud.
PROGRAMMA
16 luglio
Colloquio immaginario con la figlia di Moli├©re
(da Il silenzio di Moli├©re di Giovanni Macchia)
attori Rosa di Lucia, Daniel Znyk
regia Jean Lacornerie
17 luglio
da L’├®quip├®e malaise
di Jean Echenoz
attore Daniel Znyk
da L’altra amante
di Elisabetta Rasy
attore Pierluigi Cuomo
regia Jean Lacornerie
18 luglio
Les atl├©tes dans leur t├¬te
di Paul Fournel
attori Daniel Znyk, Jean-Baptiste Malartre
Dillon Bay
di Daniele del Giudice
attore Pierluigi Cuomo
regia Jean Lacornerie
19 luglio
da Maîtres et serviteurs
di Pierre Michon
attore Jean-Baptiste Malartre
da La rovina di Kasch
di Roberto Calasso
attrice Barbara Valmorin
regia Jean Lacornerie
21 luglio
La glycine
di Serge Rezvani
attori Isabelle Habiague, Jean Lacornerie, Jacques Vassalle, Jean-Baptiste Malartre, Serge Rezvani, Daniel Znyk
regia Jean Lacornerie
22 luglio
da Gnif Gnaf
di Valerio Magrelli
da Echanges de la lumi├©re
di Jacques Roubaud
attori Jean Lacornerie, Jean-Baptiste Malartre, Jean Pennec, Jacques Roubaud, Daniel Znyk
regia Jean Lacornerie
L’ALTRA AMANTE DI ELISABETTA RASY
di Guy Walter
La forte originalit├Ā dell’opera di Elisabetta Rasy ha forse due valenze: l’estrema precisione della sua frase, paradossalmente ieratica e melodica, e la crescente importanza che si avverte, da un romanzo all’altro, nella percezione dello spazio. Lungi dall’essere solo il quadro nel quale si trama un intrigo romanzesco e che la descrizione pu├▓ racchiudere, lo spazio appare come l’attore principale di ogni storia, come la possibilit├Ā stessa che possa viversi poi dirsi tra gli uomini. Lo spazio non ├© solo il luogo in cui si giocano necessariamente le relazioni, il requisito vitale dei corpi. Lo spazio ne costituisce i rapporti. Non c’├© psicologia o interiorit├Ā attiva se non nell’attualit├Ā di una relazione spaziale e ottica tra gli esseri. Tutta la gamma complessa dei sentiment├¼ non ├© che una questione di disposizione. Un sentimento ├© uno stato dei luoghi, una distanza tra i corpi, una relazione al movimento, una iscrizione nella luce, un tono di voce, un portamento. Ognuno dei personaggi si definisce dall’insieme di questi parametri. La storia che li unisce ne ├© la variazione inter-attiva.
Elisabetta Rasy inventa un nuovo tipo di racconto, quello di un orientamento aleatorio quanto necessario tra instabilit├Ā e stabilit├Ā, in uno spazio dalla geometria variabile. Raccontare una storia significa tentare di disegnare una mappa, fare delle rilevazioni. Lo scrittore ├© un agrimensore, gli tocca calcolare con il massimo di precisione l’angolo visivo, il punto d’impatto. Il reale ├© questione di organizzazione.
In L’altra amante, Madame Strohl, suo marito, l’amministratore e Stella disegnano delle figure che il narratore tenta di ricordare, individuando le fragili leggi della loro geometria. Dal movimento all’immobilit├Ā, il lettore registra e capisce. Che cosa succede in verit├Ā? Una storia si costruisce. I personaggi stanno gli uni con gli altri di sbieco, di fronte, attorno, tra, in …. altrettante modalit├Ā perch├® l’evento venga ricordato o dimenticato.
“Certo – scrive il narratore nel prologo – molti dettagli mi sfuggono – e i dati, si sa, i fatti non sono mai sicuri – non sono che un narratore di seconda mano, un maniaco frequentatore dell’usato. Del resto la ripetizione tende all’essenziale. ├ł necessario sradicare, omettere, direi dimenticare, se gi├Ā non ci fosse cos├¼ poco da ricordare. E evidentemente l’impresa ├© proprio questa, perch├® man mano che si va avanti nella ripetizione, anche le poche certezze svaniscono e la memoria perde la sua protervia”.
COLLOQUIO IMMAGINARIO CON LA FIGLIA DI MOLIERE
di Jacqueline Risset
L’opera critica di Giovanni Macchia ├© caratterizzata da una libert├Ā di metodo e da una complessit├Ā di analisi che fanno dei suoi testi delle macchine per catturare, nelle pagine della letteratura che egli decifra con la scienza erudita di un filologo e con la passione “senza maestri” di un artista, la parte d’ombra, di silenzio, di non detto. Centrali nella sua opera e per la critica moderna i suoi scritti su Baudelaire e la poetica della contraddizione, su Proust “angelo delle tenebre” portatore di luce, su Parigi, mito suscitatore di miti, sugli incontri pi├╣ fuggevoli tra arti diverse, tra opere e non-opere (i frammenti, i vuoti della follia), tra opera e vita […].
Il testo sulla figlia di Moli├©re ├© certamente uno dei rari esempi in cui il discorso critico improvvisamente – nel bel mezzo di un libro di saggi razionali e pacati – si anima, si surriscalda fino a produrre “il teatro”, come per virt├╣ propria: all’interno del volume dal titolo Il silenzio di Moli├©re sorge improvvisamente una sorta di racconto, intorno ad un personaggio che ├© forse l’emblema del silenzio. Personaggio al limite antiteatrale, o teatrale ma nascosto, per sempre, nelle quinte; personaggio pirandelliano, ombra sofferente in cerca di autore – “personaggio non realizzato” lo chiama appunto Macchia. Si tratta, come spiega il sottotitolo, di un “colloquio immaginario” tra la figlia di Moli├©re e un giovane attore, e si pu├▓ descrivere come una r├¬verie del critico […]. Costruito intorno ad un enigma crudele, quello dell’incesto, non lo suggerisce attraverso ricostruzioni filologiche, non lo spia attraverso incroci di testimonianze: lo evoca direttamente attraverso la figura di Esprit-Madeleine Poquelin, che custodisce con dolcezza, nell’ombra, un suo segreto doloroso. Tuttavia il senso del dialogo, il suo vero motore non ├© l’indagare sulla verit├Ā dell’incesto; il suo vero motore ├© la “voce” (i libelli, le dicerie) che vigila sull’infelicit├Ā di un’esistenza – quasi una variet├Ā nuova delle “ombre” che popolano le pagine del critico. Si cercano le ragioni del silenzio che costruisce l’esistenza.
Moli├©re ├© l’incarnazione del teatro; la forza del colloquio sta nell’orrore inatteso, espresso da un personaggio simbolo dell’inespressione, verso il mondo del teatro, minacciosa passione di un essere amato e ammirato[…]. Il silenzio di Moli├©re ├© anche questa presenza, in questo eccesso della malinconia nel cuore stesso del riso.
DANIELE DEL GIUDICE
di Martine Van Geertruyden
Nel romanzo Lo stadio di Wimbledon – storia di un’inchiesta condotta dal narratore su un uomo morto in odore di letteratura senza mai avere pubblicato nulla – Italo Calvino aveva immediatamente riconosciuto un “nuovo approccio alla rappresentazione, al racconto, secondo un nuovo sistema di coordinate”.
Daniele Del Giudice ├© affascinato dai rapporti tra persone e oggetti e dalle mutazioni che la tecnica ha portato, secondo lui, nella sensibilit├Ā e nell’immaginario. “In un mondo dove tutto ├© visibile – dichiara l’autore – quello che m’interessa ├© il confine sul quale si crea un nuovo invisibile, cio├© un mistero. Una parte del non-visibile, ci├▓ che si potrebbe chiamare il non-visibile di “grado zero”, ├© costituito dalle immagini che non vediamo pi├╣… perch├® il nostro sguardo non le trattiene pi├╣”.
Evocare l’invisibile e i sentimenti prodotti dalla nuova soglia tra visibile e non-visibile, questa ├© indubbiamente la passione che anima buona parte dei suoi personaggi. Il lavoro di Brah├®, il giovane fisico di Atlante occidentale, consiste nel vedere, con l’aiuto di strumenti sofisticati, gli oggetti del futuro nascosti oltre la soglia della materia normalmente percettibile; mentre il suo amico scrittore Epstein ha smesso di scrivere, convinto che gli basta la visione perch├® la trama subito si formi e si esaurisca.
Barnaba, il protagonista del Museo di Reims, sta perdendo la vista e decide di memorizzare alcuni quadri come ultime immagini. Finisce col ritrovarsi in una posizione privilegiata per afferrare una possibile verit├Ā dietro la luce e le cose.
Per quanto riguarda gli eroi di questo racconto militare, Dillon Bay, scritto nel 1985 (quasi una premonizione sul conflitto nel Golfo) la guerra che fanno ├© diventata invisibile, “senza nemici, n├® fortezze concrete, una guerra di pure traiettorie, dove il tempo non si misura pi├╣ in giorni e notti ma in millesimi di secondi, e dove lo spazio si riduce o si piega come nella relativit├Ā”.
ECHANGES DE LA LUMI├łRE DI JACQUES ROUBAUD
di Jacqueline Risset
I primi testi di Jacques Roubaud, poeta e matematico appartenente all’Oulipo di Raymond Queneau (e all’interno dello stesso gruppo, pi├╣ vicino a P├®rec e Calvino) erano sperimentali e lucidi. Consistevano nella rigorosa descrizione della loro stessa organizzazione formale. Ad esempio, Epsilon, del 1967, consisteva in 361 poemi corrispondenti alle 180 pedine bianche e le 181 pedine nere del gioco di “go”, leggibile secondo quattro modalit├Ā di lettura, peraltro indicate nella stessa regola del gioco del libro. Trente et un au cube, del 1973, era composto da 31 poemi di 31 versi su 31 piedi ciascuno, regolati dalle costrizioni del tanka e delle haiku giapponesi.
Tutta l’opera di Roubaud, da quegli anni in poi, ├© in qualche modo sdoppiata e accompagnata da una riflessione sulle costrizioni della forma poetica (ad esempio sui trovatori in La fleur inverse e pi├╣ recentemente sul sonetto in Soleil du soleil). Il libro Quelque chose noir, stravolgente dialogo con la parola di una donna amata e scomparsa, insieme al romanzo composito intitolato Le grand incendie de Londres, segnano indubbiamente una sorta di ampliamento progressivo quanto imprevedibile […]. Eppure qualcosa di ricorrente emerge ovunque in questi testi: si tratta della presenza in sottofondo di una pluralit├Ā di voci e dell’enigma della loro congiunzione.
Echanges de la lumi├©re, versione contemporanea del dialogo filosofico, incontro notturno sulla definizione della nozione di luce – luce filosofica e scientifica ma altrettanto teologica e poetica – risulta un complesso tessuto di citazioni di varie epoche e provenienze. Anche qui affiora il gioco. Ma con il gioco, portato dal gioco, sorge la folgorante bellezza della parola nel suo stato di pensiero attivo, nel suo sforzo multiplo per catturare il reale che si ritrae: assieme poesia e teatro, nati in qualche modo da loro stessi, sboccio luminoso del movimento umano che tende verso la conoscenza, la cui metafora ├© la luce.
L’├ēQUIP├ēE MALAISE DI JEAN ECHENOZ
di Pierre Lepape
Gli anni ’50 si possono cogliere nelle foto di Doisneau, gli anni ’60 nei film di Godard, gli anni ’70 nei quadri di Warhol. Per gli anni ’80 ci vuole Echenoz e i suoi libri: nell’ultimo decennio, uomini e donne, paesaggi, oggetti e persino animali hanno assomigliato alla scrittura di Jean Echenoz.
├ł da un bel po’ che gli scrittori realisti diffidano della scrittura e della realt├Ā. Sanno che le parole non sono le cose. Da Flaubert in poi il romanzo vive in un conflitto spesso teso tra immensit├Ā del reale e finitudine del linguaggio. Negli anni ’60 il “nouveau roman” aveva tentato una soluzione del conflitto, distruggendo ci├▓ che fino ad allora veniva chiamato letteratura.
Echenoz non ha voluto scegliere tra i Don Chisciotte della teoria e i Sancho Pancia del romanzo casareccio, ha scelto la via trasversale, ha messo le idee alla prova dei fatti, preferendo la distanza, il piccolo passo laterale, l’ironia e la discrezione. Negli abissi della sua memoria elettronica, egli ha ingoiato non solo la realt├Ā del suo tempo ma persino le maniere, le tematiche, le invenzioni, le retoriche di tutti quelli che credono di saper raccontare perfettamente le storie: fa il verso ai seguaci di Jules Verne (Le m├®ridien de Greenwich) agli autori di gialli (Cherokee), agli scrittori d’avventura (L’├®quip├®e malaise), ai maestri dello spionaggio (Lac). Ma di questi modi di dire Echenoz trattiene soltanto la grazia, la curvatura, l’apparenza, eliminando accuratamente invece tutta quella costruzione di certezze bugiarde. Finita l’avventura nasce il malessere.
Echenoz non afferma nulla, non afferma nemmeno che non sta affermando nulla: ├© il romanziere del senso sospeso, del dogma demolito con un sorriso, dello spazio destrutturato e del tempo galleggiante. Prima di lui, nel romanzo come nella societ├Ā, la periferia ubbidiva al centro. Il centro cambiava volto (Dio, l’uomo, la natura, la storia, il destino, l’utopia) ma continuava a comandare e legittimare le manifestazioni della periferia. Echenoz prende atto del fallimento dell’ancestrale subordinazione: non vi ├© pi├╣ centro, viviamo nelle periferie dello spirito, un po’ citt├Ā, un po’ terrain vague, un po’ dormitorio, un po’ cimitero, un po’ fabbrica, un po’ villeggiatura, agglomerati instabili di popolazioni incerte e di individualit├Ā, in cui pensieri, sogni, fantasmi e comportamenti ubbidiscono solamente a una logica stanca e logora, alla morale dello “zapping” e delle passioni in cantiere permanente.
Si potrebbero scrivere interi drammi su questa atomizzazzione, tragedie su questa solitudine, lamentos su questi slittamenti di terreno o sullo svanire di ogni riferimento stabile. Ma la grandiloquenza ├© alleata al militantismo. Al decentramento invece, all’era del vago, all’epoca delle precisioni arbitrarie e dei significati erranti, corrisponde questa scrittura ellittica, giocosa, trasognata, questi trompe-l’oeil sapienti, queste inutili entomologie, queste metafore in contropiede, questa limpidezza del racconto che avvolge nelle sue acque dolci, con uguale tenerezza, con uguale quiete, personaggi e oggetti, paesaggi e musiche, parole e residui urbani. Nulla galleggia, tutto ├© scenografia.
PAUL FOURNEL
di Martine Bauer
Essere stato alla testa di una grande casa editrice francese; dirigere le prestigiose edizioni Seghers; partecipare attivamente al sapiente gruppo di ricerca (e di piacere) chiamato L’Ouvroir de Litt├®rature Potentielle; oppure essere tra i pionieri del rilancio del racconto francese e tra i pi├╣ illustri praticanti del genere: si, ├© possibile fare tutto ci├▓ e trovare anche il tempo di amare lo sport!
├ł possibile essere sportivi e scrittori nello stesso tempo.
Lasciamo raccontare da Paul Fournel stesso come, da sempre, hanno fatto parte della sua vita l’esercizio della parola e la cultura dei muscoli: “Lo sport preferito dei miei compagni di liceo era l’esonero dalle lezioni di ginnastica. Tutto diventava pretesto per sottrarsi a quelle quattro miserevoli ore di esercizi settimanali e trasformarle in pesanti ore di studio. I pi├╣ furbi, con l’aiuto dei genitori, inventavano mirabolanti scuse e si attribuivano raffreddori ed angine croniche per meglio offrire alla matematica il tempo riservato ai muscoli ed al gioco. Era quindi normale che un ragazzo sportivo passasse per cretino. Per me che amavo lo sport quanto lo studio, la tenaglia si stringeva sempre pi├╣, ad ogni occasione: quante volte, nel duro anno di preparazione al concorso della Normale Sup├®rieure, mi sono ritrovato, da solo, a fare rimbalzare il pallone sotto il canestro? E quanti giorni di footing solitario mi sono imposto lungo i muri del cortile d’onore? Quel segreto giardino muscolare che coltivavo con cura, ogni domenica mattina sulla mia bicicletta, avrebbe potuto destinarmi al clan dei cretini o perlomeno allo sdoppiamento, se non fosse stato, ogni anno, per quel punto d’incontro meraviglioso tra il mio amore per la letteratura e la mia passione per la bicicletta: il Tour de France. Quel magnifico feuilleton, con i suoi eroi, i suoi cattivi o traditori, il suo stile, i suoi modi; con i suoi uomini di secondo piano, i bari, le scene madri e i ribaltamenti di situazione […]. Ogni mese di luglio mi porta la serenit├Ā: il corpo e la mente si uniscono a dimostrare che tutto ├© spirito nei muscoli e tutto ├© muscolo nel cervello e che i grandi atleti sono innanzitutto atleti nella loro testa”.
SU LA GLYCINE
di Serge Rezvani
Questa “piece” ├© una sorta di “fatto di cronaca” estetico. ├ł la storia di un “capriccio” architettonico, storia della sua scoperta, della sua resurrezione, della sua morte.
Tre uomini si innamorano di un rudere in mezzo ad un parco abbandonato. Si tratta di un “capriccio” italianeggiante del secolo scorso. Il primo (Landor) si stabilisce nelle vicinanze del luogo e si accontenta di contemplarlo. Il secondo (Ellison) desidera ci├▓ che il primo possiede solamente nell’immaginazione e cos├¼ ne diventa l’acquirente. Il terzo (Silvio, il Fauno) s’identifica con il “capriccio”, lo restaura. Lo fa rivivere fino a perdere la ragione, a morire per esso e con esso.
Questa ├© la posta in gioco, il luogo del gioco.
Si pu├▓ possedere la Bellezza? Chi possiede la Bellezza? Colui che la contempla? Colui che ne diventa proprietario? Oppure colui che la plasma e la trasforma?
In La Glycine Landor, contemplando il luogo, ne ├© trasformato. Ellison, che se ne appropria tramite il denaro, compra qualcosa che non riuscir├Ā mai a capire. Quanto a colui che al “capriccio” d├Ā la vita e l’anima, vi si perder├Ā.
I tre personaggi de La Glycine hanno una preesistenza letteraria. Provengono da tre racconti di Edgar Allan Poe: Landor ├© tratto da Villa Landor, Ellison da Il dominio di Arnheim, Silvio da Tre bestie in una.
SU GNIF GNAF
di Valerio Magrelli
I testi presentati nel corso di questa lettura sono stati composti a partire dal 1987. Si tratta di poesie, traduzioni e prose, via via pubblicate su giornali e riviste. L’idea di riunirle nel presente spettacolo nasce dall’interesse per un tipo di scrittura ibrido, contagiato, sporco, spurio. Non prosa poetica, dunque, ma un “libro ornitorinco”, per usare un’espressione del musicista Carlo Boccadoro. Da qui la scelta di un titolo doppio e onomatopeico.
Gnif Gnaf l’antico nome di un paese dell’Agro Pontino infestato dalla malaria e cos├¼ chiamato dal rumore dei passi nel fango, mi sembra rendere bene l’ironica ed irrisolta opposizione-apposizione di prosa e poesia, testa e croce, yin e yang, pari e dispari. Un simile progetto, d’altra parte, riflette quello slittamento che avevo perseguito nel passaggio dalla prima alla seconda raccolta delle mie poesie.
Gnif Gnaf costituisce appunto il seguito di questo percorso, caratterizzato da una spiccata attrazione sia verso materiali non strettamente poetici (reportages, recensioni, resoconti), sia verso tecniche e forme compositive tradizionalmente associate a un genere basso (poesia d’occasione, testi su committenza). ├ł la spola dei versi scardinata, la molla rotta, la macchina inceppata, il vecchio giradischi che si incanta e seguita a girare, “rimando” con se stesso.
GNIF GNAF DI VALERIO MAGRELLI
di Jacqueline Risset
Tra i giovani poeti italiani “post-sperimentali”, a volte chiamati “dionisiaci” o “della parola amorosa”, Valerio Magrelli si ├© presto distinto per via di una particolare tenuta stilistica. Nel suo primo libro dal titolo latino, Ora serrata retinae, la geografia dell’occhio era da lui esplorata, o meglio suggerita, con una lievit├Ā trasognata, una sorta di tranquillit├Ā dell’approccio in cui la prosa filosofica dei secoli scorsi si amalgamava (senza stento, senza ritardo, senza urto) con la pi├╣ attuale espressione della crisi di frantumazione dell’io – evento cos├¼ lampante, cos├¼ presente nelle pagine di Magrelli da assumere una certa familiarit├Ā ironica, una sorta di dolcezza.
In questa prima raccolta, la frequentazione degli scritti di Francis Ponge e di Paul Val├®ry si fondeva con l’attenta lettura dei pi├╣ impercettibili movimenti del corpo umano, e quella dell’enigmatica presenza degli oggetti, di fronte alla “tappezzeria, del pensiero”. Pi├╣ tardi, in Nature e venature, si precisava per Magrelli il dialogo tra la calma e la frattura segreta.
Per quanto riguarda Gnif Gnaf, l’eterogeneit├Ā dei materiali (con onomatopee dei passi nel fango, con ripresa ironicamente degradata delle auliche antitesi simboliche notte / giorno, yin / yang, poesia / prosa, ecc…) ├© ripresa e metaforizzata nel corso del testo tramite l’attivit├Ā paradossale e “adolescenziale” del fumatore, l’immagine della “impresa di traslochi”, oppure lo stupore di fronte alla voce che nasconde “l’osso del tempo”, di fronte al “contagio” e all’energia contraddittoria della “natura”. Come se, rispetto alla scrittura silenziosa, l’emergere del teatro, o della teatralit├Ā, stesse a indicare il “rumore”, il sorprendente, l’indomabile.
IL LIBRO “IN SCENE”
Prima di tutto vi sono due percorsi incrociati: l’uno (tracciato con la complicit├Ā di Guy Walter) attraverso la letteratura italiana contemporanea, l’altro (qui, la complicit├Ā ├© quella di Martine Bauer) attraverso la letteratura francese contemporanea. Tra i due percorsi s’istaura un gioco di corrispondenze tra lingue (italiana e francese), stili, forme, tematiche.
Poi vi ├© un altro percorso, quello nei giardini di Villa Medici. Ho intrecciato insieme i tre fili e individuato per ogni testo lo spazio d’ascolto pi├╣ idoneo. Persino la pagina che meno si presta ad essere detta ad alta voce trover├Ā qui il suo posto, in un luogo appartato che le restituir├Ā arricchito il proprio segreto.
Cos├¼ mi si ├© imposta la sequenza dei testi, in funzione dei luoghi che scoprivo. Vi ho visto la scenografia ideale che, assieme agli attori, tenteremo di abbozzare nel corso di queste letture “in scene”.
Jean Lacornerie
(in Catalogo Romaeuropafestival 1991)
La “cospirazione”
La presentazione incrociata di dieci scrittori italiani e francesi , nell’ambito del Festival Romaeuropa 1991, ├© la resultante di una “cospirazione”, fatta di conversazioni sottovoce, incontri discreti e riscontri di aspirazioni comuni: poco a poco i “congiurati” hanno elaborato il loro piano, reclutato seguaci e militanti finch├® la “cosa” ├© scoppiata alla luce del giorno. Tant’├© vero che per mostrarsi, la letteratura adora travestirsi.
Trattandosi di un Festival dello spettacolo, erano necessari spazi scenici e presenze fisiche, per far vivere i testi. La prima “alleanza” quindi e avvenuta tra gente del libro e del teatro. Volendo offrire un panorama limitato ma equo tra i vari generi letterari, dovevamo evitare la scelta sistematica di testi scritti per il palcoscenico. Ma questo implicava il rischio, che ├© stato deliberatamente assunto, di rendere sonori e visivi dei testi nati per nutrire un rapporto silenzioso tra la pagina e il lettore. Non ci ├© apparso vano cogliere, nel passaggio da una lingua all’altra, gli accenti e i gesti, spesso inconsci, che accompagnano la parole.
Da una lingua all’altra, dicevo: gli autori invitati sono stati tutti tradotti, nell’editoria. Eppure abbiamo optato per una presentazione delle opere nella loro lingua di origine. Anche se certe sfumature del testo rischiano di sfuggire ad alcuni spettatori, non ├© troppo temerario ipotizzare che la comunicazione comunque “passer├Ā” tra due popoli cos├¼ vicini e da tempo allenati a capirsi con una mezza parola. A costo di incorrere in eventuali malintesi. Ma conosciamo le astuzie dei malintesi e lo humour che spesso li accompagna.
Vi erano altre trappole da evitare. Per tradizione l’Italia predilige, tra i testi francesi, la saggistica, mentre gli editori francesi si dilettano essenzialmente a tradurre la narrativa italiana. Qui invece abbiamo tentato di illustrare unitamente, cio├© con un italiano e un francese, alcuni generi letterari praticati naturalmente nei due paesi. A guardarli da vicino, si intrecciano delle reti precise tra tante voci che armonicamente declinano gli stessi temi, lasciando a noi, spettatori, soltanto l’imbarazzo della scelta.
L’ultima fase della “cospirazione” per portare a termine questa settimana letteraria riguardava non tanto le persone quanto la volont├Ā congiunta di pi├╣ istituzioni: prima di tutte il Festival Romaeuropa che ha scelto Villa Medici – luogo che incanta sempre – come scenario per questi appuntamenti; la Maison des Ecrivains e la Villa Gillet di Lione, che hanno unito testi e autori; la Com├®die Fran├¦aise che far├Ā di questa unione uno spettacolo; l’Ambasciata di Francia in fine, che vorrebbe prolungare questa prima iniziativa con incontri successivi… se altri “complici” italiani accetteranno di entrare nel gioco.
Interferenza di onde
Tra la tenebrosa distanza dell’una e l’aerea luminosit├Ā dell’altro, sono scarsi i rinvii a qualche parentela. Elisabetta Rasy di primo acchitto immerge il lettore in una specie di gravit├Ā. Jean Echenoz invece sorride.
Eppure i due si somigliano, per via di quel particolare modo che hanno di collocarsi nel mondo: un po’ lontani da tutti e vicinissimi a ci├▓ che si avverte come inafferrabile e universale. L’enunciazione di saperi frammentari, l’ascolto del tempo che scorre, l’alternanza ritmica di silenzi e di astuzie, questa attitudine al tempo stesso modesta e acuta, si traduce sul piano letterario in una immensa generosit├Ā: sbarazzata da qualsiasi intralcio, la scrittura parte per una grande avventura, senza prevederne il risultato.
Sar├Ā estasi o prodezza, comunque al lettore toccher├Ā sbrogliare la matassa. A meno che, fiducioso, egli preferisca lasciarsi catturare da intrighi che in tutta evidenza non si riducono ad una singola soluzione.
La corsa contro il tempo
Per fortuna l’Italia non ha vissuto il lungo periodo in cui, in Francia, il racconto divenne un genere bandito. Negli anni ’70 infatti aveva subito gli effetti della letteratura “testuale”, cio├© l’esilio del raccontare – che fosse asciutto o diluviale – nei territori molto sospetti dell’ingenuit├Ā.
Eppure ├© senzaltro tramite il racconto che ├© tornato in auge il romanzesco. E con la nuova ondata, i “novellisti” francesi hanno avuto modo di rivendicare come statuto per i loro testi, non quello di variazioni nella scia di pi├╣ rilevanti opere ma quello di creazioni compiute, cos├¼ come avviene nella letteratura americana e italiana.
Molte direzioni, allora, si sono aperte. E se Daniele Del Giudice, preparato da una lunga tradizione, assegna ampi spazi al dispiegamento delle sue storie, Paul Fournel invece esercita tra confini piu stretti l’arte di racchiudere la trama. Tra i due scrittori vi e un punto in comune, che forse costituisce il racconto in quanto tale: la precisione del particolare, la cura del meccanismo nei suoi minimi ingranaggi, il gusto di raggiungere, e al pi├╣ presto, il cuore dell’orologeria.
Che sia di trenta o tre pagine, cos├¼ concepito il racconto corre alla velocit├Ā del lampo ed esibisce, con puntigliosit├Ā post-moderna, l’ossessivo tormento dei suoi congegni.
Gli apprendisti stregoni
Cos├¼ come un tempo si parlava di “folli del re”, si potrebbero definire Pierre Michon e Roberto Calasso “folli del letterario”. Se ├© vero che i loro libri enunciano, frontalmente, certe verit├Ā su certe storie, si tratta per├▓ di verit├Ā paradossali su storie sproporzionate. In altre parole, non sono il grande o il minuscolo, il breve o il durevole, l’importante o l’irrisorio, i parametri delle loro investigazioni.
Investire un essere, genio o anonimo che sia, vedere in lui il prisma dei suoi desideri, identificare le sue mosse, dispiegare il suo tempo interiore: tale ├© il metodo adottato da questi nuovi demiurghi nel loro lavoro contro l’oblio, per trovare nell’uomo l’uomo, per dirne la gloria e la potenza, e soprattutto per non risparmiarlo in nulla.
Che ci sia qualcosa di un po’ mistico in questo modo di cogliere il mondo, ├© probabile. Ma chi oserebbe sostenere che la fede nella letteratura non ├© in grado di spostare le montagne?
Martine Bauer
MAÎTRES ET SERVITEURS DI PIERRE MICHON
di Martine Bauer
L’autore di Ma├«tres et serviteurs non ├© uno specialista di pittura: ne critico d’arte, ne storico, neppure cultore. Ha solamente ritenuto che storie di pittura, o meglio di pittori gli avrebbero permesso forse di meglio formulare le domande che sono all’origine di ci├▓ che lo fa scrivere: egli si ├© chiesto quale strano amore, o quale odio verso il mondo, spinge alcuni a rappresentare il mondo; e per quale gioco di prestidigitazione la scelta di rappresentare o duplicare ha come corollario una deliberata assenza rispetto al mondo. Pierre Michon ha messo in scena le ambigue relazioni che, nell’ambito di una stessa persona, la volont├Ā creatrice intrattiene con altre funzioni, meno presuntuose e pi├╣ condivise, l’ambizione, la consapevolezza, il libero arbitrio, l’avidit├Ā, la fede, la buona volont├Ā. Ha voluto parlare anche della vanit├Ā, o irrealt├Ā, che il nostro tempo professa alle arti; ha voluto affrontare il disgusto che tale devozione puo provocare in chi proprio di questa devozione vive, essendone al contempo grande sacerdote e profanatore in carica: l’artista, pittore o scrittore.
I nomi dei pittori – Van Gogh in Vie de Joseph Roulin, Goya, Watteau e Piero in Ma├«tres et serviteurs – sono per noi, “devoti” del 1990, pretesti per una mitologia prolissa. ├ł da queste favole culturali che ├© partito l’autore, senza preoccuparsi dell’esattezza storica. Ma, tramite la semifinzione e il confronto tra nomi incontestabilmente grandi e piccoli personaggi incerti, spera di aver restituito a questi nomi, per un attimo, un po’ dell’incerta esistenza carnale che fu loro, prima delle grandi certezze della posterit├Ā.
LA ROVINA DI KASCH DI ROBERTO CALASSO
di Pietro Citati
Talleyrand ├© la deliziosa calamita attorno alla quale si raccolgono capricciosamente molti temi della Rovina di Kasch. Calasso ├© affascinato dalla sua eleganza, dal suo cinismo, dalla sua perfidia; dalla ineguagliabile qualit├Ā di metamorfosi, che gli rendeva possibile adattarsi e piegarsi a tutto, conservando la punta adamantina dello stile; dalla capacit├Ā di scivolare, con la grazia ironica di un’anguilla principesca, attraverso i disastri della storia. Ma, per lui, Talleyrand ├© molto di pi├╣. Egli ├© persuaso che la Rivoluzione francese sia ancora oggi il laboratorio e il modello dei tempi moderni: dal 1789 al 1814, con un immane sforzo, la storia universale ha cercato di produrre una tragedia greca con migliaia di personaggi e coro ed ├© riuscita soltanto a congegnare una serie di farse (sia pure sanguinose). Dopo di allora gli eventi non fanno che ripetere la Rivoluzione. Ne riproducono questa o quella fase; e cercano di correggerle; e da questa ripetizione il tempo moderno riceve il proprio carattere fantomatico – non pi├╣ fatti ma apparenze di fatti, non pi├╣ idee ma apparenze o menzogne di idee.
[…] All’improvviso, con un gesto non sappiamo se da grande maestro di cerimonie o da guitto, Talleyrand si allontana in punta di piedi dalla scena. Anche il suo emulo Sainte-Beuve tace; ed entrambi lasciano il campo alla storia della “Rovina di Kasch”, che introduce una teoria del sacrificio. Calasso incarna come nessuno il paradosso di molti fra noi. Egli ├© completamente estraneo alla realt├Ā mitica, vive a suo agio soltanto nel mondo dissacrato della citt├Ā moderna, in quel Palais Royal di cui ha fatto giustamente il simbolo del nostro pensiero; eppure solo il mito l’attrae, l’affascina e occupa la sua mente. Dal mondo mitico, egli ha tratto con straordinaria duttilit├Ā lo strumento essenziale della sua intelligenza: la qualit├Ā analogica, il senso delle connessioni simboliche, l’intuizione dell’interdipendenza universale delle cose.
Calasso ha una vera passione per gli aneddoti che […] sono, per lui, il punto dove la storia universale perde la sua oscura compattezza e la verit├Ā si rivela di colpo, abbagliante.
Tutto pare esistere – azione o pensiero o libro – soltanto per culminare in uno scintillante “bon mot”, mentre il “salon” francese del Settecento o del primo Ottocento, dove aristocratici, letterati e dame si scambiavano eleganti perfidie, diventa lo spazio ideale della terra.
Ma Calasso sa bene che, oggi, l’arte della conversazione ├© morta. Cos├¼ decide di trasformare La rovina di Kasch in un grande “salon” vuoto, dove egli e l’unico fantasma sopravvissuto, e si traveste inesauribilmente, ora Talleyrand ora Saint-Beuve, ora De Maistre ora Chateaubriand, confidandoci in un cicaleccio ininterrotto i pensieri, le sensazioni, le associazioni che attraversano la sua mente curiosa.
L’arte delicata delle sfumature, l’obliquit├Ā proteiforme, le mollezze quasi orientali dello stile di Calasso non debbono trarci in inganno. La rovina di Kasch ├© un libro sommamente ambizioso, […]. Un nascosto desiderio di potenza lo anima. La serie ininterrotta delle chiose ai testi deve formare una specie di sovrano sopra-testo, superiore a qualsiasi libro e a qualsiasi storia umana, superiore persino al Tutto – o coincidente con esso. Alla fine delle cose, quando un nuovo diluvio avr├Ā ricoperto l’insensatezza della storia, gallegger├Ā sulle acque soltanto questa superba rovina, che rende il Tutto inutile o insufficiente o addirittura irrisorio.
Rassegna stampa
“I sentieri che portano il testo, e specialmente il testo di un romanzo, al palcoscenico sono cosparsi di trappole, tradimenti, amputazioni, espropri forzati e reciproci malintesi. Non sar├Ā il caso di questa serie intitolata Il libro in scene, passeggiata nella letteratura italiana e francese in sei stazioni che si ├© aperta l’altra sera nel parco di Villa Medici, con la figlia di Moli├©re interpretata da Rosa Di Lucia, decisa a rivelare due o tre segretucci a proposito del padre indagati da Giovanni Macchia nel suo saggio-romanzo Il silenzio di Moli├©re“.
(Nico Garrone, A Villa Medici le pagine dei libri diventano teatro, la Repubblica, 17 luglio 1991)
“Con l’acume dello studioso-indagatore, Macchia trae per qualche minuto dall’ombra questa figura quasi anonima immaginando che nel 1705 un giovane aspirante attore chieda ed ottenga un colloquio con Madeleine ormai quarantenne. Lentamente l’obbiettivo della conversazione si sposta dalla vita di Moli├©re, di cui il giovane ├© un ammiratore fervente, all’esistenza appartata dell’erede di un nome cos├¼ illustre. In particolare il visitatore vorrebbe sapere, e chiede con discrezione, quale sia stata la reazione di Madeleine alle velenose accuse, lanciate contro Moli├©re in occasione del suo matrimonio con Armande, di chi insinuava in un libello che l’attore si fosse unito con la figlia della propria amante, dunque in odore di incesto. Ma da Madeleine, che Macchia tratteggia con drammaturgica finezza, in equilibrio tra storia e fantasia, non vengono rivelazioni n├® scatti drammatici. […] I brani del testo di Macchia sono stati letti da Rosa Di Lucia in costume d’epoca, molto brava nel dare voce alla sommessa presenza di Madeleine. Le dava replica, in francese, il collega D. Znyk”.
(Renzo Tian, Povera Madeleine, figlia dimenticata, Il Messaggero, 19 luglio 1991)