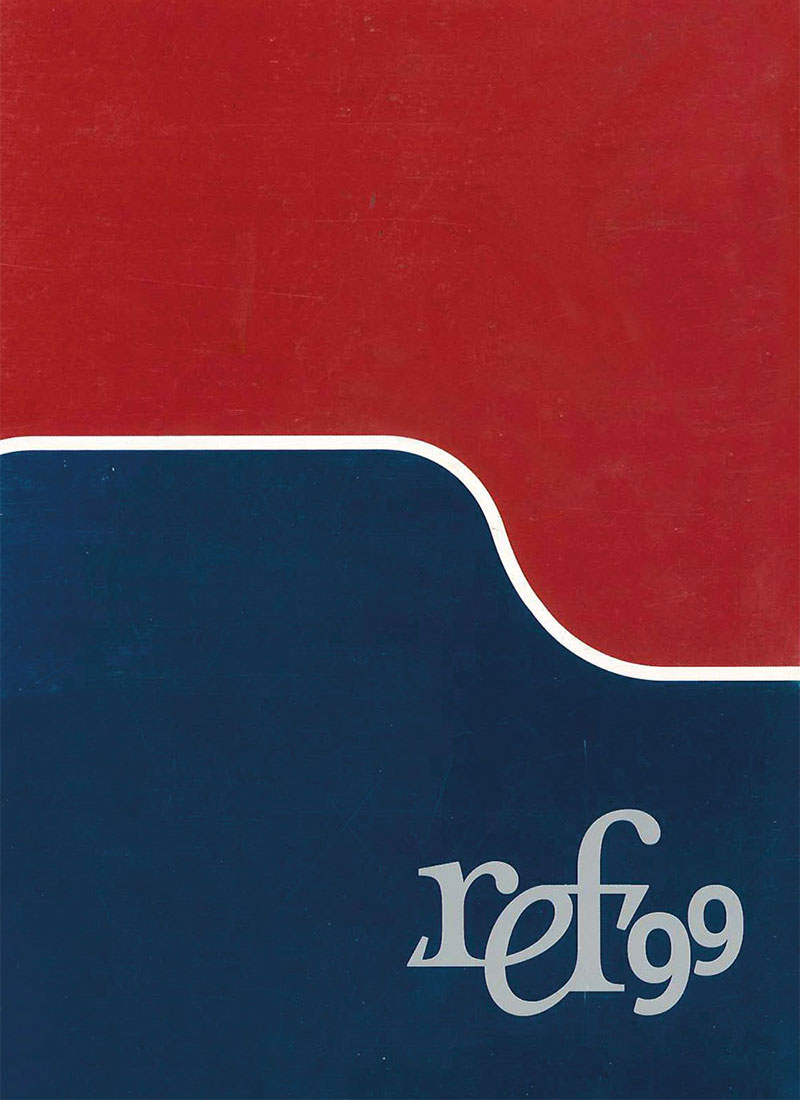Costantemente al centro di polemiche per spettacoli radicalmente iconoclasti, per l’impegno sociale e le scelte tematiche delle sue creazioni, Bill T. Jones ha sempre rivendicato: “Sono nero, gay e sieropositivo”. Dalla morte di Aids nel 1988 del suo compagno di lavoro e di vita, Arnie Zane, la sua danza ha assunto ancora di più una connotazione di lotta contro l’emarginazione e il razzismo, facendo della diversità il suo vessillo. a 47 anni sembra tuttavia aver frenato la sua rabbia per approdare in un universo più intimo e sentimentale. Decide quindi di “prendersi un respiro”, citando il titolo, di tornare cioè da solo sul palco, come agli esordi della carriera, e di danzare per sé, di creare unicamente per il suo corpo, quasi a voler ritrovare le ragioni profonde del suo essere artista. Lo spettacolo si divide in tre sezioni senza soluzione di continuità , a cominciare da Some Schubert song, ispirato ai lieder del compositore austriaco e ai musicisti romantici, poiché, sostiene Jones, “parlano con il cuore in mano e compongono con poca ironia e nobili idee”. Nella coreografia si inserisce anche un doppio Jones, una sagoma nel video Ghost catching: a virtual dance installation, realizzato da Paul Kaiser e Shelley Eshkar applicando dei sensori sul corpo del danzatore. In TBA (sic) rielabora alcuni dei suoi primi assoli, come 21 e Floating the tongue, con nuove sequenze sulle note di Theolonius Monk e di Ionization di Edgar Varèse, mentre per l’ultima sezione collabora con un cineasta del calibro di John Mekas, che crea il paesaggio virtuale di un giardino trasformato in bosco con rami d’oro e d’argento: Gardening in the age of anxiety è una riflessione sulla sua carriera, sul lavoro svolto sul proprio corpo e sulla compagnia, di cui, come spiega la canzone iniziale composta dallo stesso Jones, il giardinaggio è una calzante metafora: “Stiamo costruendo il Paradiso, scavando, piantando, innaffiando, togliendo le erbacce, guardando, pensando, ricordando…”.
Cartellone 1999
SOLO – THE BREATHING SHOW
Teatro Olimpico, 6, 7 novembre 1999 INTERVISTA A BILL T. JONES
a cura di Carmela Piccione
Un ritorno alle origini, dunque, ad un minimalismo del cuore e della mente…
Dopo i quarant’anni ci si volta indietro a guardare la propria vita. Provengo da una famiglia poverissima. Terzultimo di una nidiata di 13 figli nati da un raccoglitore di patate. La danza è arrivata per caso… Grandi gioie e grandi dolori. Il teatro mi ha dato la forza, però, di sopravvivere, di continuare a lottare.
Cosa è cambiato oggi, nel suo approccio con la coreografia?
Prediligo universi più intimisti, sentimentali. Nel mio Show parlerò di amore (i Lieder di Schubert), di nature incontaminate, sempre verdi. E di giardinaggio. Penso abbia molto in comune con la danza. Lavoro duro, ostinato, quotidiano. Ti obbliga a riflessioni costanti, ti costringe a stare solo con te stesso. Come il ballerino in sala.
Artista militante, personaggio scomodo nel mondo della danza di fine millennio. Nel ’92 “l’Osservatore Romano” giudicò Last supper at uncle Tom’s Cabin – The Promised Land spettacolo immorale e oltraggioso, mentre Arlene Croce, temuta critica del “New Yorker”, lo accusò dopo la prima di Still – here (interpreti, alcuni malati terminali di Aids) di voler speculare sul dolore e sulla sofferenza. Cosa rimane dl quelle provocazioni?
La sensazione che forse, quei lavori non fossero stati capiti o apprezzati. Ho sempre parlato nei miei balletti di negritudine, di esclusione, di emarginazione. Per combatterli. La diversità ? Noi uomini di colore ce la portiamo dentro da secoli. Eppure negli anni sono riuscito a frenare le mie rabbie. Esplosioni benefiche che ho trasformato in un modo nuovo di accostarmi alla danza. Teatralità che stringe il pubblico come in un abbraccio contaminato dalle moderne tecnologie. Videoinstallazioni, proiezioni, sensori, computer, cineprese… Universi tecnologici e multimediali di indiscusso fascino.
A quando le Baccanti di Euripide con la partitura di David Bowie?
Ci siamo incontrati più volte ne abbiamo parlato, discusso ma bisognerà ancora aspettare del tempo prima che il progetto si concretizzi. Ci sarà comunque un debutto importante, a marzo, negli Stati Uniti, You walk?, creazione che giungerà a maggio all’Arena del Sole di Bologna. Un immaginario incontro tra due culture, tra due mondi, il vecchio e il nuovo continente, accompagnato da musiche tradizionali americane e celebri pagine di autori barocchi.
(in Carmela Piccione, Bill T. Jones il provocatore ha cambiato pagina, Il Tempo, 6 novembre 1999)
Evento
Rassegna stampa
Intervista a Jones
Trombetta su Jones
Cartellone 1999
SOLO – THE BREATHING SHOW
Teatro Olimpico, 6, 7 novembre 1999 Rassegna stampa
“Artista radicale, insofferente di qualsiasi clichè, Jones è amatissimo dai romani che fin dall’apparizione-scandalo a Spoleto, nel ’93, gli hanno sempre tributato accoglienze trionfali, e ha scelto la capitale […] per una sorta di autoanalisi in presa diretta. […] Su tutto prevale comunque la straripante energia di Bill che trasforma la serata in un evento unico, grazie alla sua capacità di stabilire un rapporto immediato – intimo, solenne – con il pubblico, ammaestrandolo, e facendolo sorridere. Facendolo riflettere. Mettendo sempre se stesso al centro dell’attenzione e però trasformandosi in uno specchio: trasfigurandosi, con prodigiosa alchimia, nell’immagine che il pubblico vuole avere di lui. E di se stesso”.
(Donatella Bertozzi, Bill T. Jones, danza-evento e autoanalisi di un mito, Il Messaggero, 7 novembre 1999)
“Teatro militante e rabbioso. Gli anni hanno smussato le asperità , levigato i tratti di una drammaturgia fortemente impregnata di mistica sociale. Bill T. Jones riscopre, oggi, alla soglia dei cinquant’anni dimensioni narrative raccolte (spazi verdi, incontaminati, giardini di volterrana memoria nel video realizzato da Abraham Ravett, giovane e affermato cineasta americano), si lascia sedurre dalle moderne tecnologie (video installazioni, camere computerizzate che trasformano i movimenti in segmenti fluttuanti richiamando, inconsciamente, le sofisticate e geometriche sperimentazioni del costruttivismo), intona versi poetici, brevi canzoni. Chiede al pubblico di farsi protagonista e partecipe della rappresentazione”.
(Carmela Piccione, Così Bill T. Jones seduce ballando, Il Tempo, 8 novembre 1999)
“Ma – come gli altri spettacoli da lui firmati – si spinge a proporsi come messaggio etico più che estetico: non ha molta importanza quel che Bill, pur con straordinaria grazia e plasticità , balla sulla scena, ma il perché lo fa. La sua è una testimonianza, prima ancora di essere una coreografia. È un modo di vivere e di insegnare a vivere l’attimo fuggente, perché la precarietà dell’esistenza umana, conclamata per lui, è in realtà una condizione universale per noi tutti. Non c’è cupezza negli assoli che Bill inanella sul palco, è piuttosto un canto alla vita, alle sue luci e ombre, alla gioia e alla solitudine, alla nostalgia e alla memoria. Un collage di sequenze dove irrompe la presenza surreale di un omino con gli occhiali (probabilmente in memoria di Zane) che soffia palloncini fino a farli scoppiare, o le scheletriche rielaborazioni al videocomputer delle sue danze, che danno un brivido come strani fantasmi pronti ad affacciarsi alla mente”.
(Rossella Battisti, Bill T. Jones, oltre il giardino dei sentimenti e della danza, l’Unità , 8 novembre 1999)
“Ma perché Bill destabilizza lo spettatore assai più di un Nurajev o di un Baryshnikov? A monte c’è comunque una personalità intrigante e fantasiosa, carica di una irresistibile vis polemica. C’è il suo duplice volto – Bill uno e due. La voglia di vivere e di morire. La voglia di dirla tutta. La leggerezza e la perfezione del gesto. Quel modo sexy di muovere i passi, proprio dei neri. Altroché John Wayne. […] L’adesione ai diversi stili, al suono, al ritmo era sempre perfetta, a tratti esaltante. Sculettare con ironia seguendo Thelonious Monk non era affatto volgare. Usare come punto di partenza della danza 2000 Ionization di Edgar Varèse era un bel messaggio da conservare a futura memoria. Quella di Bill T. Jones non è solo danza bensì cultura. E, perché no, divertimento”.
(Mya Tannenbaum, Bill T. Jones danza una metafora sulla fine del Millennio, 9 novembre 1999)
“Poi un nuovo video, imitando lo stile dell’avanguardia americana dell’epoca di John Mekas e dintorni (ma anche pensando a certo ultimo Barman): immagini di giardino, finalmente rivelato, i piedi di Bill in primo piano, statuette africane, erba, bambole, panchine. Aspettando che lo sfondo disegnato da Bjorn Amelan (che occasionalmente attraversa la scena) si trasformi in foresta di rami oro, argento, azzurro. Una chiusura celestiale, indovinatissima: Bill esegue i suoi movimenti su note mozartiane in maniera tersa e perfetta, esemplare, non senza un’ironia rifinitissima alla Pierre & Gilles. E poco prima aveva invitato qualcuno del pubblico a scegliere un numero compreso fra uno e dieci. Ogni numero corrispondeva a un brano musicale, sorteggiato dal caso, eseguito all’istante. Il bello di tutto questo, di questa danza da camera, come fossimo fra quattro mura e avessimo di fronte un amico che danza e non una stella di prima grandezza, è la vivente negazione di ogni narcisismo”.
(F. Be., Bill virtuale e intimista, La Voce Repubblicana, 9 Novembre 1999)
Cartellone 1999
SOLO – THE BREATHING SHOW
Teatro Olimpico, 6, 7 novembre 1999 BILL T. JONES
di Sergio Trombetta
C’entra la vita personale di un artista con il suo lavoro? I suoi amori, le sue disgrazie, la sua formazione influiscono su quello che egli ci dà in scena, in un libro, in un quadro? E tutto ciò è vero soprattutto per un coreografo? Un anno e mezzo fa sul “New York Times” Anna Kisslegof metteva a confronto due biografie artistiche dedicate rispettivamente a Frederick Ashton e Merce Cunningham.
E si chiedeva perché nel primo caso il libro fosse così pieno di pettegolezzi e storie private sull’omosessualità del coreografo inglese, mentre nel secondo neppure si facesse cenno all’amicizia che legava Cunningham con John Cage.
Sono probabilmente davvero imperscrutabili le cause che portano un artista a riversare totalmente il proprio vissuto nella arte; e contemporaneamente fanno sì che gli esiti di un altro siano del tutto indifferenti rispetto ai dati personali.
Ma quel che è certo è che Bill T. Jones (1951) appartiene senza ombra di dubbio alla prima categoria e ne è pienamente consapevole.
Un ballerino nero, di origini proletarie, apertamente omosessuale e, da un certo punto della sua vita in avanti, sieropositivo: sono questi i simboli, le bandiere che Bill non ha mai rinunciato a mettere in primo piano nei suoi spettacoli dando spesso vita a una sorta di “agit-dance”. La cosa non sempre è stata accolta benevolmente dalla critica. Gli scarti da un giudizio politically correct ci sono stati, eccome. C’è chi ha respinto sdegnosamente certi suoi esiti bollandoli come “victim-art” e la polemica si è fatta rovente.
A ben guardare non soltanto l’emergenza Aids ha influenzato la parabola artistica di Bill T. Jones. Tutto il suo percorso creativo può essere letto come il rispecchiarsi in danza degli ultimi tre decenni di cultura omosessuale americana.
Sia chiaro: con una aspirazione a parlare a un pubblico più composito, ma da un punto di partenza preciso, da esperienze molto personali.
All’inizio degli anni 70 quando Bill frequenta corsi di danza afro-caraibica, Graham, classico, contact improvisation, fondamentale è l’incontro con il fotografo Arnie Zane, che diventerà il suo compagno e il cofondatore della Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company.
Nascono lavori importanti, caratterizzati da una nuova narratività che li rende apprezzabili anche in Europa. E sono proprio di questo periodo i lavori come Freedom of information e Secret pastures con i graffiti di Keith Haring, la musica di Peter Gordon e i costumi di Willi Smith che fanno di Jones e Zane la coppia più glamour della scena coreografica newyorkese. Il 1988 è l’anno in cui nasce Soon duo programmaticamente e indifferentemente destinato a una coppia omo o etero, di grande bellezza. Ma è anche l’anno in cui Arnie Zane muore di Aids. E questa tragedia imprime una svolta creativa nel lavoro di Bill. D-man in the Water del 1989 è il primo brano apertamente dedicato a un danzatore morto di Aids. Ma è il potente affresco Last Supper at Uncle’s Tom Cabin/Promised Land del 1990 il lavoro in cui i temi del razzismo, dell’uguaglianza di fronte alla morte vengono affrontati apertamente. C’era un dialogo, che era il perno centrale dello spettacolo (presentato con scandalo a Spoleto e a Torinodanza) dove Bill seduto a un tavolo, di fronte a un prete, chiedeva: “Padre, lei crede davvero che l’Aids sia un castigo divino?” E il prete rispondeva: “No. Non lo credo. La sessualità non è peccato, non è scandalo”.
Negli anni ’90 Bill è molto presente in Europa. Come coreografo ospite al Ballet de l’Opéra de Lyon, in tournée con la sua compagnia, caratterizzata sempre più come catalizzatrice di tipi umani molto diversi, anche fisicamente: c’é per esempio un indimenticabile grassone che danza con energia e leggerezza.
Ma il cammino di Bill verso uno spettacolo che sia sempre più “docu-dance” lo fa approdare a Still/Here (1993), realizzato utilizzando workshop e video con malati terminali. È a questo punto che si scatena in America la polemica, molto rovente, che lo accusa di fare della “victim-art”, cioè di usare la malattia, l’Aids come uno scudo per ripararsi da eventuali critiche al suo lavoro.
Quello che è certo è che dopo questo spettacolo si assiste ad una nuova svolta artistica che porta il coreografo verso lidi più sereni. Da una parte le collaborazioni con un’artista come Trisha Brown, con una cantante famosa come Jessie Norman (il recente How! Do! You! Do!) o un jazzista come Fred Hersch (l’ancora più recente Out Some Place). Dall’altra il ritorno a una riflessione sulla danza di questo secolo con We Set Out early… Visibility Was Poor del 1998 che si dipana attraverso la musica di Igor Stravinskij (L’histoire du soldat) e del lituano Peteris Vasks (Stimmen).
(in Catalogo Romaeuropa Festival 1999)