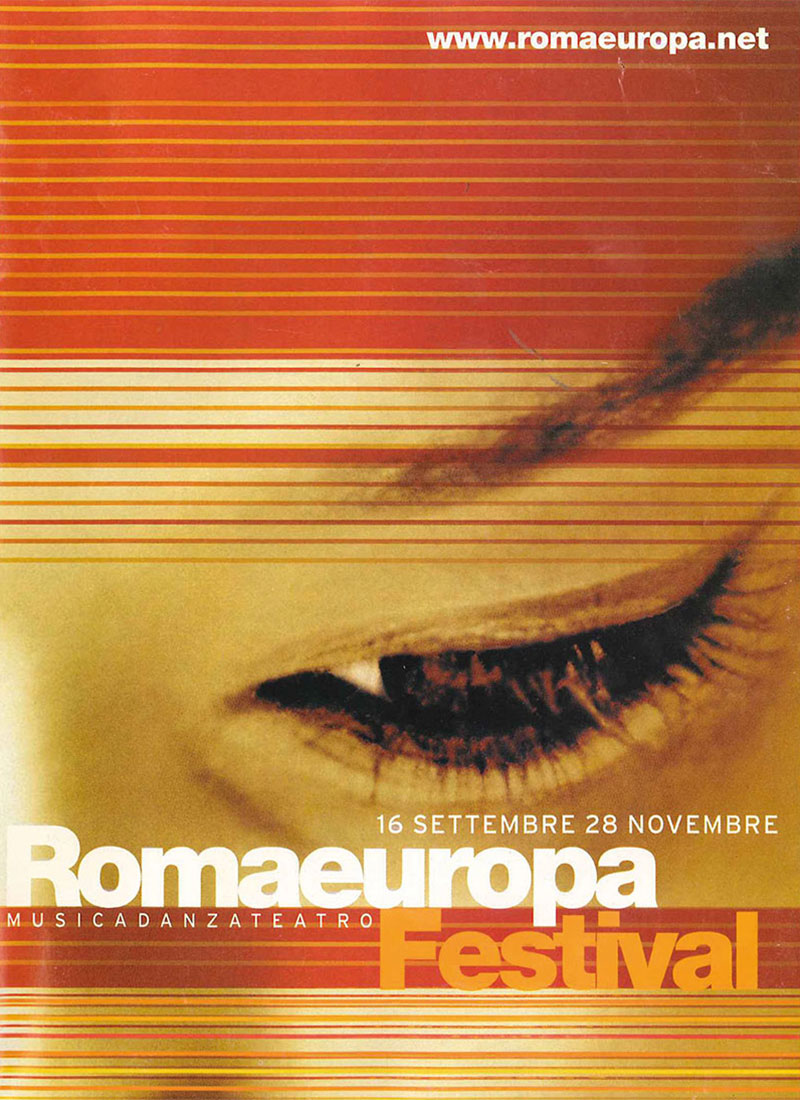In occasione del ventennale della compagnia, la Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company presenta uno spettacolo, Another evening (“un’altra serata”), che è memoria e futuro allo stesso tempo: un evento dove la danza si mescola con la musica, le parole, le immagini video, ripercorrendo, nelle quattro serate, le coreografie più significative ed importanti di questa straordinaria compagnia che nella sua storia ha sempre coraggiosamente guardato avanti, senza condizionamenti e senza pudori. Il tema centrale resta quindi il trascorrere del tempo. A vecchi lavori come il duo The continous replay (di Zane del 1977), riarrangiato fino a comprendere più di trenta danzatori, o come Blauvelt Mountain (creato da Jones con Arnie Zane nel 1980), o Last supper at uncle Tom’s Cabin che suscitò scandalo per i nudi in scena, si aggiungono brani degli anni Ottanta e Novanta, ma anche creazioni nuove nate attorno a passi di un testo scritto dallo stesso Jones (e da lui letto): uno spartito poetico che lascia spazio al linguaggio del corpo, “un teatro danza della vita”, come dice lo stesso coreografo.
Il testo riflette, sin dalle prime battute, sul perenne contrasto tra l’assolo e il movimento d’ensemble, proseguendo poi lungo la linea dei ricordi che scorrono da una immagine della sua infanzia alle parole della madre fino alle frasi scritte dopo l’11 settembre, che ne raccontano la rabbia e la paura. Mentre Jones parla rivolgendosi direttamente al pubblico, sul fondo della scena scorre il costo in dollari calcolato in tempo reale della guerra in Iraq, ed ancora numeri sono quelli che i danzatori, hanno stampati sulle loro maglie: sul petto la propria data di nascita, sulla schiena una data per loro significativa, del passato o del futuro.
Gli assoli si alternano a disegni ed azioni che coinvolgono, due, tre, quattro danzatori fino all’intera compagnia, creando un movimento di danza esistenziale contrappuntato da un tappeto sonoro, composto ed eseguito dal vivo da Daniel Bernard Roumain, che miracolosamente miscela (con una tecnologia avanzata) suoni e musiche dalle origini più disparate.
La memoria, quindi la vita di Jones (omosessuale nero), dunque la diversità (temi a lui cari) guidano le traiettorie di una coreografia che superando l’atteggiamento “ferocemente” antirazzista, lascia emergere una rinnovata coscienza di sé e del proprio corpo, mentre lo sguardo al passato non infrange la speranza di un futuro, oltre la paura.
IL SODALIZIO TRA BILL E ARNIE, UN NERO DEL PROFONDO SUD E UN EBREO DEL BRONX
di Maria Pia D’Orazi
Alto Bello, corpo da Dio greco e sorriso aperto Bill T. Jones, decimo di dodici figli, nasce in Florida cinquantadue anni fa da Estella e August, afro americani emigrati che si guadagnano da vivere raccogliendo patate. A nove anni scopre la danza per caso giocando coi fratelli in un parco dove c’è un jukebox. Perché ai contadini neri non era permesso di entrare nei bar senza affrontare l’ostilità della gente, ma quando si mettevano a ballare raccoglievano subito una piccola folla. Lui immaginava per ore ciò che sarebbe diventato: “Qualcuno che stava davanti a un pubblico”. In casa si parlava sempre di giustizia e di diritti. A dodici anni si lascia travolgere dall’entusiasmo dei manifestanti in marcia su Washinghton dietro Martin Luther King e capisce che bisogna muobersi verso l’alto. Dopo il liceo vince una borsa di studio ed entra nell’ambiente della danza newyorkese con la sensazione e il bisogno di lottare per restarci. Il resto lo fanno gli anni Sessanta e la convinzione di essere libero; può vivere dove vuole, creare ciò che vuole e amare chi vuole.
E lui volle Arnie Zane.
Bill e Arnie si incontrarono alla State University nel giorno di S. Patrizio del 1971. Lui era un grosso nero espansivo del sud con la passione per la danza. Arnie era un piccolo ebreo bianco del Bronx, molto riservato e promettente fotografo. Rimangono insieme diciassette anni e la relazione personale diventa subito sodalizio artistico. Un periodo a lavorare in due, nel 1982 mettono su famiglia: persone di taglie, colori e lingue diverse per la compagnia più provocatoria dell’avanguardia newyorkese dell’epoca. È una celebrazione della differenza mischiata all’esibizione di un erotismo pieno di rabbia e sempre in stato di guerra. Il linguaggio combina danza, teatro, video, silenzi e musica di ogni genere. Corpi nudi di tutte le età . Spettacoli brevi di pochi minuti o lunghi un intero pomeriggio. Intanto vanno in giro tenendosi per mano. Se nessuno chiedeva a Rockfeller di giustificarsi per essere un maschio bianco eterosessuale, tanto meno spiegazioni ne avrebbero date loro.
“Arte da vittima”
Nel 1984 scoprono d’avere l’Aids. Arnie muore quattro anni dopo, a 39 anni Bill decide di andare avanti in sua memoria. Per 24 mesi intervista malati terminali in dodici città . Ne viene fuori Still/Hetre (1994), il suo modo di dire a gay e sieropositivi che nonostante tutto vale la pena continuare a vivere. Il critico del New Yorker, Arlene Croce, si rifiuta di vederlo: “arte da vittima”. Per tutti resta un capolavoro. L’etichetta di “nero, omosessuale e sieropositivo” da tempo non gli appartiene più. Lui non si è mai sentito un artista impegnato, ha sempre e solo raccontato storie che descrivono la sua maniera di sentirsi vivo. Si definisce un hippy con una forte spiritualità . È tornato al movimento puro e non è più sicuro che l’arte serva a provocare un cambiamento. Le sue creazioni vogliono emozionare profondamente le persone e nello stesso tempo essere fredde come una scultura da osservare. Le forme dialogano con ciò che accade. Le risposte e i significati ognuno li trova da sé.
(in “Il Foglio”, 18 settembre 2004)
PARLANDO CON BILL T. JONES
Estratti da interviste a cura di Francesca De Sanctis, Pirro Donati, Donatella Bertozzi
“Io non amo le polemiche. Sono un’artista non un politico. Per anni e anni mi sono occupato di tematiche sociali, ma negli ultimi dieci anni ho provato a concentrarmi sull’estetica. Con me un artista crea sempre il lavoro partendo dalla sua vita. Quando cammino per Roma, che è una città bellissima, cerco di ascoltare la mia esperienza nelle strade di Roma. E la danza moderna per me è come la mia lingua, danno la forma alla mia anima. Le nostre anime, in fondo, ricevono informazioni dal mondo che creiamo. […] Da anni cerco di allontanarmi dalla psicologia e dalla politica, perché l’arte deve essere pura, deve mantenere questa essenza. In questo senso lavoro sulla forma, sullo spazio. Per raggiungere la purezza”.
(in Francesca De Sanctis, B.T. Jones: arte contro pregiudizio, l’Unità 4 aprile 2004)
“I ballerini che lavorano con me sono tutti giovani che conoscono poco la storia della Compagnia e io sono rimasto solo da quando Arnie è morto: così dal 2002 ho iniziato a lavorare sul nostro passato. Il problema con la danza è che le Compagnie sono costruite sulle personalità dei danzatori e su un linguaggio comune che è nello stile e nelle scelte del coreografo: tutte cose che cambiano in continuazione. Ritrovare i movimenti pensati 20 anni fa non è per nulla scontato, equivale a dargli una vita completamente nuova senza tradirli. Come accade in scultura, pittura architettura, vuol dire creare una tradizione che però non ti blocchi. Non nascondo che guardare attraverso il mio passato mi spaventa molto, oggi devo ammettere che mi sta spingendo avanti […]. Mentre molti danzatori danzano da soli o in gruppo c’è anche una frase ripetuta continuamente che deve funzionare come mantra: “Solo dancing is a dead”, un’affermazione molto ironica, che mi relega nel passato mentre mi fa guardare alla compagnia come al mio futuro. Perché nello spettacolo faccio un solo, ma deve essere chiaro che io continuo a danzare perché esiste la Bill T. Jones e Arnie Zaine Company”.
(in Pirro Donati, La danza ricrea il passato, Il Tempo, 4 settembre 2004)
“Sono partito da un ricordo personale: una frase che negli anni Settanta, a S. Francisco mi rivolse una collega, Theresa: “L’assolo è una strada senza uscita”, disse “se insisti a lavorare sull’assolo ti condannerai a ripetere il medesimo assolo per il resto della vita”. Era apertamente una sfida, io ero all’epoca fondamentalmente un solista. Theresa era fatta così. Ma quella frase mi è tornata in mente e ne ho fatto l’inizio ironico di questo lavoro che è invece sulla mia compagnia vista come una comunità di individui. […]
Io credo che lei resterebbe scioccata da quanto mi sono spogliato da qualunque idealismo a questo punto… L’idealismo è stato sostituito da qualcosa di diverso. L’arte può davvero cambiare qualcosa? Io non lo so. Ho anche detto “l’arte è la mia religione” . Ma oggi non lo direi più. Mi pare che anche la maggior parte delle persone che hanno una fede religiosa ammettano che le loro convinzioni rischiano di andare in pezzi. Ci sono momenti in cui mi sento così disorientato che arrivo a pensare che se la mia vita e la mia arte non fossero così strettamente collegati non continuerei a lavorare come faccio, farei qualcos’altro .. Ma dal momento che la mia arte è così intimamente connessa con la mia sopravvivenza devo cercare di restare attivo in questo mondo e dare e trarne il meglio che posso […].
Ho perso la mia fede in quello che l’arte può fare? È diventata per me un’abitudine? Pensare come un’artista può diventare un’abitudine? Questo è il punto a cui sono arrivato. Ma mi costa molto ammetterlo. È qualcosa di molto privato. È giusto condividere i miei pensieri con il lettore? Questo è un altro punto importante per me: come sia possibile costruire un legame fra il mio lavoro e i molti estranei che lo vengono a vedere. Cerco da sempre di presentarmi al pubblico e di presentare il mio lavoro con questa domanda in mente: “Perché? Perché la danza? La modern dance? Ma in questo momento non so dire perché. O almeno non più”.
(in Donatella Bertozzi, Danzo i numeri che cambiano la vita, Il Messaggero, 13 settembre 2004).
Rassegna stampa
“Lo spettacolo, impeccabile sotto il profilo della pura ricerca coreografica, varia e ben strutturata, con il coreografo ultracinquantenne in scena come una sorta di demiurgo affettuoso con i suoi interpreti, non era questa volta però una performance di sola danza. Al contrario di come accade spesso invece in molta danza contemporanea americana, difatti qui non contano solo le architetture, perché il lungo testo recitato dallo stesso coreografo aggiunge un valore particolare alla performance. In maniera soffice e un po’ sconnessa vi si parla dei malesseri della nostra odierna società , alle prese con guerre in cui non crede, della perdita dei valori (onore, lingua, cultura, tolleranza), dell’annullamento, della omologazione culturale, della globalizzazione che in nome della libertà di uguaglianza annulla paradossalmente le differenze individuali. E ancora del mistero della vita e della morte dell’amore e della sofferenza, della caducità effimera della vita, della assurda violenza familiare sulle donne, della ricerca di una serenità interiore”.
(Lorenzo Tozzi, Con Bill T. Jones non solo danza, ma monito per la vita, Il Tempo, 20 settembre 2004)
“Lo spettacolo visto all’Auditorium, Another evening, è un suo estroso e metaforico autoritratto, brandelli di memoria e di idee su un possibile futuro. Bill T. Jones è capace tuttora di prodigi espressivi e acrobatici. Ed è perfetto nel leggere il suo testo, raffinato e commovente, ma fin troppo geometrico e razionale nelle sue strutture coreografiche e nelle scrupolose, pianificate interazioni tra danza poesia e musica. Musica eccellente di un violinista, compositore e dj: Daniel Bernard Roumain. Anche in questo affresco dove vivono rimpianto del passato e speranza del futuro c’è una breve scena in cui tutti a poco a poco, si spogliano e appaiono nudi. Ma non è più il vecchio urlo antirazzista, questa volta, ma un manifesto per una nuova presa di coscienza di se stessi, del proprio corpo e della propria anima insieme e della necessità assoluta di essere liberi, se si vuole continuare a sperare”.
(Vittoria Ottolenghi, Per Bill T. Jones un’autobiografia metaforica e nuda, Il Mattino, 25 settembre 2004)
“Acora una volta per Bill T. Jones la nudità diventa sinonimo di sincerità : del corpo, dell’emozione, del movimento “svelato” fisicamente. Non un corpo di ballo, ma corpi che ballando dichiarano la loro individualità . Come l’esplosiva Ayo Janine Jackson, un piccolo tizzone acceso di gioia di vivere e danzare, la lunare Leah Cox, lo stesso Jones nero e magnifico nei suoi maestosi (e nudi) overfifties.
Ogni interprete è un microcosmo rivelato nelle danze di Bill T. Jones. È questa la sua forza. La grande incredibile umanità che trasuda dal palcoscenico e ci raggiunge per brevi sensazioni, frammenti di segno, baluginii di gesto. La testimonianza, appunto dell’essere creature umane che cercano di resistere all’onda della storia e di un destino troppo più tragico della nostra capacità di sopportarlo per intero”.
(Rossella Battisti, “Un’altra sera”con Bill. T. Jones per sentirci davvero umani, l’Unità , 4 ottobre 2004)
“Con un’altra serata di danze Bill T. Jones – americano, nero, sieropositivo – ha interrogato il suo passato all luce di un presente che non si limita a “fissare” ciò che è stato, ma lo vivifica scaldandolo al calore dei corpi di dieci danzatori: sono loro, oggi, le anime della compagnia, naturalmente guidati dal coreografo (straordinaria presenza scenica, piglio vivace, fisico da guerriero a dispetto dei 52 anni) e dall’assenza quasi tangibile del cofondatore del gruppo Arnie Zane, il compagno di Jones che l’Aids ha ucciso nel 1998. Più che i riferimenti alle vicende internazionali o i frammenti autobiografici, a colpire lo spettatore è la capacità dell’artista a guardare il futuro, a tutto quello che c’è ancora da fare. E questo suggerisce la poetica immagine iniziale e finale: due uomini attraversano la scena rotolandosi a terra avvinti in un abbraccio iniziato nei primi anni Settanta e indifferente allo scorrere del tempo, che l’artista scandisce al microfono trascinandoci con lui di anno in anno fino al 2040 e oltre”.
(Ada D’Adamo, Uno sguardo prossimo, il futuro rappresentato da Bill T. Jones, Diario, 9 ottobre 2004)
Scenografia Bjorn Amelan
Musica Daniel Bernard Roumain
Direttore artistico associato Guil Amelan
Direttore di compagnia Jessica Cabrera
Direzione di palco Kathryn Kyle Maude
Direttore musicale Daniel Roumain
Luci Robert Wierzel
Supervisione luci Laura Bickford
Direttore di produzione Bob Bursey
Direttore prove Janet Wong
Danzatori Nadide Asli Bulbul, Catherine Cabeen, Leah Cox, Shaneeka Harrell, Ayo Jackson, Wen-Chung Lin, Malcom Low, Erick Montes, Gaetan Pettigrew
Durata 80 minuti