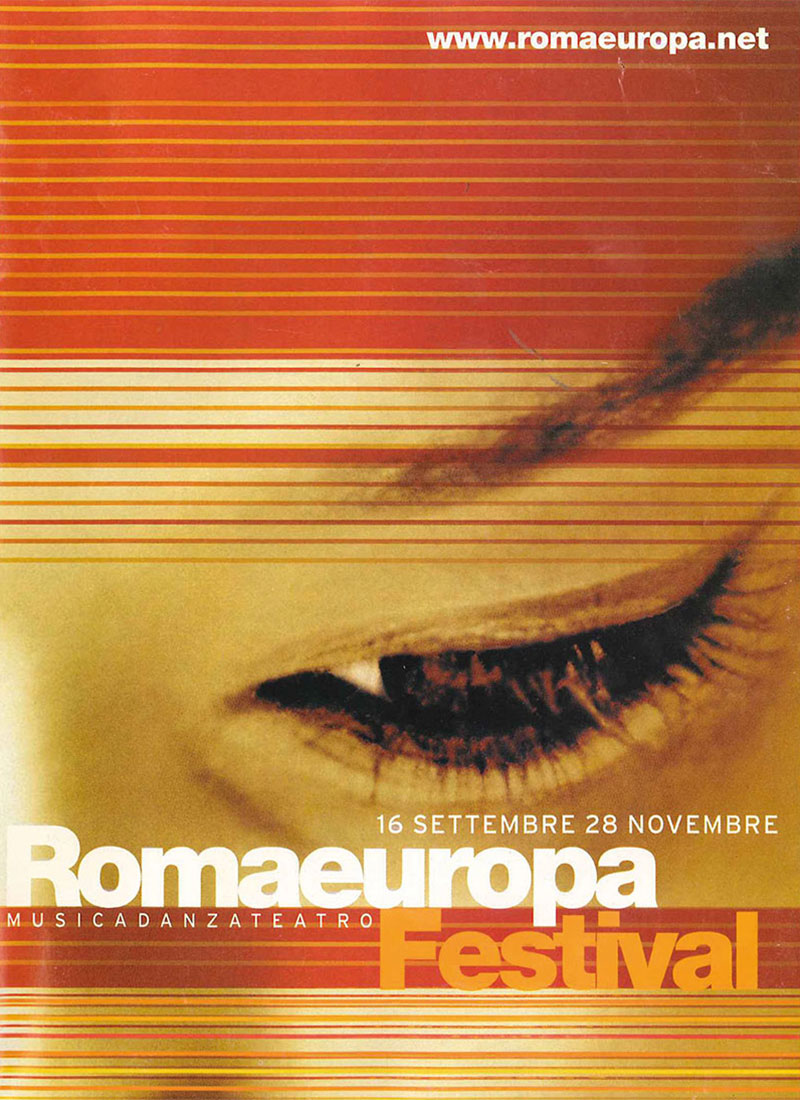Ma, che in Indi e bengali significa sia madre sia terra, si ispira ed è ispirato al libro dell’indiana Arundhati Roy, The Algebra of Infinity Justice, una raccolta di saggi politici in cui la Roy analizza in modo molto critico le conseguenze e gli effetti della globalizzazione, battendosi soprattutto contro la politica delle grandi dighe, all’origine della progressiva devastazione del territorio.
Lo spettacolo, che mescola danzatori e musicisti, si muove attraverso il racconto del conflitto tra l’uomo e la Madre-Terra: strisciando sul palcoscenico i danzatori ripropongono la resistenza dei contadini alla distruzione che avanza, condotta attraverso riti ancestrali, raccordi profondi tra uomo e natura. Al movimento, la “religiosa” visione di Akram Khan, già ospite del festival nel 2002 con Kaash, affianca la storia di una fanciulla che non potendo avere figli, si lega agli alberi da lei stessa piantati – una fiaba, metafora radicale della simbiosi fra uomo e natura, che nata dalle immagini del coreografo stesso, è stata messa in forma narrativa da Hanif Kureishi, narratore molto amato ed apprezzato, anch’egli in felice bilico fra oriente ed occidente.
Faheem Mazhar, dalla voce straordinaria, appeso ad un albero a testa in giù apre lo spettacolo sulle note di Riccardo Nova che spazia sapientemente tra oriente e occidente (dalla simbologia della musicalità indiane alla musica elettronica) offrendo un tessuto sonoro quanto mai idoneo a questo “canto ritmico” dei danzatori, come rivela lo stesso compositore.
Ma si conclude, con guizzo cinico, con A Wonderful World che lascia infine il pubblico nell’illusione di una vita meravigliosa.
Il lavoro ha felicemente confermato la riflessione e la ricerca di Akram Khan che, capace di rinnovare l’antica tradizione del Kathak, danza classica indiana, ha sviluppato un khatak contemporaneo fatto di un perpetuo contrasto e dialogo nei movimenti fra immobilità e velocità , continuità e frattura.
Musica Riccardo Nova
Testo Hanif Kureishi
Musica registrata Ictus Ensemble (composta da Riccardo Nova)
Luci Mikki Kunttu
Scene Illugi Eysteinsson
Costumi Tony Aaron Wood
Drammaturgia Carmen Mehnert
Direzione tecnica Rachel Shipp
Tecnico del suono Jukka Kaven
Regia prove Britta Pudelko
Produttore esecutivo Farooq Chaudhry
Musicisti Faheem Mazhar (voce), B. C. Manjunanth (mridanga), Natalia Rozario (violoncello)
Danzatori Eulalia Ayguade Farro, Akram Khan, Anton Lachky, Moya Michael, Inn Pang Ooi, Nikoleta Rafaelisova, Shanell Winlock
Produzione Romaeuropa Festival 2004, The South Bank Centre, Théâtre de la Ville, Singapore Arts Centre Vooruit, Tanzhaus nrw Düsseldorf, Holland Festival, Göteborg Dance and Theatre Festival, Lincoln Center for the Performing Arts
Con il sostegno di Arts Council England, The British Council
Estratti da interviste a cura di Paolo Cervone, Luca Del Fra
“Da piccolo passavo lunghi periodi di vacanza nel Bangladesh (ma allora era ancora India), nel cortile c’era un immenso albero al quale mi appendevo a testa in giù. Mi immaginavo il fratello, gli amici che non avevo. Come tutti i bambini avevo tante domande da fare. Perché il cielo blu? Ma non c’era nessuno a darmi una risposta. E allora aspettavo che arrivasse la terra, anche solo un sussurro, sfiorandola a testa in giù. Sottosopra vedendo tutto a rovescio la vita mi appariva tranquilla. Quando poi mi rimettevo in piedi in posizione normale, mi sembrava che fosse tutto un caos.
I miei genitori mi hanno spinto a non staccarmi dalle nostre radici, sono cresciuto frequentando la comunità indiana, ma ho voluto anche dialogare con i miei amici dell’Occidente. Per me la vita è una confusione un melting di altre culture, le cose succedono naturalmente, buone o cattive che siano. Ma, è ispirato al libro dell’indiana Roy The Algebra of Infinite Justice […]. Arundhati lotta per la difesa della terra. I contadini vivono con i prodotti dei campi, ma danno anche molto; un rapporto che i governi non capiscono. Così mi è venuta voglia di raccontare questa tragedia, la decisione di costruire grandi dighe in India, così come in Cina, provocando l’inondazione di vaste aree e l’esodo dei contadini. Una scelta forzata che ha sconvolto la loro vita. […] I danzatori in scena strisciano sul palcoscenico in una sorta di giardino indiano fatato popolato da adolescenti che giocano alle arti marziali. Lo sguardo vola basso, la simbologia mitologica tipica delle statue indiane richiama il germogliare delle piante o le radici contorte degli alberi. I movimenti si rifanno all’antica tradizione della danza Kathak violenta e ritmata, per poi confondersi con la danza contemporanea occidentale.[…] È la confusione dei corpi che cerco in maniera incosciente, senza intellettualizzazioni. I movimenti per me vengono istintivamente, niente di quello che succede è voluto da me. Io ho studiato danza classica indiana, anche i miei ballerini devono avere una tecnica rigorosa, che poi cerco di spezzare. Nel mondo del “Ballet” domina una sola opinione, lo spazio è definito dai limiti codificati, tutto è bianco e nero, giusto o sbagliato. Nella danza moderna niente è sbagliato, lo spazio è istintivo come il gesto, fatto di sguardi, di feeling”.
(Paolo Cervone, A testa in giù, danzo la madre terra, Corriere della sera, 26 giugno 2004)
“Ho iniziato a studiare il Kathak quando avevo sette anni, ancora oggi mi piace danzarlo e faccio anche spettacoli tradizionali. Alla danza contemporanea sono arrivato quasi per caso […]. Nella comunità indiana a Londra danzare non è considerata una cosa seria, insomma un vero lavoro. Così quando avevo vent’anni la mia famiglia cominciò a fare pressioni perché andassi all’Università e prendessi un diploma. Li ho accontentati studiando quello che mi piaceva: la danza. È stato ai corsi universitari che sono stato attratto dalla danza contemporanea”.
(Luca Del Fra, La madre degli alberi, R360, ottobre 2004)
IL KATHAK
Il Kathak ha origine dalle danze devote eseguite nei templi del nord dell’India, dove esisteva come forma narrativa. In seguito, acquisì una propria identità quando venne adottata dall’imperatore moghul Akbar, per essere praticata nella sua corte. Accompagnata dalla musica classica Hindustani, viene danzata da uomini e donne: le danzatrici portano un velo (secondo l’usanza musulmana) per coprire i capelli e pantaloni sotto l’ampissima gonna.
Il Kathak viene chiamato il flamenco indiano, ed effettivamente lo ricorda sotto molti aspetti: è una danza caratterizzata da combinazioni complesse di ritmo, sottolineate da fitte cavigliere, e da spettacolari giri, simili a quelli del flamenco. Kathak è lo stile di danza classica dell’India settentronale. Storicamente il nord e il sud dell’India si differenziano soprattutto per l’influsso che la cultura islamico-persiana ha avuto al nord. Il nome deriva dal sanscrito katha, storia, racconto, più precisamente prende il nome dalla categoria di menestrelli e danzatori che interpretavano le storie epiche religiose vishnuite, le katha, e che già vengono nominati nel testo epico Mahabharata (II secolo a.C.).
Con l’Impero Mughal (XII-XVII secolo), il kathak entra a corte e subisce l’influenza persiana. È proprio allora che viene stilizzato dai grandi ballerini di corte della tradizione di Lucknow.
A corte erano infatti le cortigiane che vi si esibivano, associandola al canto amoroso.
Un discendente tuttora molto famoso a livello internazionale della scuola (gharana) di Lucknow è Birju Maharaj.
Oggi esistono due stili di kathak, quello di tradizione hindu, tipico della scuola di Jaipur, e quello che porta ancora le tracce dell’influenza persiana, tipico di Lucknow.
Le due varianti si distinguono nelle vesti, nel saluto (uno hindu, l’altro islamico) e nella tematica.
Lo stile hindu ha proseguito un carattere più devozionale, mentre quello di influenza persiana ha tenuto il soggetto amoroso incentrandosi sull’estetica del movimento.
Caratteristici del Kathak sono il gioco di passi frenetici e le piroette spettacolari. Conserva un repertorio estremamente virtuosistico sul piano ritmico e su quello dei passi e dei movimenti dei piedi e una ricca tradizione espressiva, in cui la danza si esprime attraverso le mani e il volto. Il kathak è costituito come le altre danze indiane da danza pura `nritta’ e danza narrativa `nritya’, per la quale usa gesti (mudra) combinati o di una singola mano e gesti abbinati a passi (gat).
Alcuni danzatori leggendari di kathak, come Bindadin Maharaj (1838-1918) o Shambu Maharaj (1904-1970) usavano unire danza e canto cantando prima un verso e poi illustrandolo coi movimenti da seduti.
Rassegna stampa
“[…] La terra è brulla, ma la giovane donna che dialoga con un’amica a testa in giù sogna non bambini impossibili ma tanti alberi; stare insieme è facile quando non ci sono parole, ma se si parla troppo c’è la condanna dell’esilio. Le parti danzate, modern break, stile Graham un po’ modificato, sono di perfetto taglio occidentale, l’India e il Kathak sono lontanissimi ma l’aria del favoleggiato Bengala si respira comunque, quasi senza peso, leggera come gli spiriti dell’aria. La doppia cultura di Ma, rende astratte le differenze, alleggerisce le tensioni: e qui sta il limite di uno spettacolo che non vuole coinvolgere il pubblico, ma solo spiegargli (il cinema inglese o pakitano sono ststi però più espliciti) che esistono cose e persone tutte da scoprire. Non stupisce allora che i vocalizzi indiani diventino una sorta di “scat” nonsense jazzistico in cui proprio Armstrong era maestro, o che il violoncello diventi a sua volta tamburo; i testi di Kureishi sono inglesi, le musiche composte – e ascoltate su nastro a supporto di quelle live – sono firmate da un italiano Riccardo Nova, che pensa all’indiana, così ci troviamo di fronte a un continuo scambio incrociato di segni artistici, a un caleidoscopio di forme ineguali”.
(Mario Pasi, Madre terra e i suoi contadini, Corriere della sera, 16 ottobre 2004)
“Strumenti privilegiati della sua coreografia erano la danza indiana kathak, con le sue movenze marziali, eroici scatti e rotazioni rapinose (unite allo stile di danza contemporanea occidentale) e la musica indiana di Riccardo Nova, diplomato al Conservatorio di Milano ma da dieci anni in India. Le percussioni dal vivo di Manjuanth, il violoncello di Natalia Rozario, soprattutto la voce di Faheem Mazhar esterna ai toni e modi occidentali con i suoi antichi lamenti e dolorose e roche suppliche che ci ha condotto laggiù, nel più profondo sonno della Terra. Tutti gli esseri dopo una prima esplosione vitale danzata sono caduti nel suo grembo oscuro, nelle nebbie emanate dal suo corpo madido, nel sopore indotto dalla bellissima nenia indiana su una nota lungamente tenuta dal violoncello, mentre lontano affiorava sulle braccia di qualcuno il corpo dell’Eletta sacrificata alla Terra. Il risveglio panico segnava l’esplosione degli istinti, in cui ancora e sempre si affermava l’inscindibile rapporto delle creature con la Terra, per concludersi col ritorno alla solarità del mondo occidentale nella dolce voce di Armstrong in A Wonderful World, “Vedo alberi verdi, anche rose rosse, le vedo sbocciare per me e per te”. Grande e meritato il successo di pubblico”.
(Paola Pariset, Nenie indiane su eroici scatti, Il Tempo, 16 ottobre 2004)
“Le braccia sembrano saette, mentre le gambe compiono complesse combinazioni. Attimi di stasi. Di nuovo movimenti velocissimi, audaci, sulle note di un violoncello, di percussioni, di una cantante. Un turbinio di intrecci, per una coreografia di pura danza. I ballerini a contatto col suolo, saltano strisciano, cercano di staccarsene. Ma la loro radice li lega alla terra, elemento che ha ispirato Ma – terra nel dialetto hindi, e anche madre – dell’anglo bengalese Akram Khan […]. Sul fondale che fa risaltare il marrone dei costumi, l’immagine iniziale di un uomo a testa in giù che intona una nenia, ci riporta all’infanzia del coreografo appeso agli alberi curioso di guardare il mondo al rovescio e far fluire i pensieri verso la terra. Un’attrazione ripresa dagli interpreti che danzano con la testa piantata al suolo. Germogliare di piante, lotte, conquiste e libertà (come il magnifico duetto di un uomo che vorrebbe tenere prigioniera una donna), culminano nella canzone A Wonderful World, il desiderio cioè di un mondo meraviglioso. E le braccia dei danzatori in controluce, aprendosi sembrano arrendersi ad una pace ritrovata”.
(Giuseppe Di Stefano, La Terra di Khan, Città Nuova, novembre 2004)
“Spettacolo magico con grandi simbologie sacre e filosofiche in cui gli dei non sono avvertiti come esseri reali, ma come semplici proiezioni illusorie di elementi appartenenti alla psiche umana. La prima scena mostra un’immagine illuminata di una figura a testa in giù, mentre dal buio emergono piano piano i danzatori, il violoncello il caratteristico “mridanga” indiano con il “cantastorie Mazhar”. Le luci giocano magistralmente in uno sfondo amaranto di grande suggestivo effetto. Quadri movimentati e quadri mistici talmente sofisticati da suscitare l’impressione che si tratta più che di una rappresentazione scenica, di un mistero, di una vera e propria celebrazione religiosa”.
(Liliana Speranza, Akram Khan al teatro Argentina: Danze esoteriche, L’Attualità , ottobre 2004)