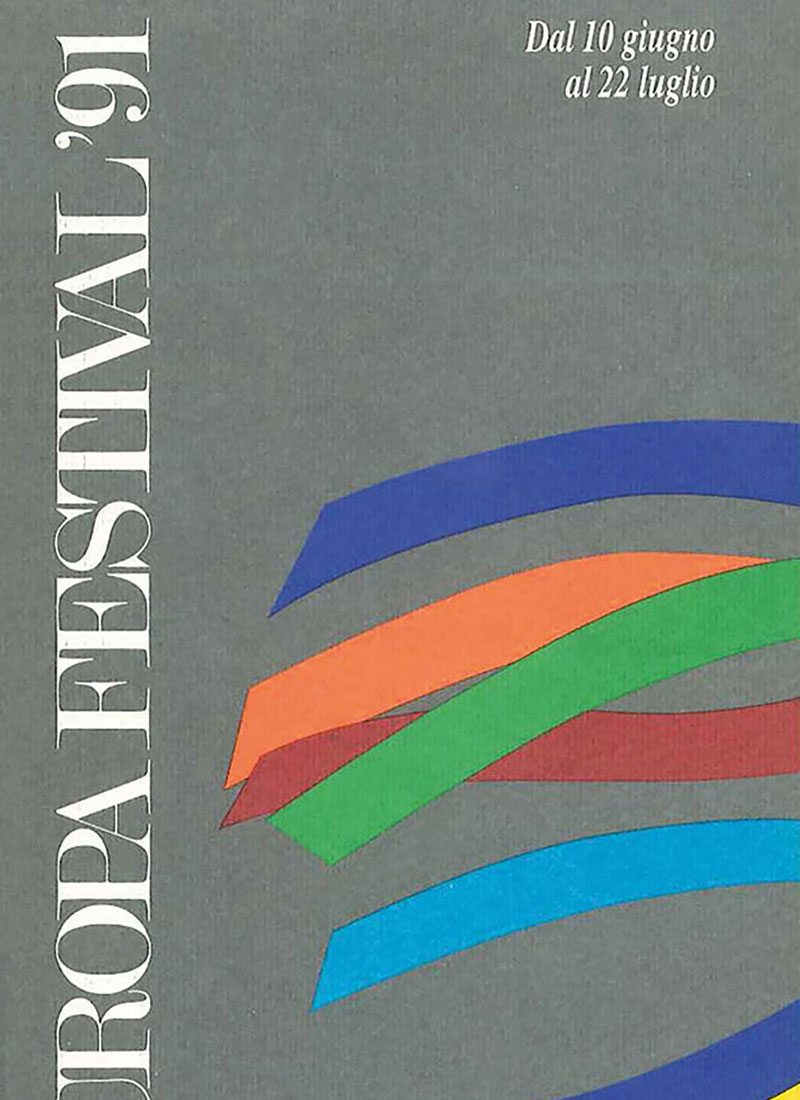Per la serata Passaggio del ventesimo secolo Pierre Boulez ha presentato una scelta di brani forse poco noti, ma che rivendicano un assunto del grande compositore: non si può parlare di un linguaggio comune tra i musicisti del Novecento, poiché ognuno di essi ha sviluppato una linea personale, al di là dei principi che rimandano alle diverse scuole. Ad eccezione del brano di Edgar Varèse, Intergrales, tentativo di integrazione di timbri strumentali inconsueti, che data 1923, gli altri sono stati composti negli anni Sessanta e Settanta: Estri di Goffredo Petrassi del 1967 appartiene all’ultimo periodo dell’autore e ne riflette lo stile più maturo; Ritorno degli Snovidenia di Luciano Berio del 1976 si pone come punto d’incontro fra le diverse tecniche compositive sempre innovativamente percorse dal compositore; Couleurs de la Cité Cèleste di Oliver Messiaen del 1963 segna l’inizio di un’attività creativa più narrativa e meno ermetica; Modulations di Gérard Grisey del 1978 – composta per i 70 anni di Messiaen – ha la sua genesi in un elemento particolarmente amato dal compositore, il silenzio, nella sua veste di misura della distanza fra un suono e l’altro.
Pierre Boulez, alla guida dell’Ensemble Intercontemporain, nel comporre il repertorio per questo concerto, come ama fare, ha lasciato che rimandi, intrecci, associazioni creassero un tessuto fra le opere presentate tale da determinare una struttura musicale comprensiva delle singole drammaturgie.
Passaggio del ventesimo secolo
Direttore Pierre Boulez
Musica Edgar Varése (Integrales), Goffredo Petrassi (Estri), Luciano Berio (Ritorno degli Snovidenia), Olivier Messiaen (Couleurs de la Cité Cèleste), Gérard Grisey (Modulations)
Solisti (dall’Ensemble Intercontemporain) Jean Guihen Queyras (violoncello), Florent Boffard (pianoforte)
Ensemble Intercontemporain Sophie Cherrier, Emmanuelle Ophèle (flauto), Laszlo Hadady, Didier Pateau (oboe), Alain Damiens, André Trouffet (clarinetto), Guy Arnaud clarinetto (basso), Pascal Gallois, Paul Riveaux (basso), Jacques Deleplancque, Jens Mc Manana (corno), Antoine Curé, Jean-Jacques Gaudon (tromba), Jérome Naulais, Benny Sluchin (trombone), Gérard Buquet (tuba), Vincent Bauer, Michel Cerutti, Daniel Ciampolini (percussioni), Pierre Laurent Almard, Florent Boffard (piano/tastiera), Marie Claire Jamet (arpa), Jeanne Marie Conquer, Jacques Ghestem, Maryvonne Le Dizês (violino), Christophe Desjardins (viola), Pierre Strauch, Jean Guihen Queyras (violoncello), Frédéric Stochl (contrabbasso)
e con Jerome Gaubert (flauto), Pierre Dutrieu (clarinetto), Claude Dolangle (sassofono), Pierre Thibaud, Jean Luc Ramecourt (trombe), Olivier Voize, Charly Vestraete, Jean Douay (tromboni), Eve Payeur, Isabelle Cornelis, Christophe Bredeloup (percussioni), Pascal Godart (pianoforte), Agnés Sulem, Marie Christine Millière Charrin (violini), Geneviève Strosser, Françoise Bordenave (viole), Chrìstophe Roy, Ariane Lallemand (violoncello), Axel Bouchaux (contrabbasso)
PASSAGGIO DEL XX SECOLO
di Arrigo Quattrocchi
Edgar Varèse
A quasi trent’anni dalla scomparsa, Edgard Varèse è riconosciuto come uno degli autentici maîtres à penser del Novecento storico in campo musicale; una schiera eletta alla quale appartengono Stravinsky, Schönberg, Bartók e pochissimi altri. A distinguere Varèse da questi compositori c’è tuttavia un destino particolare: quello di non aver esercitato una influenza diretta e militante nel breve periodo della sua attività , ma di aver dovuto attendere un quarto di secolo perché la sua musica venisse per così dire “scoperta” e studiata come quella di un “precursore” da parte dell’avanguardia del secondo dopoguerra. Una simile vicissitudine è spiegabile con il carattere totalmente rivoluzionario dell’opera di Varèse.
Già la biografia del compositore ha dei tratti estremamente peculiari. Nato a Parigi da padre italiano, Varèse rinuncia agli studi scientifici per quelli musicali, e compie questi ultimi nell’ambito della solidissima scuola francese, prima alla Schola Cantorum di D’Indy e poi al Conservatorio. Su questa formazione si innesta l’influenza della “nuova estetica dei suoni” di Busoni, consciuto a Berlino nell’anteguerra. Nel 1915, la rottura con il passato e il trasferimento negli Stati Uniti, dove si tratterrà stabilmente, con l’eccezione di un breve periodo (1928-32) trascorso nuovamente in Francia. È appunto negli anni compresi fra il 1915 e il 1932 che Varèse concentra la propria attività di compositore, scrivendo tutti i lavori principali del proprio esiguo catalogo. È degli anni Cinquanta una doppia svolta, quella del ritorno alla composizione, ma con mezzi elettronici, e del pieno riconoscimento da parte delle nuove leve di compositori, con l’invito ai corsi di Darmstadt.
Integrales, scritto fra la fine del 1923 e l’inizio del 1925 ed eseguito a New York l’1 marzo 1925, rientra nel gruppo delle opere maggiori, ed è emblematico della poetica dell’autore. Non è un caso che, per spiegare la musica di Varèse, i critici siano spesso ricorsi ad allusioni figurative, stabilendo relazioni con gli architetti del Bauhaus ed i pittori cubisti. In effetti è l’intera organizzazione del suono e del discorso musicale che avviene, in Integrales come nelle opere coeve, secondo criteri rivoluzionari che ignorano del tutto i parametri di melodia, armonia, ritmo, sviluppo, elaborazione e simili, propri della tradizione europea.
Il titolo di Integrales allude al calcolo matematico e alla “valutazione”, alla “comprensione” di uno spazio. Secondo le parole dell’autore “Integrales è stato concepito per una proiezione spaziale. Costruii il lavoro pensando di impiegare certi mezzi acustici che ancora non esistevano, ma che sapevo avrebbero potuto essere realizzati e utilizzati, prima o poi”. Proprio Integrales era stato scelto dall’autore, negli ultimi anni di vita, per una rielaborazione elettronica (poi non compiuta). Infatti la partitura precorre la concezione sonora del linguaggio elettronico. Già la strumentazione è indicativa, escludendo del tutto strumenti “comunicativi” come gli archi, e limitando la scelta a strumenti più impersonali, come fiati e percussioni. I fiati coprono l’intero spettro sonoro, le percussioni, impiegate in modo massiccio (diciassette strumenti per quattro esecutori) si richiamano alla predilezione dell’autore per i “rumori” cittadini.
Il brano si sviluppa secondo l’opposizione di piani e volumi sonori, “fasci di suono” in continua trasmutazione, quasi secondo un processo di “cristallizzazione”. Una nota cardine si pone come punto di riferimento per queste trasformazioni e “cristallizzazioni” del suono. Ritmo e timbro diventano valori assoluti, i frammenti melodici presenti sono solo uno dei tanti elementi, senza alcuna funzione di guida del discorso. Così avviene anche per il frammento tematico – esposto in una sezione centrale da trombe e corni – simile al tema creato da Ravel per il Bolero, tre anni più tardi: una scheggia priva di qualsiasi referente esterno, elemento variabile della nuova organizzazione del flusso sonoro.
Goffredo Petrassi
“Estri è dedicato a mia moglie, la pittrice Rosetta Acerbi. Mia moglie è veneziana. I veneziani dicono che hanno estro di far o non fare una data cosa. Io ho avuto estro di farla e mi è sembrato del tutto naturale offrirla a chi pone l’estro come condizione di vita”. Queste le parole della dedica di Estri, composizione che è stata terminata da Goffredo Petrassi nel 1967 ed ha avuto la prima esecuzione nell’aprile di quell’anno presso l’Hopkins Center di Hannover negli USA, istituzione che aveva commissionato la partitura. La prima europea avvenne poi presso l’Accademia Filarmonica Romana. Ma la fortuna della composizione è legata anche alla versione coreografica realizzata da Aurelio Milloss, per il Festival di Spoleto 1968, e destinata a grande diffusione; una coreografia che rinnovava la collaborazione fra compositore e coreografo, non più replicata dopo gli incontri degli anni Quaranta, con La Follia di Orlando e Ritratto di Don Chisciotte. Tuttavia una notevole distanza separa Estri da quelle partiture teatrali.
La rivelazione di Petrassi era avvenuta, nel 1932, con la Partita per orchestra, espressione di un neoclassicismo filtrato attraverso Casella. In seguito Petrassi si guadagnò la definizione di “barocco romano” per le opere religiose e corali degli anni Trenta e Quaranta, affiancate da sporadiche esperienze teatrali (fra cui i balletti citati). Nella maturità il compositore si è orientato poi decisamente verso composizioni puramente orchestrali, con la serie degli otto Concerti. Nei suoi anni più recenti invece si è dedicato principalmente agli organici cameristici, e si è aperto inoltre alle tecniche dodecafoniche, adottate comunque sempre con grande libertà e personalità .
Estri è una composizione che si colloca appunto agli inizi di questa ultima fase e riflette quindi lo stile più maturo dell’autore, improntato ad un contrappunto definito da Massimo Mila non più “hindemithiano”, ma “alla Scarlatti: leggerissimo e allusivo, una specie di contrappunto-fantasma, tutto rapidi scorci ed elisioni, risolto nell’immediatezza di fugaci tocchi luministici”. Lo stesso titolo della composizione è in un certo senso allusivo di questa ultima poetica di Petrassi. L’autore ha scritto a questo proposito: “Estri è un termine che significa molte cose: immaginazione, inventiva, cambiamenti d’umore, improvvisazione e, in generale, quei subitanei moti dell’animo che vengono filtrati dalla fantasia”.
Parole in uno stile fiorito gustosamente retrò, dietro le quali si cela tuttavia una tendenza all’astrazione concettuale filtrata attraverso un ferreo controllo della materia sonora. Ne fa fede lo stesso organico orchestrale, che consiste in cinque gruppi di tre strumenti ciascuno, selezionati secondo il timbro: tre legni, tre ottoni, tre archi, tre tastiere, tre percussionisti. Ed è proprio il timbro (si pensi alle tastiere: cembalo, celesta, vibrafono) una delle variabili della “estrosità ” della partitura. I gruppi strumentali si presentano sia singolarmente sia in molteplici e cangianti aggregazioni. Il gioco dei contrasti e delle sovrapposizioni, degli scarti dinamici e discorsivi, realizza caleidoscopiche possibilità concertanti; vi possiamo cogliere due costanti della personalità dell’autore nel tempo, attraverso i cambiamenti stilistici: fantasia e razionalità .
Luciano Berio
Alla metà degli anni Settanta la ricerca musicale di Luciano Berio seguiva strade piuttosto dissimili da quelle frequentate dal compositore nei decenni precedenti. Berio è passato infatti attraverso tutte le esperienze dell’avanguardia; dagli esordi sulla scia di Ghedini e Dallapiccola, all’adesione al serialismo, all’uso delle tecniche elettroniche (presso lo Studio di Fonologia di Milano della Rai, da lui fondato e diretto con Maderna dal 1955), alle procedure aleatorie, al ritorno al teatro, all’elusione degli sperimentalismi. Un percorso che sembra procedere verso una progressiva involuzione, e che invece ha sempre trovato ad ogni nuova tappa nuovi spunti di rinnovamento.
Proprio la crisi dell’avanguardia, fatale a molti altri compositori “sperimentalisti”, mise pienamente in luce, agli inizi degli anni Sessanta, quello che era già un tratto caratteristico della personalità di Berio e che doveva rimanere tale negli anni successivi: la capacità “artigianale” del fare musica, di assimilare e rielaborare gli spunti più dissimili, le più varie suggestioni culturali (Monteverdi, Boccherini, Mahler, folk, jazz), nella piena consapevolezza del valore “fisico” del suono, del predominio della prassi sulla teoria, dell’importanza della pura tecnica compositiva.
Il ritorno degli snovidenia non si sottrae a questa concezione “artigianale”, e si pone nel contempo come punto d’incontro di diverse tecniche compositive proprie dell’autore. Il brano fu commissionato nel 1976 da Paul Sacher per l’Orchestra da Camera di Basilea e il violoncellista Mstislav Rostropovic, allora espatriato in occidente da un paio d’anni. Quasi obbligato il riferimento, nella composizione, alle vicende dello stato sovietico. La parola russa snovidenia ha infatti il significato di “sogni nostalgici”, quelli della rivoluzione d’ottobre.
Ha scritto Berio a questo proposito: “Il Ritorno è soprattutto un omaggio a un sogno tradito dalla storia, dagli uomini e dallo stalinismo. – È possibile trasporre il tradimento in una dimension musicale? – Credo di no. Anche se queste idee possono certamente svolgere un ruolo importante nel mio inconscio, ciò non avviene a un determinato livello musicale. Il materiale svolge soprattutto una funzione musicale”.
Punto di partenza della partitura sono tre frammenti di canti rivoluzionari russi (scelta che si riallaccia anche all’attenzione mostrata da Berio verso i materiali popolari). Questo materiale di base diviene oggetto di continue elaborazioni, secondo una logica che sintetizza diverse teniche gia precedentemente impiegate da Berio: il predominio di una linea melodica centrale, intorno alla quale vengono generati processi armonici sempre in evoluzione; il ritorno ciclico, in costanti metamorfosi, del modello di base (un ritorno a cui si riferisce, indirettamente, anche il titolo del brano).
Dal punto di vista formale la composizione si articola come una climax seguita da una anticlimax, con lo sviluppo di un accelerando parallelo all’intensificazione della complessità armonica, seguiti da un processo inverso. Ma un altro problema è alla base della partitura; quello del rapporto fra il solista e l’orchestra, che non si basa su una semplice ripartizione di ruoli (guida-accompagnamento), ma su una continua interazione, un continuo scambio, in cui l’orchestra trasforma incessantemente in sfondo armonico le note suonate dal solista; soluzione personalissima a un problema antico e “tradizionale” della letteratura per solista e orchestra.
Olivier Messiaen
In Olivier Messiaen la cultura musicale del Novecento ha trovato uno dei suoi esponenti più complessi e problematici; tanto che i tentativi di inserire il maestro di Avignone nell’una o nell’altra corrente sono apparsi quasi sempre indebiti, ed hanno comunque mortificato la poliedricità della sua personalità . L’aspetto di Messiaen che più è stato esaltato dalle avanguardie del secondo dopoguerra, che hanno trovato in lui uno dei più autorevoli “precursori”, è quello “tecnicistico”. Messiaen infatti già nell’anteguerra fondò il proprio linguaggio sul totale cromatico, non già però sulla base delle tecniche dodecafoniche, ma su un personale sistema di “modi a trasposizione limitata”. Tecnicismo vi è anche nella ricerca ritmica, nei ritmi “non-retrogradabili” derivati dai metri indiani.
E già in quest’ultimo fatto vediamo un’altro aspetto fondamentale del compositore, l’interesse per le culture non-eurocolte e distanti dall’evo moderno; così il compositore ricorre alla piena acquisizione dei metri greci antichi, medioevali oltre che indiani. Vi è poi un Messiaen “naturalista”, studioso dell’ornitologia e degli sterminati canti degli uccelli, espressione di una purezza primigenia. Vi è ancora un Messiaen organista ed uno tradizionalista, esponente della scuola francese ed erede di Berlioz e Debussy.
Probabilmente la chiave di volta per integrare tecniche compositive e suggestioni culturali tanto dissimili è quella del misticismo, aspetto spesso sottovalutato, forse perché quasi imbarazzante nella cultura contemporanea. Il misticismo di Messiaen è fondato su una incrollabile fede cattolica, e nutrito del simbolismo che permea tanta parte della cultura francese. Materiali e tecniche si coagulano così in una prospettiva visionaria.
Appunto misticismo e simbolismo sono alla base di Couleur de la cité cèleste, composizione scritta nel 1963 e eseguita al Festival di Donaueschingen il 17 ottobre 1964, sotto la direzione di Pierre Boulez. Il brano segna l’apertura di una nuova fase nella vicenda compositiva del maestro, una fase che abbandona l’intensa ricerca speculativa e l’ermetismo degli anni del dopoguerra, in favore di una nuova semplicità di linguaggio e di una chiarezza strutturale e stilistica.
I “colori” del titolo si riferiscono a cinque citazioni tratte dal Libro dell’Apocalisse:
1) “Un arcobaleno circondava il trono…” (Apoc. IV, 3).
2) “E i sette angeli avevano sette trombe…” (Apoc. VIII, 6).
3) “Si diede alla stella la chiave del pozzo dell’abisso…” (Apoc. IX, 1).
4) “Lo splendore della città santa somiglia al diaspro cristallino…” (Apoc. XXI, 11).
5) “Le fondamenta del muro della città sono adorne di tutte le pietre preziose: diaspro, zaffiro, calcedonio, smeraldo, sardonice, cornalina, crisolito, barillo, topazio, crisofrazo, giacinto, ametista…” (Apoc. XIX, 20).
La partitura stabilisce una corrispondenza imaginifica fra colore e suono. La strumentazione comprende pianoforte, tredici fiati e percussioni. Brevi sequenze si succedono in un montaggio continuo, giustapponendo alleluiatici canti gregoriani, canti d’uccello di diversi paesi, ritmi indiani e greci, permutazioni di durata. Tutti questi elementi sono posti al servizio delle trasformazioni timbriche, che seguono la logica di aggregazione dei colori: colori caldi e freddi, fondamentali e complementari, tesi alla luce o al buio. Accanto a misticismo e simbolismo si fa strada un altro elemento della poetica di Messiaen, quasi conturbante dato l’assunto del brano: la sensualità del suono.
Gérard Grisey
Nato a Belfort nel 1946, Gérard Grisey si è affermato fra i compositori francesi più autorevoli della sua generazione, dopo un curriculum di studi e riconoscimenti non meno che prestigioso. Ha compiuto gli studi prima in Germania, a Trossingen, con Helmut Degen, e poi al Conservatorio di Parigi, sotto la guida di Messiaen (1968-72). Fra i suoi insegnanti anche Stockhausen, Ligeti e Xenakis (ai corsi di Darmstadt del 1972) e, per l’elettroacustica, Jean Etienne Marie. Ha vinto il primo premio della Biennale Internationale de Paris nel 1971, il premio Hervé-Dugardin della SACHM nel 1973; è stato borsista di Villa Medici a Roma (1972-74). Nel gennaio 1973 è stato fra i fondatori dell’Ensemble Itinéraire creato da un gruppo di compositori ed interpreti con il proposito di lottare contro la crisi della musica contemporanea.
Alla base della scrittura musicale di Grisey si pongono i processi di mutazione da un suono a un altro suono, da un insieme di suoni a un altro insieme, in un continuo divenire. Altri interessi riguardano la spazializzazione della musica, nonché l’invenzione di timbri sintetici, ottenuta tramite sperimentazioni acustiche sulla materia prima non temperata.
Su Modulations per 33 musicisti, brano commissionato dall’Ensemble Intercontemporain e eseguito a Parigi il 9 marzo 1978, l’autore stesso ha scritto una breve nota.
“Questa partitura è dedicata a Olivier Messiaen in occasione del suo settantesimo compleanno. In Modulations tutto è in movimento. Soli ancoraggi in questa deriva lenta e insieme dinamica: uno spettro di armonici in mi (41,2 herz) e delle durate periodiche.
La forma di questo pezzo è la storia stessa dei suoni che lo compongono. I parametri del suono sono orientati e diretti per creare numerosi processi di modulazione, processi che si basano ampiamente sulle scoperte dell’acustica: spettri d’armonici, spettri di parziali, transitori, formanti, suoni addizionali, suoni differenziali, rumor bianco, filtraggi ecc.
Grazie all’attenzione portata costantemente, non più sul materiale stesso, ma sul vuoto, sulla distanza che separa l’attimo percepito dall’attimo seguente (grado di cambiamento o di evoluzione), io penso di essermi avvicinato un poco al tempo essenziale, non più tempo cronometrico ma tempo psicologico e suo valore relativo”.
Rassegna stampa
“Chi aveva mai ascoltato Petrassi eseguito con così netta lucidità di timbri, o Berio con così calda pasta cantabile, merito anche dello strepitoso violoncello di Jean Guihen Queyras, un giovane di 24 anni che farà molto parlare di sé? Ma c’era anche il percorso duro, ascetico di Messiaen, e infine quell’affascinante trasmutarsi di piani sonori che è la musica di Grisey. Per Messiaen, bravissimo pianista il giovane Florent Boffard. Per tutti, inimitabile e docile strumento l’Ensemble Intercontempoirain. E a giudare tutti, la mente più lucida della musica di questo secolo, Boulez”.
(Dino Villatico, Trionfa Boulez, la Repubblica, 19 luglio 1991)
“Così Varèse ha dimostrato più che mai, nelle mani sapienti del Compositore-Direttore, la sua vena ripetitiva, il richiamo ossessivo all’universo definito “simbolico” da Boulez, quello dei soli legni e degli ottoni; niente archi, ma l’uso intenso delle percussioni. Il medesimo “corpo” sonoro che si ritrova esattamente nella musica di Messiaen, compresi tuttavia (nelle percussioni) il ridondante xilofono e un punitivo pianoforte, tutto strappi. L’uso dello spazio strumentale, da parte di Grisey, si richiama alla scuola degli spettri: “Non dico spettri, come nel teatro shakespeariano”, ha precisato Boulez, ma si tratta degli accordi d’effetto spettrale provocati dalle risonanze degli armonici naturali. Quanto agli Estri erano un omaggio di Boulez all’amico Petrassi, “alla sua favolosa capacità di seguire i mutamenti generazionali del vocabolario musicale”. Quindi Snovidenia di Berio: l’addio al “rigore che ci ha segnato negli anni Sessanta”. Il ritorno a qualche dolcezza ornamentale. Alla fine un’ovazione al grand’uomo Boulez”.
(Maya Tannenbaum, Un genio ci conduce nel ventesimo secolo, Corriere della sera, 19 luglio 1991)
“Così, gli Integrales (1925) di Edgar Varèse rappresentano senza dubbio lo strato più profondo e denso della sperimentazione sulla “spazialità del suono”, ma le “avanguardie” europee degli anni Sessanta e Settanta, pur correndo lungo lo stesso perimetro della ricerca varesiana, ne sono totalmente, quasi polemicamente indipendenti: come dimostrano il puntillismo timbrico del Petrassi di Estri, le sinestesie suono-colore del Messiaen di Couleurs de la Cité Cèleste, la distruzione-ricostruzione della forma concertante tentata da Berio con Ritorno degli Snovidenia, persino le esasperazioni fisio-acustiche di Modulations di Gèrard Grisey, la pagina più “giovane” (1978) del programma. Inutile insistere ancora una volta sulla affilatissima, cristallina intelligenza esecutiva dell’Ensemble allevato e diretto da maître Boulez”.
(Guido Barbieri, Boulez alla corte del Novecento, Il Messaggero, 20 luglio 1991)