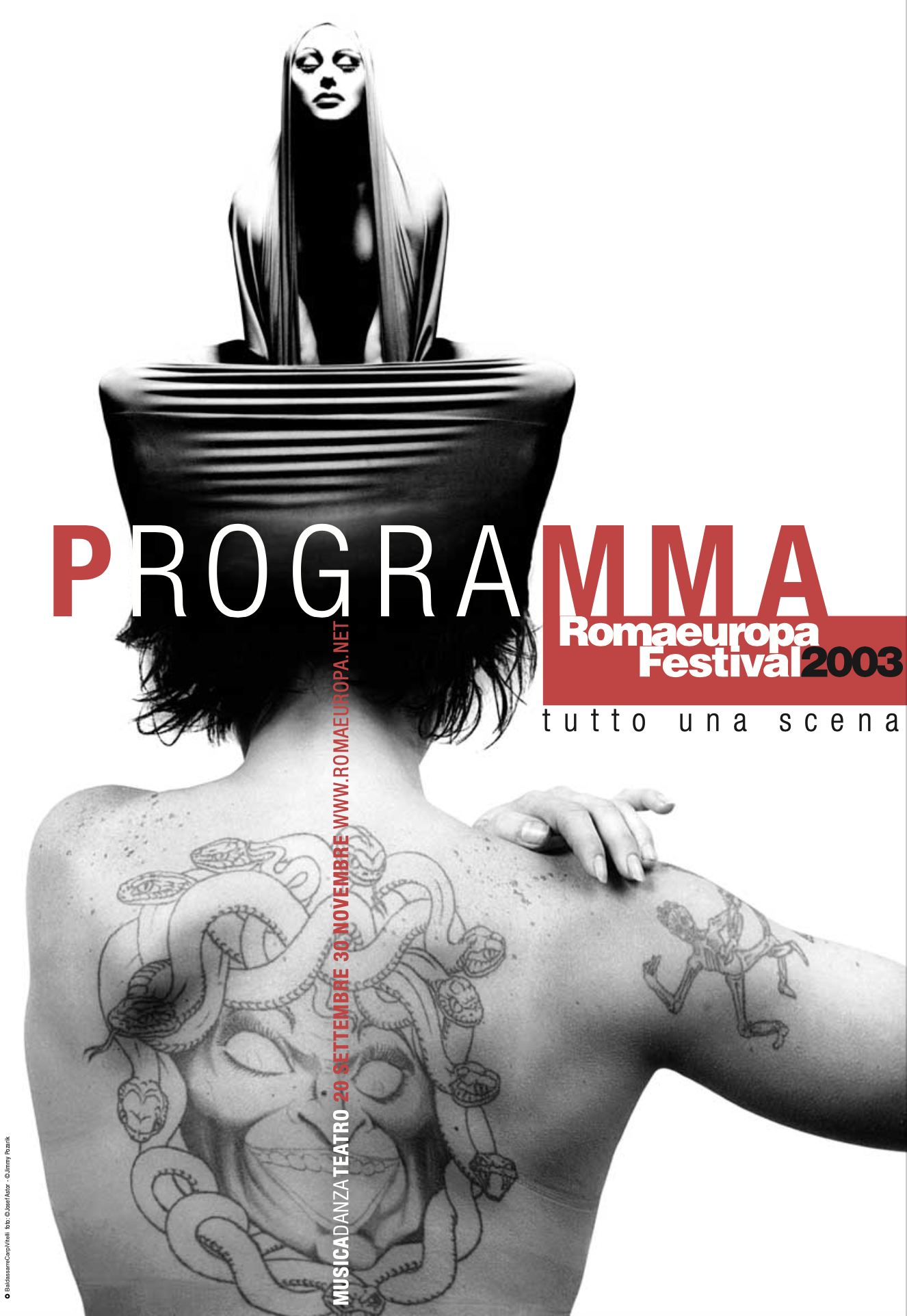Prima nazionale
Shadows è un monologo commovente e suggestivo sulla discriminazione e l’intolleranza, una denuncia a futura memoria di ciò che la paura del diverso e la crudeltà degli stereotipi sociali possono comportare per i più deboli.
William Yang, fotografo e narratore, si muove con umanità fra le ombre del passato per capire e sentire meglio il presente, illumina con le sue infinite, delicate e dolorose proiezioni un viaggio sul senso della vita, rendendo omaggio a coloro a cui la vita non ha dato molto. In Shadows narrazione documentaria, diapositive incrociate e riflessioni personali accompagnano e suggeriscono un pellegrinaggio epico fra le vicende di due popolazioni diversissime (gli Aborigeni del Nuovo Galles del Sud e gli immigrati tedeschi), egualmente emarginate e culturalmente sfigurate dalla maggioranza anglosassone dell’Australia, fra le due guerre mondiali.
Lo spettacolo nasce dalla “riconciliazione” tema del festival di Adelaide dal quale era stato commissionato, tuttavia quella riconciliazione che all’inizio sembrava porre a Yang una questione piacevole – “riconciliazione significa prendere insieme due parti e adoperarsi per la comprensione l’una dell’altra” – svela a poco a poco, nel corso delle ricerche, le “azioni oscure nel passato che avevano causato molti screzi. Con il titolo Shadows alludo a quel passato poco chiaro”.
Yang infatti non si limita unicamente a raccontare, ma compie piuttosto un gesto di comprensione e riconciliazione per immagini, parole e gesti, un tentativo di annullare le distanze e d’infrangere, sempre nella più piena coscienza del passato, le barriere che separano le vite di oggi a causa di antichi rancori e recriminazioni, solo apparentemente inscritti nei geni degli individui.
Dopo Sadness, Shadows. Perché questo titolo?
In totale ho realizzato otto performance, e le due più impegnative sono proprio Sadness e Shadows. La prima indagava argomenti come la morte e la perdita mentre Shadows ha a che fare con la riconciliazione. È un lavoro fatto su commissione per i festival di Adelaide, Sydney e Perth. Il tema del festival di Adelaide era la riconciliazione, concetto che in Australia è legato alla riconciliazione con gli aborigeni. All’inizio pensavo che la riconciliazione sarebbe stata una performance piacevole: riconciliazione significa prendere insieme due parti e adoperarsi per la comprensione l’una dell’altra. Ma più mi addentravo nelle cose e più scoprivo che c’erano azioni oscure nel passato che avevano causato molti screzi. Con il titolo Shadows alludo a quel passato poco chiaro.
Le fotografie riescono a toccare i territori delle emozioni ma anche quelli dell’identità …
Ho cominciato a fare proiezioni negli anni ottanta e i miei primi spettacoli erano audiovisivi, immagini e musica. E le emozioni venivano comunicate attraverso quel doppio registro. Tendevano però ad essere astratte perché non c’erano testi. Mi veniva naturale, mentre proiettavo le diapositive, di commentarle. Questo mi permetteva di dare un contesto alle immagini e di sviluppare una narrazione. La maggior parte dei miei lavori ha un carattere autobiografico e l’identità è una questione rilevante – sono gay, un australiano, cinese di nascita ma allevato in tutto come un australiano – e talmente complessa che è meglio sviscerarla attraverso parole e testi.
Come convivono immagini e parole nei suoi spettacoli?
Il mio lavoro si basa sempre, essenzialmente, sulle fotografie. Quando comincio premo il bottone per far girare le diapositive, ne scelgo una e poi le parole vengono da sole. A volte non ho proprio l’immagine corrispondente a quello che sto dicendo e allora la invento… ma questo accade in qualsiasi lavoro documentaristico. È sempre meglio esserci stati nei posti che mostri, rende tutto più efficace. Ho anche sviluppato un modo di narrare piuttosto audace. Saltello qua e là attorno a un evento e il pubblico deve connettere le varie parti di una storia. In genere, agli spettatori questo piace perché non è prevedibile e non segue stereotipi. Si divertono a esercitare il cervello e l’immaginazione per dare un senso al mio lavoro.
Lei è un grande viaggiatore. Pensa che l’attuale condizione umana sia quella di una continua migrazione?
Viaggio in differenti parti del mondo per costruire le mie performance e questo mi permette di entrare in contatto con culture lontane e di incontrare i vari membri della mia famiglia, disseminati per il pianeta. I miei nonni migrarono dal sud della Cina in Australia nel 1880 e si può ben dire che ho un passato di migrazioni. Gli australiani sono comunque dei grandi viaggiatori perché si sentono isolati dal resto del mondo e hanno la necessità di guardarsi intorno. Non credo però che la condizione moderna dell’essere umano sia il continuo migrare. La gente che desidera partire vive condizioni pessime nel suo paese. Dall’altra parte, molte persone sono spaventate da questi flussi perché temono che gli “stranieri” diventino troppi. Chi si sposta cerca un’esistenza migliore. I miei parenti sono andati in America sperando di fare più soldi.
Cosa pensa della globalizzazione?
È il mondo che sta diventando inglobale. Solo le grandi imprese esistono, le piccole non hanno margini e competere. Il “cottage industry”, l’industria artigianale va scomparendo e così i suoi mestieri. Il mondo tende a ripetere questo schema, come le sue metropoli.
Quali sono i prossimi progetti?
Con Shadows mi sono immerso nella questione della sofferenza umana e ne sono rimasto invischiato. Il prossimo lavoro sarà qualcosa di molto personale, una specie di dissertazione filosofica su come costruiamo i significati della nostra vita. Viviamo in tempi incerti, dobbiamo considerare con attenzione i nostri valori, evitare di danneggiare il pianeta e gli altri popoli. Sebbene questo sia un argomento serissimo, spero faccia divertire.
(Arianna di Genova, Dietro le ombre del passato, il manifesto, 2 novembre 2003)
SHADOWS
di Francesco Di Giovanni
Shadows è un viaggio fotografico ed autobiografico attraverso la discriminazione, i pregiudizi, le sofferenze e la speranza.
Il racconto di William Yang comincia nel 1980 all’Adelaide Festival: qui egli allestì un’esposizione di sue fotografie che ritraevano le “sottoculture” della città di Sydney. Ricavò impressioni contrastanti dal quel suo viaggio a Adelaide. Lo colpì l’esibizione di un gruppo di aborigini di Mornington Island, e lo colpì il fatto che il loro concerto fu relegato nel cortile della biblioteca, fuori dal programma del festival, ai margini.
Nel 1981 il nuovo direttore del festival scelse Yang come fotografo ufficiale per l’edizione successiva e partirono insieme a ritrarre gli artisti in giro per il mondo. Fu così che si ritrovarono a Berlino Est, oltre la cortina di ferro ed il muro che divideva la città . Durante la sua visita al Pergamon Museum, Yang si stupì di trovare così familiare quell’ambiente europeo che distava migliaia di chilometri dalla sua Australia. E si rese conto che lui, come milioni d’australiani, aveva avuto un’educazione così profondamente europea da sradicarlo quasi dalla sua terra.
La storia che ci racconta Yang continua a Enngonia, una cittadina nel Northern New South Wales, negli anni Ottanta. Di Enngonia era originario Fulla, un ragazzo aborigeno adottato dal pittore di Bundeena George Gittoes e da sua moglie Gabrielle, amici di William. Quando adottarono il ragazzo, i Gittoes chiesero il permesso a Ruby Eulo, sua nonna, perché questa è l’usanza fra gli aborigeni; entrarono a stretto contatto con la comunità di Enngonia prima di diventare co-genitori di Fulla. Quando Fulla compì ventuno anni William partì per Enngonia con Gabrielle e suoi figli Harley e Naomi (George era all’estero). Lì conobbe la famiglia naturale di Fulla e della nonna Ruby, originari della città di Eulo (che in lingua aborigena significa “grande canguro”). Gli uomini della sua comunità erano stati mandriani nelle fattorie dei bianchi. Quando negli anni Sessanta entrò in vigore il minimo salariale, i latifondisti piuttosto che aumentare loro la paga li cacciarono ed assunsero mandriani bianchi. Quella di Enngonia è una riserva: negli anni Ottanta il governo ha costruito nuove case per permettere agli aborigeni di vivere più dignitosamente.
Fulla, ormai un giovane forte e atletico, raccontò a Yang che la settimana prima era stato aggredito da un gruppo di ragazzi bianchi con una mazza da baseball: avevano cercato di colpirlo ma avevano avuto la peggio. Nonostante questo, fu Fulla a finire in galera e non loro.
Continua nel South Australia, la storia di Yang, a Hahndorf il più antico insediamento tedesco del continente. Lì si rifugiarono molte comunità provenienti dalla Germania intorno alle metà del diciannovesimo secolo, quando il Kaiser impose la religione di stato ed i luterani vennero perseguitati. I tedeschi rappresentavano una delle minoranze più diffuse e rispettate del South Australia, ma la prima guerra mondiale trasformò ad un tratto quelle persone nel nemico. Vennero odiati, ancora perseguitati e rinchiusi in campi di internamento.
A quell’epoca l’identità nazionale australiana coincideva con quella britannica. La guerra che vedeva contrapporsi la Gran Bretagna alla Germania segnò l’emarginazione e l’oppressione di cittadini colpevoli soltanto delle loro origini. Oggi la comunità d’origine tedesca ha rimosso quella triste pagina della sua storia: persino al Museo per la Storia dei Tedeschi nel South Australia non esiste una sezione dedicati ai campi d’internamento di cui furono vittime durante le due guerre mondiali.
Il viaggio di Yang prosegue nella Berlino riunificata da ormai undici anni e profondamente cambiata. Yang riflette su come i desideri di molti cittadini tedeschi non si siano realizzati dopo la riunificazione.
Il racconto ritorna poi ad Enngonia, dieci anni dopo il primo viaggio. Yang si trova di fronte una comunità allo sbando, abbandonata dal governo e preda di un malessere diffuso. William rivede Fulla a un funerale: un uomo, ormai. Nei dieci anni precedenti ha avuto tre compagne e sei figli; con qualche lavoro saltuario cerca di crescere da solo i suoi tre figli più piccoli.
Nei giorni seguenti Yang riesce a farsi accompagnare in un sito dove decine di aborigeni furono trucidati dai bianchi. Sembra che questi massacri non fossero pianificati dall’alto, ma è giusto chiedersi se non si tratti comunque di una forma di genocidio.
Il racconto di William Yang prosegue nel museo ebraico di Berlino, passando attraverso le immagini di un campo di concetramento alle porte della città in cui nella seconda guerra mondiale vennero internati soprattutto prigionieri politici. Quando Harley, il sensibile figlio di George Gittoes, lo visitò, ne fu talmente spaventato da essere tormentato per mesi da orribili visioni.
Il viaggio di Yang si conclude in Australia, alla marcia per i diritti civili e la riconciliazione. Riconciliazione che è possibile soltanto se le ombre del passato vengono riconosciute e comprese, al fine di costruire una nuova speranza nel futuro.
SHADOWS
Teatro Valle, 31 ottobre, 1, 2 novembre 2003 Rassegna stampa
“Le ombre del titolo sono, alla lettera quelle proiettate dalle sue diapositive; e in senso metaforico quelle evocate dal racconto Yang potrebbe essere accostato ai nostri Paolini, Baliani, Curino, Celestini, in quanto affabulatore. Due segni stilistico-strutturali lo distinguono in modo netto. La musica suonata dal vivo implica un coinvolgimento nella performance di diversa e più intensa natura. In più questo coinvolgimento è testimoniato dalle diapositive: anche le diapositive sono sue, ma a differenza della musica distanziano l’oggetto della narrazione. In quanto alla narrazione vera e propria, c’è un punto di contatto con quella degli artisti italiani: Shadows trova il suo senso ultimo in una dimensione politica. È la rievocazione di due mondi scomparsi o in via di sparizione: degli aborigeni nel Nuovo Galles del sud e degli immigrati tedeschi in Australia. La sfera di percezione testimoniata da questo accostamento – tra aborigeni e tedeschi in fuga dall’Europa -, non ci parla tuttavia di una differenza ma appunto di una comunanza. È il senso di familiarità e nello stesso tempo di estraneità che Yang percepisce in se stesso, come cinese australiano di cultura europea: una presa di coscienza (tardiva, sopraggiunta dopo i quarant’anni) che lo spinge a Berlino, prima per caso, poi in una specie di pellegrinaggio. Da questo ulteriore accostamento, tra la Germania e l’Australia, tra il passato europeo e il presente australiano, scaturisce la precisa idea del genocidio come esperienza universale”.
(Franco Cordelli, Viaggio dall’Australia fino all’Apocalisse, Corriere della Sera, 2 novembre 2003)
“Si chiama Shadows ed è un viaggio. Un viaggio particolare che si svolge […] inanellando una serie di tappe, una “via crucis” tutta mondana e per nulla trascendentale, attraverso le immagini e le parole del fotografo e narratore australiano (ma di origine cinese) William Yang. Il suo è un coinvolgente monologo drammatico che racconta, tra Oceania e Europa, la paura del “diverso”, proponendo un pellegrinaggio visivo e visionario fra gli aborigeni del Nuovo Galles del sud e gli immigrati tedeschi. […] Nel fluire delle immagini, il genocidio degli aborigeni va a sovrapporsi ad un altro massacro quando William approda nelle sale del museo ebraico di Berlino. La seconda “location” è nel sud dell’Australia, a Hahndorf, il più antico insediamento tedesco del continente. Ma durante la Prima Guerra Mondiale quei tedeschi vennero ancora perseguitati e rinchiusi nei campi di internamento. Cambio di scena, Berlino dopo la riunificazione. Ecco la “riconciliazione” ma le ombre del passato non si dimenticano”.
(Arianna Di Genova, Dietro le ombre del passato, il manifesto, 2 novembre 2003)
Musica (composizione ed esecuzione) Colin Offord
Luci e diapositive Martin Langthorne
Produzione Performing Lines
Commissionato da Sydney Festival, Adelaide Festival, Perth International Arts Festival.