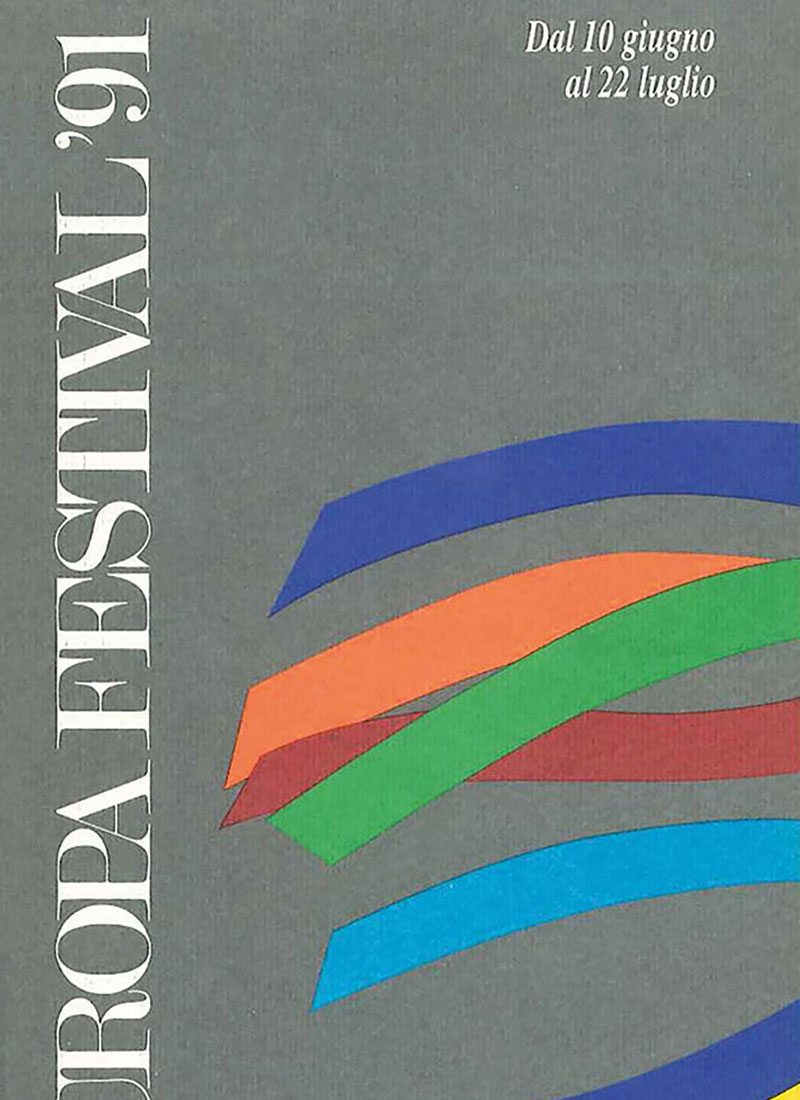Il ballerino di flamenco ha in sé qualcosa di ancestrale e primitivo nel suo battere il ritmo con le mani ed i piedi mentre il corpo si curva e volteggia, ma anche qualcosa di aristocratico in quel suo darsi fiero sulla scena. Una danza antica, carnale e sensuale, che si muove sulle corde di chitarra per sedurre e conquistare i corpi. La tragicità insita nelle voci e nei volti rimanda alla passionalità dell’atto d’amore ed alla fatale separazione e morte, temi centrali in tutte le espressioni del flamenco.
Per la serata due importanti compagnie – la Miguel Angel Ballet Espanol ed il Teatro Flamenco di Joaquin Ruiz – si sono unite, con cantaores e chitarristi, per creare Madrid Flamenco: un’antologia o meglio un viaggio attraverso passi, ritmi e coreografie di questa antica danza.
Miguel Angel e Joaquin Ruiz si sono avvicendati negli assoli – creando un tessuto fatto di storie danzate nutrite di tradizione e tecnica – per terminare infine in una coreografia che ha visto il coinvolgimento dell’intero ensemble.
Direttore Joaquin Ruiz
Interpreti Miguel Angel, Joaquin Ruiz, Tania, Charo Espino (danzatori), Manuel Palacin, Silverio (cantaores), Paco Cruz, José Losada, Diego Losada (chitarra)
SOLEA
Interprete Charo Espino
MARTINETE
Interprete Joaquin Ruiz
ALEGRIAS
Interprete Tania
FARRUCA
Interprete Miguel Angel
SEGUIRILLA- con assoli di chitarra
Interprete Tania
CANA- con assoli di chitarra
Interprete Charo Espino e Miguel Angel
ALEGRIAS- con assoli di canto
Interprete Joaquin Ruiz
FIN DE FIESTA- con assoli di canto
Interprete Miguel Angel, Joaquin Ruiz, Tania, Charo Espino (danzatori), Manuel Palacin, Silverio (cantaores), Paco Cruz, José Losada, Diego Losada (chitarra)
IL FLAMENCO, ANIMA DELLA SPAGNA
di Elsa Airoldi
Capelli crespi, occhi incupiti dalla memoria di remote passioni, corpo plastico scosso dal fremito di un zapateado che percuote la terra con rabbia impotente. È Mario Maya, bailaor gitano di Granada: che sia lui il flamenco?
Un vocalizzo lungo tormenta tra i suoi melismi le sillabe “Ay” e “LelÔ ed è tormentato da una voce nasale, raschiata, quasi impedita. La fantasia materializza un muezzin sulla cima di un minareto. Lui, ne siamo certi, conosce il mistero del flamenco. Certezze vane, non certezze.
Per il flamenco si sono versati fiumi di inchiostro; il numero degli esegeti, specie negli ultimi decenni, non si conta. Tuttavia nessuno è riuscito a trovare la parola definitiva. Almeno per quanto concerne genesi e filologia. Ché per contro, l’analisi musicale è avvantaggiata dall’osservazione di alcune forme ricorrenti. Consultiamo i sacri testi. Un capogiro di contraddizioni. Imperterriti, come consuetudine impone, iniziamo dall’etimo.
Da dove verrà il vocabolo “flamenco”? Dall’arabo, è ovvio: da fellah mengu che significa cantare come da falai kun che vuol dire contadino. Ma perché non dal provenzale ilama, insinua qualche ameno? Allude alla fiamma, al fiammeggiare. Mentre altri chiamano in causa i fiamminghi giunti in Spagna all’epoca di Carlo V, o meglio quei flamencos, ossia “felloni” in argot, che arrivarono sì dalle Fiandre ma erano orde gitane.
“Flamenco”, del resto, è anche il nome di un fenicottero rigido e impettito proprio come i cantaores flamenchi. Ma, se non fosse tutto per la parola “flamenco”, orizzonti infiniti si aprono per i termini ad esso connessi. Cante hondo ad esempio, per Falla il più antico canto andaluso e persino europeo, e per Louis Lucas il primo apparso in natura su imitazione del canto degli uccelli e del grido degli animali. In ogni caso un elemento che i più (ma non tutti) collegano al canto flamenco. Anche lui, il cante hondo, ha la sua brava radice lessicale. Potrebbe essere l’ebraico jom-hol, giorno buono; oltre che, è ovvio, l’andaluso jondo, profondo, intimo, segreto. Mentre olé, il grido di incitamento rivolto a tocaores, cantaores, e bailaores (suonatori, cantanti e ballerini) può scegliere tra il dionisiaco Evohé dei greci, l’espressione d’entusiasmo joleh degli ebrei e l’invocazione Allah degli arabi.
Quanto poi al significato del termine flamenco, leggiamo indifferentemente che con esso si intende ogni espressione della cultura gitana, oppure che è un vocabolo generico atto a indicare una particolare qualità di cante, baile e toque (canto, danza e assolo di chitarra) in uso in Andalusia e nella Spagna del sud.
C’è poi la questione del rapporto tra flamenco e cante hondo. Due mondi assolutamente autonomi, dice qualcuno; filiazione l’uno dell’altro, sentenziano altri; due differenti definizioni per lo stesso canto, sostengono altri ancora. Secondo una credibile classificazione raccolta da un recente studio di Israel J. Katz, il cante hondo altro non sarebbe che un tipo di canto flamenco.
Ma sia come si vuole, i dubbi che turbano i sonni di storici ed etnomusicologi nulla tolgono alla fatale imperturbabilità degli artisti impegnati sul “tablao” o nelle piazze di Siviglia. Come sulle scene dei grandi teatri del mondo. Più che i cantaores eredi di una feconda e celebrata tradizione, vagano per i continenti i bailaores. E anche i più preparati di essi, come Mario Maya, Antonio Gades o gli esperti ingaggiati dall’organo ufficiale del Ballet National de España, non se lo sognano nemmeno di spingere il discorso oltre qualche dissertazione accademica sulle danze regionali e su quelle di scuola “bolera”, e cioè su danza e musica segnate dalla contaminazione tra popolare ispanico e scuola classica franco-italiana: non a caso il critico catalano Alfonso Puig, alludendo alla scuola bolera, parla di “sintesi dell’ispanismo romantico”. Se già Marziale lodava le danzatrici di Cadice e Giovenale la passionalità dei cantaores, José Blas Vega riferisce come sul finire del Settecento fiorissero in Spagna tre scuole: quella di danza popolare, quella di nacchere e quella flamenca. E come le prime due assistessero alla “misteriosa” nascita della terza. I centri di flamenco, racconta Israel Katz, erano Triana (il quartiere gitano di Siviglia), Cadice, Jerez de la Frontera e le città di porto in genere. Si individua nel flamenco anche la prima matrice del genere teatrale popolare della tonnadilla.
Il flamenco vive il suo periodo d’oro tra il 1860 e il 1930. In tale lasso di tempo teatro naturale del genere sono i cafés cantantes (caffè-concerto) con i loro tablaos (pedane) dove gli artisti siedono in semicerchio. Nel 1880 in alcuni “cafés” appaiono le prime sottane a strascico e i primi cappelli a larga tesa. Nel 1914, all’Alhambra di Londra, Antonia Mercé, detta la Argentina, mette in scena Embrujo de Sevilla, sancendo il passaggio dal baile (comprensivo del flamenco) al balletto e dalla piazza al teatro. I punti di riferimento del genere, entrambi firmati Manuel de Falla, sono EI amor brujo e EI sombrero de tres picos. La stessa strada sarà poi battuta da Vicente Escudero, Encarnatión López, detta la Argentinita, Pilar López, sorella di Encarnatión e maestra di quasi tutti coloro che contano oggi: a iniziare da Antonio Gades. Del 1922 è la famosa “Fiesta de cante jondo” organizzata a Granada da Manuel de Falla e Federico GarcÃa Lorca. Del 1933 la “Gran compagnia di balli spagnoli” fondata dalla Argentinita. Nonostante il fervore di iniziative il flamenco puro si avvia tuttavia verso un periodo di decadimento, anche accentuato dallo scoppio della guerra civile e dagli eventi che ne seguono. Solo nel 1957, a Jerez de la Frontera, è istituita la prima cattedra di flamencologia.
Ma come nasce questa ermeticissima “cosa” chiamata flamenco? Ovviamente i pareri sono discordi, ma tutti partono dall’osservazione geografico-politica della terra di maggior diffusione, l’Andalusia, che fu punto di sintesi delle civiltà musicali sparpagliate per il Mediterraneo: dalla Grecia a Cartagine e da Roma a Bisanzio. Manuel de Falla, in un suo studio fondamentale, poi regolarmente contraddetto, sottolinea la portata di alcuni eventi storici: l’adozione della liturgia bizantina da parte della chiesa spagnola, l’invasione araba, l’immigrazione dei gitani e lo stabilirsi di alcuni di essi (i castellanos neuvos) fuori dalle mura della città . Falla definisce con il nome di cante hondo un gruppo di canti andalusi il cui tipo base si riconosce nella seguiriya gitana. Nella seguiriya egli individua elementi bizantini e arabi ma anche varianti aggiunte nel corso del 1400 dai gitani andalusi. Dalla seguiriya si sarebbero sviluppati i generi di polos, martinetes e soleares. Israel Katz ricorda l’invasione islamica del ‘700, ma soprattutto l’arrivo a Córdoba, dove fondò una scuola di canto, di Ziryab, il famoso musico di Bagdad. La musica diviene predominante differenziandosi nel tempo da quella dei califfati di Damasco e Bagdad, cioè integrandosi con le espressioni musicali preesistenti. Più tardi si registra l’influsso del gregoriano, mentre non è certo l’apporto della liturgia ebraica. La stessa fonte sottolinea i punti di contatto, anche figurativi tra flamenco e tradizione indiana, quella originaria del popolo gitano, osservando affinità con l’intelaiatura melodica costituita dal raga.
Per l’analisi delle forme musicali c’è maggiore coerenza di giudizio. In musica si nota il passaggio di tonalità sul filo di microintervalli inferiori al semitono. Si osserva l’estensione melodica, mai superiore a una sesta (anche se vengono utilizzati molti più suoni di quelli previsti dal nostro sistema temperato). Si sottolinea l’assenza di un ritmo metrico rigido, fatto che implica una grande dinamicità di respiro. Analizzando alcuni generi rappresentativi, come la zambra gitana di derivazione araba o la juerga, sensuale, segreta, e diretta a una platea iniziatica e numericamente limitata, ci si sofferma sul cuadro flamenco. Sul numero che tutti conosciamo per essere spesso il protagonista e spesso il momento di chiusura di ogni spettacolo riservato al folclore iberico. I solisti, ballerini, cantanti o suonatori, si staccano dal gruppo per esibirsi in gioiosi assoli, sempre incoraggiati dal grido e dal battimano del gruppo.
Nello spettacolo flamenco l’apertura è generalmente riservata al cupo e dolente vocalizzo del cantaor sulle sillabe di “Ay” o “Lelì” (gipido). Il canto è quindi organizzato in coplas (strofe) che variano per numero di versi e sillabe relative. Tuttavia di frequente organizzate in una sorta di quartina di ottonari. Le coplas dei canti più antichi sono accompagnate dal battito delle mani (jaleo), o dallo schiocco dell’indice sul medio (pito). Il canto privo di accompagnamento è detto a polo seco. I vocalizzi melismatici del cantaor sono detti salidas. Canto e chitarra ricorrono sovente all’uso reiterato di una stessa nota con appoggiature inferiori o superiori. Le volute ornamentali vengono intese come rinforzo emotivo. Spesso è presente la poliritmia: il canto procede su un ritmo binario accompagnato dal ritmo ternario della musica. Il ritmo incrociato è reso possibile da taconeo, palmas sordas e pitos che utilizzano il battito di piedi, mani e dita. Il cantante ha in genere una voce nasale, aspra, raschiata. La chitarra ricopre il duplice ruolo di accompagnamento e strumento solista. Può essere impiegato nel rasgueado (raschiato), nel paseo (effusione melodica) e nelle falsetas (interludi tra copla e copla).
Un rituale antico e attento divide anche il pubblico in practicos, quelli che “sanno”, e téoricos, i fans.
Alcuni studiosi distinguono tra categorie di flamenco: cante chico, il più semplice; cante grande, comprensivo del tipo hondo; e cante intermedio. Alcuni canti (se ne catalogano una settantina) prendono nome da famosi cantaores: la soléa Tomas Pavón o la seguiriya El Manolito.
Parlando di canto, ci piace ricordare alcune raccomandazioni di Falla. Egli metteva in guardia contro la perdita del “canto grave e ieratico di ieri”, contro la povertà tonale e la grossolana metrificazione delle coplas così private di quella flessibilità ritmica che ne costituisce la grandezza. Insomma raccomandava di stare attenti al “flamenquismo” commerciale.
Esortava, come direbbe GarcÃa Lorca, alla perenne ricerca del duende: l’estro, la passione, l’estemporaneità , il costante fatale ammiccamento alla morte: “il duende non arriva se non vedi una possibilità di morte, se non sai che dovrai corteggiarla, se non hai la sicurezza che dovrà cullare quei rami che tutti portiamo con noi, e che non hanno, non avranno mai, consolazione.
Rassegna stampa
“Un gioco coreografico di quadri “iberici” in cui i danzatori si esibiscono in assoli o in coppia (Angel e Ruiz con Tania Lazaro e Charo Espino) guidati dalla musica, dal battito delle mani di chitarristi e cantaores, dal tocco di bastoni che ritmano e modulano temperature emotive. E si respira aria nuova, un senso di irresistibile vitalità guardando quei corpi sguscianti, quei volti che sembrano voler sfidare di continuo il pubblico. È la civiltà spagnola che risorge, il suo modo di essere prepotentemente e generosamente coinvolgente. Una civiltà di volteggi rapidi, di arcature poderose, di tacchi battenti e gonne fruscianti”.
(Carmela Piccione, L’aristocratica bellezza del flamenco, Il Tempo, 16 luglio 1991)