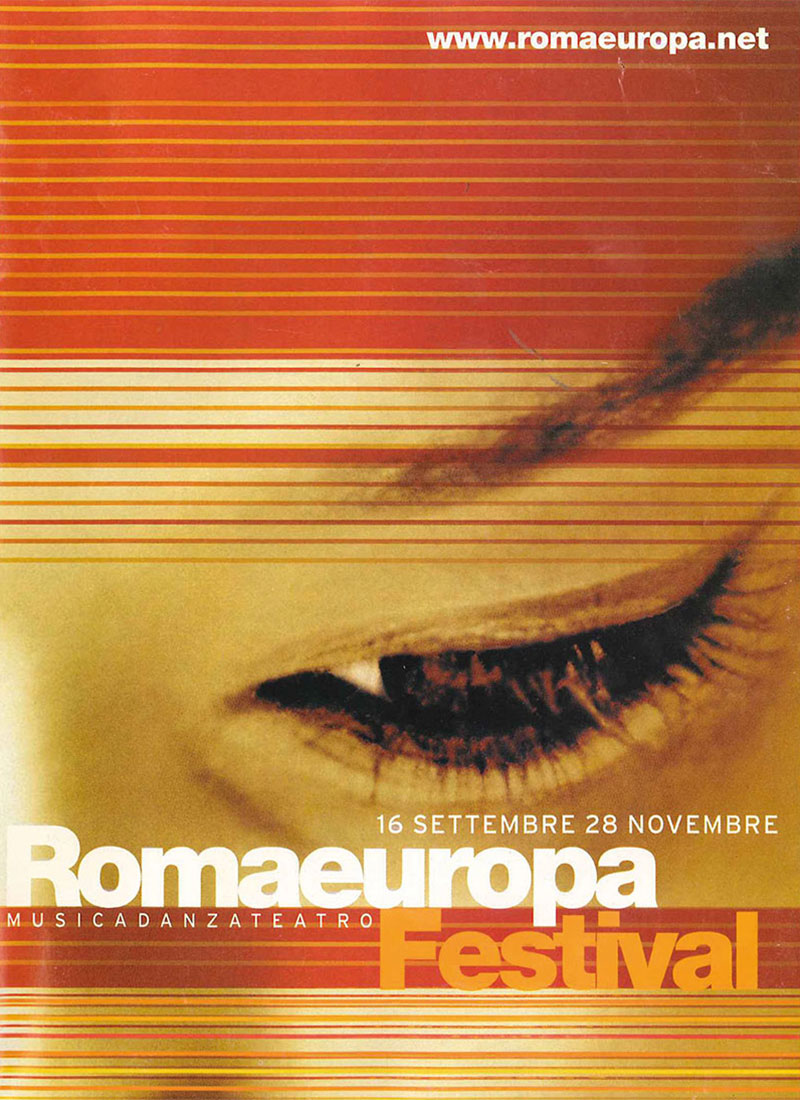Alessandro Baricco presenta la tappa finale del progetto sull’Iliade omerica di cui aveva, nel corso dell’edizione 2003, proposto l’iniziale fase di lavorazione.
Ventiquattro racconti più uno, quello di Demodòco che narra la caduta di Troia (tratto dall’Odissea), sono dunque riscritti da Baricco a partire dall’Iliade omerica – nella traduzione in prosa di Maria Grazia Ciani. Ventiquattro racconti letti dallo stesso autore in alternanza con undici voci, tra le quali quella di Stefano Benni, Sandro Veronesi, Caterina De Regibus, Fabrizia Sacchi.
Baricco per riscrive la guerra di Troia, in un’ottica del tutto personale, smonta e rimonta il testo dell’Iliade– a cui affianca alcuni frammenti apocrifi – e, sostituendo all’evocativo narratore esterno del poema omerico una prima persona monologante, lascia che emergano, uno ad uno, i racconti dei personaggi principali. Sul testo originale compie dei tagli, ma quasi mai, pur nel passaggio alla prima persona, inventa nuovi testi, mentre lo stile, lontano da quello omerico, si nutre di un linguaggio che asciugato degli arcaismi diventa più vicino alla nostra lingua.
Dalla sua Iliade, Baricco fa scomparire gli dei, affidando la sua visione ai guerrieri che muovendosi sul campo di battaglia, vivono realmente il dramma della guerra, perché, a detta di Baricco, il poema omerico è “una specie di lezione per capire cos’è stata la guerra e che cosa sarà sempre”. Una lettura pacifista, dunque, rappresentata dalle donne e dal lato femminile di uomini come Achille – il cui ruolo è stato infatti assegnato a Carolina Felline.
Lo spazio ̬ nudo, sul palcoscenico impera un unico leggio, e sullo sfondo vengono proiettate le immagini degli attori in scena. Illuminati da luci sobrie, questi dicono il testo in camicia e pantaloni Рgilet rossi e blu servono a distinguere gli achei dai troiani -, mentre i temi musicali creati da Giovanni Sollima accompagnano personaggi (un tema per ciascuno di essi) e battaglie (un remix, in tempo reale, di musiche note, a volte rese riconoscibili, a volte trasformate in altro).
La voce plasma lo spazio, crea immagini, risuona in sala potentemente, amplificata dal microfono, e lo spettacolo avvicinandosi alla forma concerto ha nascoste le potenzialità di un rito – emozione collettiva.
QUEL CHE STATE PER ASCOLTARE
di Alessandro Baricco
Poche righe per spiegare come è stato costruito il testo che stiamo per leggere. Il punto di partenza è la traduzione che, dell’Iliade, ha fatto Maria Grazia Ciani (la potete trovare in libreria, pubblicata da Marsilio). È una traduzione in prosa e mi è sembrata più moderna di altre, o forse solo più vicina al mio sentire. Comunque: l’ho scelta, e ci ho lavorato su per ottenere un testo che potesse essere letto in pubblico in un tempo ragionevole e con qualche possibilità di non esasperare la pazienza degli ascoltatori. Così ho fatto una piccola serie di interventi.
Per prima cosa ho fatto dei tagli per ricondurre la lettura a una durata ragionevole (adesso ce la dovremmo cavare in sette, otto ore di lettura: ammesso che questo sia ragionevole). Non ho tagliato, quasi mai, delle scene intere, ma mi sono limitato, per quanto è possibile, a togliere le ripetizioni, che nell’Iliade sono numerose, e ad asciugare un po’ il testo. Ho cercato di non riassumere mai e di non inventare delle frasi: e di creare piuttosto delle sequenze più stringate usando sezioni originali del testo. Per cui i mattoni sono quelli omerici, ma il muro risulta più essenziale. Non ci sono tutte le parole di Omero, ma tutte le parole che ci sono vengono, in linea di massima, da Omero.
Ho detto che non ho quasi mai tagliato scene intere: questa è la regola, ma devo citare l’eccezione più evidente: ho tagliato tutte le apparizioni degli dei. Non è questo il luogo in cui discutere più di tanto una scelta del genere. Vorrei giusto annotare che togliere gli dei dall’Iliade non è probabilmente un buon sistema per comprendere la civiltà omerica: ma mi sembra un ottimo sistema per recuperare quella storia riportandola nell’orbita delle narrazioni a noi contemporanee. Come diceva Lukács, il romanzo è l’epopea del mondo disertato dagli dei.
Il secondo intervento che ho fatto è sullo stile. Già la traduzione della Ciani usa un italiano vivo, più che un gergo da filologi. Ho cercato di proseguire in quella direzione. Da un punto di vista lessicale ho cercato di eliminare tutte gli spigoli arcaici che allontanano dal cuore delle cose. E poi ho cercato un ritmo: la coerenza di un passo, il respiro di una particolare velocità e di una speciale lentezza. L’ho fatto perché credo che ricevere un testo, che viene da così lontano, significa sopra ogni cosa cantarlo con la musica che è nostra.
Il terzo intervento è più evidente, anche se poi non così importante come sembra. Ho girato la narrazione in soggettiva. Ho scelto alcuni personaggi dell’Iliade e gli ho fatto raccontare le storia, sostituendoli al narratore esterno, omerico. Per lo più è una faccenda puramente tecnica: invece che dire “il padre prese la figlia tra le braccia”, nel mio testo c’è la figlia che dice “mio padre mi prese tra le braccia”. È una cosa che può aiutare chi legge a non smarrirsi e chi ascolta a non addormentarsi.
Quarto intervento: naturalmente non ho resistito alla tentazione e ho fatto alcune, poche, aggiunte al testo. Non c’è modo, nella lettura pubblica, di farvi capire quali sono: le trovate nel libro, se volete, stampate in corsivo: sono come restauri dichiarati, in acciaio e vetro, su una facciata gotica. Quantitativamente, sono interventi che coprono una percentuale minima del testo. Per lo più riportano in superficie sfumature che l’Iliade non poteva pronuciare ad alta voce ma nascondeva tra le righe. A volte riprendono tessere di quella storia tramandate da altre narrazioni posteriori (Apollodoro, Euripide, Filostrato). Il caso più evidente, ma in certo modo anomalo, è l’ultimo monologo, quello di Demòdoco. Come si sa l’Iliade finisce con la morte di Ettore e con la restituzione del suo corpo a Priamo: non c’è traccia del cavallo e della caduta di Troia. Pensando alla lettura pubblica, però, mi sembrava perfido non raccontare come quella guerra fosse poi, finalmente, finita. Così ho preso una situazione che viene dall’Odissea (libro VIII: alla corte dei Feaci un vecchio aedo, Demòdoco, canta la caduta di Troia davanti a Ulisse) e le ho versato dentro, per così dire, la traduzione di alcuni passi de La presa di Ilio di Trifiodoro: un libro, non privo di una sua eleganza post-omerica, che risale forse al quarto secolo dopo Cristo.
ILIADE, UN MONUMENTO ALLA GUERRA MA ANCHE UN INNO ALLA PACE
di Alessandro Baricco
Non sono, questi, anni qualunque per leggere l’Iliade. O per “riscriverla”, come mi è accaduto di fare. Sono anni di guerra. E per quanto “guerra” continui a sembrarmi un termine sbagliato per definire cosa sta accadendo nel mondo (un termine di comodo, direi), certo sono anni in cui una certa orgogliosa barbarie, per millenni collegata all’esperienza della guerra, è ridivenuta esperienza quotidiana. Battaglie, assassinii, violenze, torture, decapitazioni, tradimenti. Eroismi, armi, piani strategici, volontari, ultimatum, proclami. Da qualche profondità che credevamo più sigillata, è tornato a galla tutto l’atroce e luminoso armamentario che è stato per tempo immemorabile il corredo di un’umanità combattente.
In un contesto del genere – vertiginosamente delicato e scandaloso – anche i dettagli assumono un significato particolare. Leggere in pubblico l’Iliade è un dettaglio, ma non è un dettaglio qualsiasi. Per esser chiaro, vorrei dire che l’Iliade è una storia di guerra, lo è senza prudenza e senza mezze misure: e che è stata composta per cantare un’umanità combattente, e per farlo in modo così memorabile da durare in eterno, ed arrivare fino all’ultimo figlio dei figli, continuando a cantare la solenne bellezza, e l’irrimediabile emozione, che era stata un tempo la guerra, e che sempre sarà .
A scuola, magari, la raccontano diversamente. Ma il nocciolo è quello. L’Iliade è un monumento alla guerra.
Così la domanda sorge naturale: che senso ha in un momento come questo dedicare tanto spazio, e attenzione, e tempo alla guerra? Come mai, con tante storie che c’erano, ci si ritrova attratti proprio da quella, quasi fosse una luce che detta una fuga alla tenebra di questi giorni?
Credo che una risposta vera la si potrebbe dare solo se si fosse capaci di capire fino in fondo il nostro rapporto con tutte le storie di guerra, e non con questa in particolare: capire il nostro istinto a non smettere di raccontarle mai.
Ma è una questione molto complessa, che non può certo essere risolta qui, e da me. Quel che posso fare è restare all’Iliade e annotare due cose che, in un anno di lavoro a stretto contatto con quel testo, mi è accaduto di pensare: riassumono quanto, in quella storia, mi è apparso con la forza e la limpidezza che solo i veri insegnamenti hanno.
La prima. Una delle cose sorprendenti dell’Iliade è la forza, direi la compassione, con cui vi sono tramandate le ragioni dei vinti. È una storia scritta dai vincitori, eppure nella memoria rimangono anche, se non soprattutto, le figure umane dei Troiani. Priamo, Ettore, Andromaca, perfino piccoli personaggi come Pà ndaro o Sarpedonte.
Questa capacità , sovrannaturale, di essere voce dell’umanità tutta e non solo di se stessi, l’ho ritrovata lavorando al testo e scoprendo come i Greci, nell’Iliade , abbiano tramandato, tra le righe di un monumento alla guerra, la memoria di un amore ostinato per la pace. A prima vista non te ne accorgi, accecato dai bagliori delle armi e degli eroi. Ma nella penombra della riflessione viene fuori un’Iliade che non ti aspetti. Vorrei dire: il lato femminile dell’Iliade .
Sono spesso le donne a pronunciare, senza mediazioni, il desiderio di pace. Relegate ai margini del combattimento, incarnano l’ipotesi ostinata e quasi clandestina di una civiltà alternativa, libera dal dovere della guerra. Sono convinte che si potrebbe vivere in un modo diverso, e lo dicono. Nel modo più chiaro lo dicono nel VI libro, piccolo capolavoro di geometria sentimentale.
In un tempo sospeso, vuoto, rubato alla battaglia, Ettore entra in città e incontra tre donne: ed è come un viaggio nell’altra faccia del mondo. A ben vedere tutt’e tre pronunciano una stessa supplica, pace, ma ognuna con la propria tonalità sentimentale. La madre lo invita a pregare. Elena lo invita al suo fianco, a riposarsi (e anche a qualcosa di più, forse).
Andromaca, alla fine, gli chiede di essere padre e marito prima che eroe e combattente. Soprattutto in questo ultimo dialogo, la sintesi è di un chiarore quasi didascalico: due mondi possibili stanno uno di fronte all’altro, e ognuno ha le sue ragioni. Più legnose, cieche, quelle di Ettore: moderne, tanto più umane, quelle di Andromaca. Non è mirabile che una civiltà maschilista e guerriera come quella dei Greci abbia scelto di tramandare, per sempre, la voce delle donne e il loro desiderio di pace?
Lo si impara dalla loro voce, il lato femminile dell’Iliade: ma una volta imparato, lo si ritrova, poi, dappertutto. Sfumato, impercettibile, ma incredibilmente tenace. Io lo vedo fortissimo nelle innumerevoli zone dell’Iliade in cui gli eroi, invece che combattere, parlano. Sono assemblee che non finiscono mai, dibattiti interminabili, e uno smette di odiarli solo quando inizia a capire cosa effettivamente sono: sono il loro modo di rinviare il più possibile la battaglia. Sono Sherazade che si salva raccontando.
La parola è l’arma con cui congelano la guerra. Anche quando discutono di come farla, la guerra, intanto non la fanno, e questo è pur sempre un modo di salvarsi. Sono tutti condannati a morte ma l’ultima sigaretta la fanno durare un’eternità : e la fumano con le parole. Poi, quando in battaglia ci vanno davvero, si trasformano in eroi ciechi, dimentichi di qualsiasi scappatoia, fanaticamente votati al dovere. Ma prima: prima è un lungo tempo, femminile, di lentezze sapienti, e sguardi all’indietro, da bambini.
Nel modo più alto e accecante, questa sorta di ritrosia dell’eroe si coagula, come è giusto, in Achille. È lui quello che ci mette più tempo, nell’Iliade, a scendere in battaglia. È lui che, come una donna, assiste da lontano alla guerra, suonando una cetra e rimanendo al fianco di quelli che ama. Proprio lui, che della guerra è l’incarnazione più feroce e fanatica, letteralmente sovrumana.
La geometria dell’Iliade è, in questo, di una precisione vertiginosa. Dove più forte è il trionfo della cultura guerriera, più tenace e prolungata è l’inclinazione, femminile, alla pace. Alla fine è in Achille che l’inconfessabile di tutti gli eroi erompe in superficie, nella chiarezza senza mediazioni di un parlare esplicito e definitivo. Quel che lui dice davanti all’ambasceria mandatagli da Agamennone, nel IX libro, è forse il più violento e indiscutibile grido di pace che i nostri padri ci abbiano tramandato:
“Niente, per me, vale la vita: non i tesori che la città di Ilio fiorente possedeva prima, in tempo di pace, prima che giungessero i figli dei Danai; non le ricchezze che, dietro la soglia di pietra, racchiude il tempio di Apollo signore dei dardi, a Pito rocciosa; si possono rubare buoi, e pecore pingui, si possono acquistare tripodi e cavalli dalle fulve criniere; ma la vita dell’uomo non ritorna indietro, non si può rapire o riprendere, quando ha passato la barriera dei denti”.
Sono parole da Andromaca: ma nell’Iliade le pronuncia Achille, che è il sommo sacerdote della religione della guerra: e per questo esse risuonano con un’autorevolezza senza pari. In quella voce – che, sepolta sotto un monumento alla guerra, dice addio alla guerra, scegliendo la vita – l’Iliade lascia intravedere una civiltà di cui i Greci non furono capaci, e che tuttavia avevano intuito, e conoscevano, e perfino custodivano in un angolo segreto e protetto del loro sentire. Portare a compimento quell’intuizione forse è quanto nell’Iliade ci è proposto come eredità , e compito, e dovere.
Come svolgere quel compito? Cosa dobbiamo fare per indurre il mondo a seguire la propria inclinazione per la pace? Anche su questo l’Iliade ha, mi sembra, qualcosa da insegnare. E lo fa nel suo tratto più evidente e scandaloso: il suo tratto guerriero e maschile. È indubbio che quella storia presenti la guerra come uno sbocco quasi naturale della convivenza civile. Ma non si limita a questo: fa qualcosa di assai più importante e, se vogliamo, intollerabile: canta la bellezza della guerra, e lo fa con una forza e una passione memorabili. Non c’è quasi eroe di cui non si ricordi lo splendore, morale e fisico, nel momento del combattimento. Non c’è quasi morte che non sia un altare, decorato riccamente e ornato di poesia.
La fascinazione per le armi è costante, e l’ammirazione per la bellezza estetica dei movimenti degli eserciti è continua. Bellissimi sono gli animali, nella guerra, e solenne è la natura quando è chiamata a far da cornice al massacro. Perfino i colpi e le ferite vengono cantati come opere superbe di un artigianato paradossale, atroce, ma sapiente. Si direbbe che tutto, dagli uomini alla terra, trovi nell’esperienza della guerra il momento di sua più alta realizzazione, estetica e morale: quasi il culmine glorioso di una parabola che solo nell’atrocità dello scontro mortale trova il proprio compimento.
In questo omaggio alla bellezza della guerra, l’Iliade ci costringe a ricordare qualcosa di fastidioso ma inesorabilmente vero: per millenni la guerra è stata, per gli uomini, la circostanza in cui l’intensità – la bellezza – della vita si sprigionava in tutta la sua potenza e verità . Era quasi l’unica possibilità per cambiare il proprio destino, per trovare la verità di se stessi, per assurgere a un’alta consapevolezza etica.
Di contro alle anemiche emozioni della vita, e alla mediocre statura morale della quotidianità , la guerra rimetteva in movimento il mondo e gettava gli individui al di là dei consueti confini, in un luogo dell’anima che doveva sembrar loro, finalmente, l’approdo di ogni ricerca e desiderio. Non sto parlando di tempi lontani e barbari: ancora pochi anni fa, intellettuali raffinati come Wittgenstein e Gadda, cercarono con ostinazione la prima linea, il fronte, in una guerra disumana, con la convinzione che solo là avrebbero trovato se stessi. Non erano certo individui deboli, o privi di mezzi e cultura. Eppure, come testimoniano i loro diari, ancora vivevano nella convinzione che quell’esperienza limite – l’atroce prassi del combattimento mortale – potesse offrire loro ciò che la vita quotidiana non era in grado di esprimere.
In questa loro convinzione riverbera il profilo di una civiltà , mai morta, in cui la guerra rimaneva come fulcro rovente dell’esperienza umana, come motore di qualsiasi divenire. Ancor oggi, in un tempo in cui per la maggior parte degli umani l’ipotesi di scendere in battaglia è poco più che un’ipotesi assurda, si continua ad alimentare, con guerre combattute per procura attraverso i corpi di soldati professionisti, il vecchio braciere dello spirito guerriero, tradendo una sostanziale incapacità a trovare un senso, nella vita, che possa fare a meno di quel momento di verità .
La malcelata fierezza maschile cui, in Occidente come nel mondo islamico, si sono accompagnate le ultime esibizioni belliche, lascia riconoscere un istinto che lo shock delle guerre novecentesche non ha evidentemente sopito. L’Iliade raccontava questo sistema di pensiero e questo modo di sentire, raccogliendolo in un segno sintetico e perfetto: la bellezza. La bellezza della guerra – di ogni suo singolo particolare – dice la sua centralità nell’esperienza umana: tramanda l’idea che altro non c’è, nell’esperienza umana, per esistere veramente.
Quel che forse suggerisce l’Iliade è che nessun pacifismo, oggi, deve dimenticare, o negare quella bellezza: come se non fosse mai esistita. Dire e insegnare che la guerra è un inferno e basta è una dannosa menzogna. Per quanto suoni atroce, è necessario ricordarsi che la guerra è un inferno: ma bello. Da sempre gli uomini ci si buttano come falene attratte dalla luce mortale del fuoco. Non c’è paura, o orrore di sé, che sia riuscito a tenerli lontani dalle fiamme: perché in esse sempre hanno trovato l’unico riscatto possibile dalla penombra della vita.
Per questo, oggi, il compito di un vero pacifismo dovrebbe essere non tanto demonizzare all’eccesso la guerra, quanto capire che solo quando saremo capaci di un’altra bellezza potremo fare a meno di quella che la guerra da sempre ci offre. Costruire un’altra bellezza è forse l’unica strada verso una pace vera.
Dimostrare di essere capaci di rischiarare la penombra dell’esistenza, senza ricorrere al fuoco della guerra. Dare un senso, forte, alle cose senza doverle portare sotto la luce, accecante, della morte. Poter cambiare il proprio destino senza doversi impossessare di quello di un altro; riuscire a mettere in movimento il denaro e la ricchezza senza dover ricorrere alla violenza; trovare una dimensione etica, anche altissima, senza doverla andare a cercare ai margini della morte; incontrare se stessi nell’intensità di luoghi e momenti che non siano una trincea; conoscere l’emozione, anche la più vertiginosa, senza dover ricorrere al doping della guerra o al metadone delle piccole violenze quotidiane. Un’altra bellezza, se capite cosa voglio dire.
Oggi la pace è poco più che una convenienza politica: non è certo un sistema di pensiero e un modo di sentire veramente diffusi. Si considera la guerra un male da evitare, certo, ma si è ben lontani da considerarla un male assoluto: alla prima occasione, foderata di begli ideali, scendere in battaglia ridiventa velocemente un’opzione realizzabile.
La si sceglie, a volte, perfino con una certa fierezza. Continuano a schiantarsi, le falene, nella luce del fuoco. Una reale, profetica e coraggiosa ambizione alla pace io la vedo soltanto nel lavoro paziente e nascosto di milioni di artigiani che ogni giorno lavorano per suscitare un’altra bellezza, e il chiarore di luci, limpide, che non uccidono.
E’ un’impresa utopica, che presuppone una vertiginosa fiducia nell’uomo. Ma mi chiedo se mai ci siamo spinti così avanti, come oggi, su un simile sentiero. E per questo credo che nessuno, ormai, riuscirà più a fermare quel cammino, o a invertirne la direzione. Riusciremo, prima o poi, a portar via Achille da quella micidiale guerra. E non saranno la paura né l’orrore a riportarlo a casa. Sarà una qualche, diversa, bellezza, più accecante della sua, e infinitamente più mite.
(in “la Repubblica”, 14 settembre 2004)
L’ILIADE DI SCALFARI E DI BARICCO È UN EQUIVOCO
di Giovanni Cerri
I miei colleghi classicisti dell’Università e dei Licei sono in genere abbastanza soddisfatti per un certo rilancio mediatico di Omero oggi in atto: film, spettacoli teatrali, paginoni sui principali quotidiani a tiratura nazionale. Con i tempi che corrono per lo studio del greco e del latino, tutto fa brodo; se un po’ di chiasso intorno ad Omero finisse per incrementare il numero degli studenti interessati a quelle discipline, sarebbe comunque una boccata d’aria. Da questo punto di vista, potrei anche essere d’accordo. Tuttavia mi sembra che qualche riflessione il fenomeno, per come si sta realizzando, la meriti. Il film Troy è dichiaratamente un colossal-fumettone, che non ha e non vuole avere a che fare davvero niente col testo dal quale è stata tratta la sceneggiatura. Il recital di Alessandro Baricco è una pubblica lettura non dell'”Iliade”, ma di un sunto-rifacimento elaborato da Baricco stesso in funzione dello spettacolo. Film e recitazione hanno avuto entrambi grande successo di pubblico, dando così ragione alle scelte dei loro autori. Dunque nulla da obiettare. Ma Baricco ha poi pubblicato il suo copione presso la casa editrice Feltrinelli (settembre 2004) con il titolo Omero, Iliade, facendolo per giunta seguire da un pezzo conclusivo (pp. 157-163), nel quale crede di interpretare proprio Omero.
Ecco che allora l’operazione comincia ad acquistare margini di equivoco. Egli afferma: “Per essere chiaro, vorrei dire che l’Iliade è un poema di guerra, lo è senza prudenza e senza mezze misure: e che è stata composta per cantare un’umanità combattente, e per farlo in modo così memorabile da durare in eterno, ed arrivare fino all’ultimo figlio dei figli, continuando a cantare la solenne bellezza, e l’irrinunciabile emozione, che era stata un tempo la guerra, e che sempre sarà . A scuola, magari, la raccontano diversamente. Ma il nocciolo è quello. L’Iliade è un monumento alla guerra”. Poi aggiunge qualche notazione critica più fine: “È una storia scritta dai vincitori, eppure nella memoria rimangono anche, se non soprattutto, le figure umane dei Troiani”; e, ancora, scopre giustamente “tra le righe” l’emergere continuo di “un amore ostinato per la pace”, e cita alcuni passi pertinenti.
Chiunque abbia studiato con un minimo di attenzione e di sensibilità il poema, sa che è ben altro e ben di più che un inno alla guerra, increspato da qualche rimorso di pace. E’ come dire che la Divina Commedia sia stata composta da Dante per fare propaganda cattolica, pur con qualche sana puntata anticlericale. Comunque, fino a questo punto, non mi sarei ancora allarmato: Baricco, con quella bocca, può dire quel che vuole! Senonché la sua “critica” ha scatenato un dibattito giornalistico, che lo ha seguito sullo stesso terreno, avvalorando quel giudizio forviante e riduttivo, finché nella provocazione è caduto in pieno un uomo dello spessore culturale di Eugenio Scalfari, il quale si muove sulle sue orme nelle pagine culturali della Repubblica (1 ottobre 2004), con inizio in prima pagina e sotto il titolo Iliade: la guerra tra orrore e bellezza.
Purtroppo, il titolo non è errore redazionale, ma rispecchia fedelmente il contenuto del pezzo. Peccato che uno dei più grandi critici del Novecento, Wolfgang Schadewaldt abbia iniziato l’introduzione alla sua splendida traduzione tedesca in versi con le seguenti parole: “L’Iliade tratta le vicende della guerra di Troia, cioè una successione ininterrotta di battaglie. Eppure non è un poema guerresco. Parla di eroi e dei loro destini, ma non è un poema eroico”. Peccato che Omero stesso, nel proemio, chiarisca a scanso di equivoci che il suo tema poetico non è la guerra in sé, della quale nemmeno indugia a narrare l’epilogo, ma “l’ira di Achille”, cioè un dissidio tragico tra eroi, nel quale entra in gioco tutta intera la loro personalità , dall’orgoglio ferito all’amore frustrato, con risvolti di carattere generale che investono questioni basilari di diritto, osservanza religiosa, lealtà dei comandanti verso l’esercito, correttezza costituzionale tra capo supremo e re confederati, valori la cui infrazione comporta la rovina della collettività nel suo insieme. Perché mai i Greci antichi, per i ben mille e quattrocento anni della loro storia, avrebbero continuato a farne, con recitazioni e letture scolastiche, il poema fondante della loro civiltà , se fosse stato solo un canto di guerra?
Mi piacerebbe un giorno poter illustrare la vera natura dell’Iliade a livello giornalistico: ma ora è di altro che voglio discutere. La divulgazione è un’ottima cosa, se è intelligente e competente: è anzi il sale della cultura, perché porta a livello di cultura media i risultati conoscitivi che lo meritino. Diviene invece pessima, se è banalizzante; ancora peggiore, se, come purtroppo è in questi ultimi sciagurati decenni, la singola operazione si iscrive in un processo univoco di banalizzazione della cultura, della politica e del costume. C’è anche un fatto di etica professionale. Perché persone, rispettabilissime e valide sotto altri profili, debbono impancarsi a critici letterari, pur risultando di evidenza palmare che sono del tutto incompetenti in materia? Perché il sistema consente loro la pubblicazione di sciocchezze ai massimi livelli dell’editoria? E perché il grande pubblico deve finire col credere che l’Iliade sia quella robina lì, e non quello che realmente è, un grande poema cosmico sulla vita umana e sul suo mistero? Anche l’Iliade, come la Divina Commedia, è un “poema sacro, al quale ha posto mano e cielo e terra”.
Alludevo sopra alla banalizzazione politica. Ebbene, la banalizzazione critico-letteraria porta Baricco e Scalfari anche a quella. Sì, perché vogliono poi spremere una morale attuale da quella favoletta esopica cui hanno ridotto il racconto di Omero! Una morale attuale in rapporto alla nauseabonda guerra dell’Iraq (e dell’Afganistan). Dice Baricco: “Quel che suggerisce l’Iliade è che nessun pacifismo, oggi, deve dimenticare, o negare quella bellezza: come se non fosse mai esistita. Dire e insegnare che la guerra è un inferno e basta è una dannosa menzogna. Per quanto suoni atroce, è necessario ricordarsi che la guerra è un inferno: ma bello (corsivo nel testo)”. Con la sua estetica bellicistica Omero, anticipando Marinetti, ha il merito oggettivo e involontario di svelarci qual è la ragione psicologica profonda del fatto che la guerra abbia ripreso a dilagare: nei risvolti del nostro cuore la amiamo; solo dopo aver preso coscienza di ciò, saremo in grado di elaborare un’estetica diversa, che ci porti fuori dal circolo vizioso: “Costruire un’altra bellezza è forse l’unica strada verso una pace vera. Dimostrare di essere capaci di rischiare la penombra dell’esistenza, senza ricorrere al fuoco della guerra. Dare un senso, forte, alle cose senza doverle portare sotto la luce, accecante, della morte”. Dall’estetica dannunziana del rischio e del lavacro di sangue a una sana estetica della quotidianità : questa è la soluzione dei mali che ci attanagliano.
E qui Scalfari si diversifica finalmente da Baricco. Perché scendere così in basso, e avvilupparsi nella mediocrità ? Meglio un’etica-estetica più elitaria, presentabile anche nei salotti di un certo livello: “Personalmente credo che si debba e si possa costruire un’altra bellezza ed è quella della conoscenza di sé e dell’amore per gli altri… L’Ulisse dantesco ha certamente potere, è un navarca e guida i suoi compagni. Ma dove li guida? Non verso la guerra che ha lasciato da tempo alle sue spalle. Li guida verso un viaggio misterico e iniziatico… Non è forse questa la nuova bellezza con la quale vincere i fantasmi dell’orrore e i cavalieri dell’apocalisse portatori di morte e di distruzione?”. Ed è la chiusa del suo pezzo.
La banalizzazione di Omero ha portato così i due pubblicisti a una mistificazione ideologica vera e propria: i guai del nostro tempo, a cominciare dalle stragi del Medio Oriente, sono in realtà colpa nostra (cioè dei popoli), sono colpa dell’Omero che si annida in noi. Bisogna trovare una via di predicazione che ci redima, e sarà la pace. Una regressione davvero paurosa verso l’illuminismo e l’idealismo più ingenui! E l’aggressione americana? Il petrolio? L’apparato militare-industriale? I centri di potere multinazionale, interessati al controllo capillare del mondo? Ma queste, si sa, sono ubbìe del vecchio marxismo.
(in “Liberazione”, 3 novembre 2004)
LA GUERRA TRA ORRORE E BELLEZZA
di Eugenio Scalfari
Non sarà un caso se l´Iliade riscritta da Alessandro Baricco si trova dopo pochi giorni dall’uscita del libro ai vertici delle classifiche diffusionali. Un nuovo interesse per la poesia in genere e per i poemi in particolare? Lo starebbero a comprovare le letture “en plein air” della Divina Commedia di Vittorio Sermonti nelle piazze e nei teatri di tante città , i vari festival di poesia e l´attenzione del cinema sull´epica e i suoi personaggi. Ma per quanto riguarda l´Iliade c´è forse una motivazione speciale: quel poema mette in scena la guerra, è un monumento alla guerra e alle sue infernali bellezze. L´attualità d´un monumento del genere è evidente. Di qui il richiamo che esercita su un pubblico che privilegia l´horror, la violenza, la muscolarità , la sfida e la vittoria del più forte. Così pensa Baricco e forse coglie un aspetto non marginale dell´umore pubblico.
Questa sua posizione ha suscitato molte reazioni e aperto un dibattito che si svolge su diversi piani. Anzitutto su un piano storico-pedagogico: la guerra è orrore e non bellezza; chi esalta sia pure in senso poetico la “bella guerra” e vede in essa la piena realizzazione della vitalità confonde l´etica con l´estetica, coltiva una dimensione decadente che non corrisponde alla sensibilità della nostra epoca, si iscrive in buona sostanza nel novero dei cattivi maestri e degli apprendisti stregoni.
Il secondo piano del dibattito riguarda l´analisi del poema omerico che Baricco compie nella lunga postilla con la quale il suo libro si conclude: un esame attento e per molti versi sorprendente per le intuizioni critiche che contiene e per la lettura moderna di un testo antico di tremila anni ma ancora capace di suscitare emozioni e passioni.
Infine la terza questione è quella non già del testo omerico ma della riscrittura che ce ne dà Baricco. L´autore è lui anche se opera (liberamente) sulla traduzione di Maria Grazia Ciani.
Anche lui si iscrive deliberatamente in quella piccola schiera di “traduttor dei traduttor d´Omero” che ebbe in Vincenzo Monti il suo migliore e più duraturo esempio attraverso il quale la mia generazione ebbe il suo primo incontro col “Cantami o diva del Pelide Achille l´ira funesta” che ancora oggi ci ricorda gli anni della nostra prima giovinezza.
Da questa terza questione, il testo di Baricco, comincerò dunque le mie riflessioni che sono di carattere letterario e insieme etico e politico.
Nella schiera dei “traduttor dei traduttor d’Omero”
Abbiamo già detto che il telaio linguistico e vorrei dire anche metrico che l´autore adopera è la versione in prosa della Ciani. Una versione tra le migliori (insieme a quella di G. A. Privitera della Fondazione Leonardo Valla) per la resa del testo greco del quale rispetta la lettera, l´ispirazione e il ritmo posato dell´esametro senza avvilirlo in una cantilena, peggio ancora se rimata.
Ottima dunque la scelta di Baricco che tuttavia, in più di una occasione, rompe la scansione del ritmo e l´aulicità del lessico prendendosi alcune licenze che a volte stridono come il raschio prodotto da una lama di coltello strisciata sul marmo. Quando Odisseo per esempio elenca ad Achille i doni inviatigli da Agamennone per riguadagnarne l´amicizia, il Pelide risponde: “Me ne frego dei suoi doni”. Baricco era certamente consapevole dello stridore di quel “me ne frego” e lo usa volutamente per dare al racconto la spigliatezza della modernità , ma il risultato che ottiene non va nel senso desiderato. Produce uno scandalo stilistico inutile che non alleggerisce il fraseggio ma lo disarticola.
Così pure in alcune giunzioni che si propongono di chiarificare e di render compiuto il testo e che l´autore fa stampare – per distinguerle dalla versione Ciani – in carattere corsivo. Esse aiutano il lettore a seguir meglio il racconto ma la dimensione didascalica va quasi sempre a detrimento di quella poetica. Ne risulta un racconto a volte aritmico, che in parte vanifica l´”andante” e il “largo” che costituiscono il fondale della Ciani, introducendo disarmonie e dodecafonie che interrompono l´epicità del testo.
Qui cessano le possibili critiche al lavoro di Baricco, al quale non reca invece alcun danno l´inserimento del brano di Demodoco sulla caduta di Troia, tratto dall´ Odissea, e di altre fonti post-omeriche che concludono efficacemente l´intero romanzo.
C´è ancora un punto da rilevare: il taglio netto compiuto dall´autore di tutto ciò che riguarda la presenza degli dei nel poema. Quella presenza, dice Baricco, appesantisce inutilmente la narrazione senza essere necessaria. Gli dei dell´Iliade sono infatti talmente antropomorfici da risultare un inutile duplicato degli eroi che combattono attorno alle mura di Ilio. Le loro liti, le loro rappacificazioni, la loro brama di guerra, la ripetitività dei loro comportamenti è tale da non distinguersi in nulla dai mortali che vivono e muoiono sotto i loro occhi. Cancellarli dal testo lo sveltisce senza produrre alcun danno.
Mi permetto di non essere del tutto d´accordo su questo punto. Ci sono infatti alcuni punti topici dell´Iliade nei quali i mortali – se abbandonati a se stessi – si comporterebbero in modo affatto diverso da come alla fine decidono di agire perché indotti o costretti dall´intervento di un dio. Cito: “Diomede torna in battaglia soltanto perché Atena glielo impone assicurandogli la sua protezione; Priamo attraversa l´accampamento acheo e arriva alla tenda di Achille per implorarlo a restituirgli il corpo del figlio perché Zeus lo induce a muoversi e manda Hermes a proteggerlo. Lo stesso Zeus manda Teti, madre divina di Achille, a convincere il figlio di fare buona accoglienza a Priamo e di rendergli il corpo di Ettore, che altrimenti Achille non avrebbe restituito.
Senza la presenza, spesso capricciosa ma talvolta saggia, delle divinità , la storia di Troia insomma sarebbe andata diversamente. Il che solleva un problema non piccolo sull´autodeterminazione umana rispetto ad una presenza “provvidenziale”. La cancellazione degli dei dal testo conferisce ai mortali un´autonomia dei comportamenti che nel poema non c´è. E incide direttamente su un aspetto importante del libro di Baricco là dove parla di una sorta di “pietas” di Achille che si manifesterebbe appunto nell´incontro con Priamo e che invece non è farina del suo sacco ma frutto dell´intervento di Teti e di Zeus.
Siamo con ciò arrivati al nocciolo dell´opera, contenuto nella “postilla” che la conclude, quella sulla quale si è acceso il dibattito e che più ci interessa: la guerra è un inferno ma bello, ed è una pulsione permanente dell´uomo, fa parte integrante della sua condizione ed esprime una sua bellezza e addirittura una pienezza vitale. Per superare quella bellezza, modificare quella condizione e abolire insieme alla guerra anche gli orrori che essa comporta occorre quindi costruire un altro tipo di bellezza che affascini gli uomini e li distolga dal vagheggiamento del mito guerriero.
Così Baricco nella sua postilla che, a mio avviso, è uno dei punti alti e sorprendenti della sua riflessione sull´Iliade.
Un monumento alla bellezza della guerra
Un monumento alla bellezza della guerra, ma non monolitico. C´è dell´altro in questo poema dedicato all´età del bronzo ma scritto quando già la civiltà degli eroi si era conclusa e per molti aspetti appariva arcaica e superata.
Intanto va segnalato un punto abbastanza sconvolgente: per la prima volta, proprio sul nascere della civiltà occidentale, una guerra viene raccontata non soltanto dal punto di vista dei vincitori ma anche da quello dei vinti. Non era mai accaduto prima e non accadrà neanche dopo, per molti secoli. Nella letteratura ellenistica e poi in quella romana non c´è traccia di narrazioni che ospitino la storia dei vinti. Neppure la pietas virgiliana offre varchi agli sconfitti, con la sola eccezione dell´episodio di Didone, nel suo strazio e nel suo suicidio causato dall´abbandono di Enea. È vero che la schiera di troiani che fuggono da Ilio mentre nella città ancora infuriano la strage e l´incendio, raffigura i vinti nella loro estrema disperazione, con l´eroe che trasporta sulle spalle il vecchio padre Anchise e tiene per mano il figlioletto in mezzo alle fiamme e alle urla del massacro. Ma quella schiera di disperati è già proiettata verso un futuro di grandi vittorie, i loro discendenti regneranno su tutto l´orbe diffondendo nel mondo sulla punta della spada i doni della pace, del diritto e del benessere.
Omero da questo punto di vista è molto più moderno di Virgilio, poeta di corte che canta la forza di Roma e l´apoteosi di Augusto.
Ma c´è un altro aspetto sorprendente del poema omerico che Baricco ha il merito di mettere in luce ed è la lettura femminile di quella vicenda che fa da contrappunto alla lettura maschile e guerriera.
Le donne troiane vogliono la pace e detestano la guerra. Lo gridano senza riserbo in pubblico e nell´intimità dei rapporti con i mariti e con i figli cercando di distoglierli dal mito della vittoria e della bella morte. Questa pena femminile contiene valori del tutto diversi da quelli dell´età eroica; valori sconosciuti perfino nella residenza degli dei olimpici, dove sono proprio le dee a mostrarsi più bramose di sangue e di strage. Atena ed Era in particolare arrivano al punto di ribellarsi a Zeus perché lo giudicano incerto tra le due parti contendenti e forse incline alla tregua delle armi. Armano i loro carri alati e si preparano ad irrompere nella magione di Zeus incuranti di affrontare uno scontro che non potrebbe che vederle perdenti pur d´ottenere che la cruenza non si arresti ma proceda speditamente fino in fondo.
I valori femminili non trovano dunque alcuna protezione né ascolto nelle divinità olimpiche, eppure costituiscono una componente essenziale nella trama del poema. Ecuba, Andromaca, Cassandra, perfino Elena, oggetto di scandalo, e insieme a loro il coro delle donne troiane, non fanno che implorare la pace, o almeno una tregua, il dialogo col nemico. Qualche scheggia di questi sentimenti femminili si percepisce anche in Paride ma trattandosi di un uomo e per di più del figlio del re, le sue esitazioni sono giudicate sintomi di viltà e come tali censurate dai suoi pari, fratelli e compagni. Sicché, per riscattarsi da quelle accuse, anche Paride si arma e combatte finché, nell´ultima notte di Ilio, sarà scannato da Menelao.
Soltanto Ettore ascolta e comprende i lamenti delle donne ed è per questo che la sua figura merita un discorso a parte come si addice ad un personaggio archetipico situato da Omero a mezza strada tra la civiltà degli eroi e quella degli uomini.
Ma l´Iliade era un´altra cosa.
I ragazzi della mia generazione studiavano Iliade e Odissea nelle prime classi del ginnasio inferiore, come si chiamava allora. Ricordo che l´ Odissea ci annoiava un po´, ci sperdevamo in quel viaggio infinito, nella sua improbabile geografia, in quelle avventure delle quali sfuggiva il senso alle nostre menti non ancora uscite dalla fanciullezza.
Ma l´Iliade era un´altra cosa. Il senso era chiaro: le battaglie, le vittorie, l´umiliazione degli sconfitti. Era ciò che mandavamo in scena ogni giorno all´uscita di scuola, sul marciapiede di cemento prima del ritorno a casa: con la palla di gomma o col pallone di cuoio, a “ruba bandiera” o alla guerra francese, a guardie e ladri o a cowboys contro pellirosse. Nello stesso modo mimavamo anche la guerra di Troia. Si erano formati due partiti: la maggior parte di noi stava dalla parte dei troiani e la difficoltà consisteva nel trovare chi combattesse sotto le insegne dei greci. Ettore ci affascinava molto più di Achille, forse perché l´invulnerabilità del Pelide ci pareva un privilegio sleale; gli eroi greci, Agamennone in testa, ci erano antipatici salvo forse Aiace Telamonio, il solo che ci sembrasse fatto della stessa pasta dei guerrieri che difendevano le mura di Troia.
Ettore combatteva per la sua patria; era forte ma non invincibile. Nessun dio combatteva al suo fianco. Insomma era un giusto, uno dei nostri come Buffalo Bill e Tom Mix che difendevano l´accampamento dalle orde dei sioux. Non c´era una logica ma un sentimento in questa scelta: amavamo il perdente e non il finto eroe predestinato a vincere. Probabilmente percepivamo una predilezione di Omero, del resto abbastanza evidente nel poema dove si configura il patriottismo troiano contro l´immensa armata d´invasione mobilitata dai re Achei. Ma noi eravamo per Ettore soprattutto per un´altra ragione: era un uomo, non un semidio come quasi tutti gli eroi. Perciò ci apparteneva e noi appartenevamo a lui. La sua guerra era difensiva e questo ci piaceva: difendeva la sua bandiera, non andava in cerca di bottino e di schiavi.
Quando poi, non più fanciulli ma ormai adolescenti, rivisitammo quel mondo attraverso le terzine dantesche del XXVI canto dell´Inferno, l´innamoramento per Ulisse fu immediato. Ma questo è un altro discorso che tra poco riprenderò.
È bello il potere?
Il nocciolo del dibattito che si è acceso attorno al libro di Baricco riguarda la bellezza della guerra, cui i pacifisti oppongono il suo orrore e la sua ferina bestialità . Non è vero, sostengono, che la guerra sia uno degli elementi costitutivi della condizione umana. Al contrario: gli uomini vogliono la felicità e la vita, quindi la pace. Il culto della bella guerra, della guerra igiene del mondo, è il prodotto di una cattiva cultura che privilegia un falso elemento estetico rispetto al sentimento morale. Fino a quando la sensibilità estetica resta nei confini di una poetica, trova una sua accettabile motivazione. Ma se ne esce, diventa istigazione alla violenza, alla sopraffazione e alla morte.
L´autore sostiene che l´ideale guerresco non sarà superabile fino a quando gli uomini non saranno in grado di creare un´altra più seducente bellezza, ma questa bellezza c´è già , affermano i suoi contraddittori, anzi c´è sempre stata ed è quella della pace. La lotta tra il bene della pace e il male della guerra.
Argomentata in questo modo la questione mi sembra malposta. Il problema non è infatti quello della scelta tra pace e guerra ma quello del potere.
Il potere è certamente un elemento costitutivo della condizione umana, anzi dell´intero orbe vivente. Perfino gli alberi si disputano la luce del sole e il più robusto toglie spazio e aria al vicino che intisichisce e declina.
Così gli animali di ogni specie difendono il loro territorio a prezzo della vita e sono di volta in volta cacciatori o prede nell´incessante lotta per il cibo; quando vivono in branco disputano per il comando ed è il più forte ad assumerlo. E così, in modi ancora più intensi e sofisticati, accade anche nella nostra specie dove la lotta per il potere assume forme spesso indirette e sublimate perché noi, a differenza delle altre forme di vita, conosciamo la nostra condizione mortale e aspiriamo al potere per esorcizzare la morte o per rinviarne gli effetti attraverso la conquista della gloria affidata al ricordo della posterità .
La guerra procaccia potere e gloria. La battaglia attorno alle porte Scee tramanda gli eroi attraverso i millenni. Ma il bambino che ancora nulla sa né di gloria né di memoria e neppure di morte sa però fin dai suoi primi mesi di vita che deve conquistare un suo territorio e lotta per questo giorno dopo giorno difendendo con grida e lacrime il suo giocattolo e impadronendosi se può del giocattolo altrui. Se poi è di sesso maschile impara rapidamente il gioco della guerra e ne fa il suo impegno principale e quasi la sua vocazione.
È bello il potere?
Fate attenzione: la pace ha una sua bellezza e anche la guerra può esprimere paradossalmente una dimensione estetica del “beau geste” e infatuare di sé. Ma il potere è impermeabile sia all´estetica che all’etica. Ha una sua dimensione autonoma e necessaria. L´opposto del potere non è l´impotenza poiché nessun essere vivente aspira all’impotenza. L´opposto del potere è la solitudine.
Un’altra bellezza
Personalmente credo che si debba e si possa costruire un´altra bellezza ed è quella della conoscenza di sé e dell´amore per gli altri.
Avevo detto prima di Ulisse rivisitato da Dante. L´Ulisse dantesco ha certamente potere, è un navarca e guida i suoi compagni. Ma dove li guida? Non verso la guerra che ha lasciato da tempo alle sue spalle. Li guida verso un viaggio misterico e iniziatico. “Considerate la vostra semenza / fatti non foste a viver come bruti / ma per seguir virtute e conoscenza”.
Non è forse questa la nuova bellezza con la quale vincere i fantasmi dell’orrore e i cavalieri dell´apocalisse portatori di morte e di distruzione?
(in “la Repubblica”, 13 ottobre 2004)
Rassegna stampa
“Voci asciutte, evocazioni d’immagini, senza caricare i toni. Malgrado parli emozionalmente e ostinatamente di guerra, quantunque sia una storia antica e vertiginosa di battaglie, e per quanto sia l’esaltazione più memorabile di virtù guerriere e di estetiche mortali, l’Iliade, ideata riscritta e diretta in forma di reading da Alessandro Baricco, sarà soprattutto un viaggio nella tradizione orale, un concerto contemporaneo sul tema strabiliante della memoria, un monumento fluido e assertivo all’arte popolare (e intensa, fanatica, umana, anche misteriosa) del racconto”.
(Rodolfo di Giammarco, Un viaggio nella memoria parlando della guerra, la Repubblica, 21 settembre 2004)
“Il senso dell’Iliade di Alessandro Baricco vive di un pubblico di oltre duemila spettatori a sera sospinti dal flusso di storie minime e immense, affetti quotidiani e mastodontiche battaglie; catturati dalla grazia di Criseide rapita da Agamennone, dal vagare di Elena nel ricordo del suo primo amplesso con Paride, dal pianto di Andromaca che teme per la vita di Ettore narrato dalla nutrice di suo figlio; travolti dalle feroci mattanze dei duelli, frecce che lacerano le carni, sangue che inonda la terra, punte che tagliano la lingua ed escono dal collo; presi dalla malia di immagini restituite soltanto dalle parole e proprio per questo ancora più possenti – perché l’Iliade che ci riguarda tutti, nel profondo e da sempre, sembra sfidare ogni contenimento nello spessore della forma e chiedere di essere detta più che rappresentata […]. La parola attraversa i volti, mette a nudo gli sguardi, a tratti li commuove, riversa su di noi la loro commozione”.
(Leonetta Bentivoglio, Iliade, orrori di guerra nel fascino delle parole, la Repubblica, 26 settembre 2004)
“Nel lavoro di Baricco diventa centrale il pubblico, esso è continuamente chiamato in causa continuamente sollecitato. Lo stile di Baricco scaturisce da un’antica alchimia: l’umiltà maschera la faccia tosta, la sfrontatezza smaschera la condiscendenza. Egli dà del tu a tutti: a Omero al suo pubblico; la seconda persona, singolare o plurale, nel suo discorso è sovrana. Questo stile demagogico è lo stile del nostro tempo. Esso si modella con docilità , sull’enorme pubblico che in silenzio assorbe un racconto interminabile e che, come il narratore ha auspicato, regredisce all’infanzia”.
(Franco Cordelli, Il demagogo Baricco dà del tu a Omero, Corriere della sera, 6 ottobre 2004)
“Il fulcro della narrazione è un unico personaggio, Achille… buco nero, energia vitale, forza allo stato puro…è Achille il centro focale di ogni sentimento, è lui la vita… la salvezza, la gloria
Non deve sembrare strano se per questo stesso personaggio Baricco abbia scelto una interprete femminile; la sua scelta, come egli stesso spiega , si fonda sulla ricerca di una vivacità interiore che non necessariamente deve appartenere a un uomo, i suoi occhi sono la manifesta espressione della rabbia di un uomo ferito nel suo orgoglio, nulla potranno le preghiere di grandi uomini per riportarlo sul campo di battaglia, né la stima di Patroclo né l’amore del vecchio Fenice.
Una lotta di sentimenti contrastanti piuttosto che di Achei contro Troiani, una lotta per la vita “che esce dalla gola e non ritorna più”. Non manca un riferimento alla guerra come evento attuale, parole semplici per esprimere un profondo rammarico per chi, nella vita, non riesce a coglierne l’essenza, non gode delle semplici cose quotidiane […] un appello all’uomo e alla sua fantasia […] a quella sua operosità che è il frutto della vita e può aiutare a migliorare se stessi e gli altri con piccoli gesti”.
(Monica Mastroianni, Dopo l’indegno Troy trionfa l’Iliade di Baricco, Vespertilla , ottobre 2004)
Progetto musicale Giovanni Sollima
Disegno Gianluigi Toccafondo
Disegno luci Guido Levi
Regia video Paolo Gazzara
Direttore tecnico Luigi Grenna
Suono Alessandro Borgioni
Ideazione costumi Marina Schindler
Con Alessandro Baricco e (in alternanza nei tre reading) Stefano Benni, Caterina Deregibus, Michele Di Mauro, Mariella Fabbris, Pierfrancesco Favino, Carolina Felline, Simone Gandolfo, Elio Germano, Edoardo Nesi, Fabrizia Sacchi, Sandro Veronesi.
Canto Rosie Wiederkehr
Coordinatore del progetto Fabrizio Grifasi
Assistente di produzione Francesca Manica
Direttore di palcoscenico Daniele Iraci
Datore luci Danilo Facco
Fonico Stefano Barbagallo
Sarti Santo Costanzo, Elena Pennello, Teresa Tamara Ventrice
Assistenti Corinna Bottiglieri, Marinella Contenti, Rebecca Raponi
Produzione Romaeuropa Festival 2004